|
Editoriale
IV Novembre 2008
Tornando a parlare di fascismo: libro e moschetto
Gelmini e La Russa, il balilla perfetto
Oggi pure i ciechi vedono che la dittatura è l'esito di una cattiva democrazia, mentre la democrazia è l'esito di una cattiva dittatura.
(Giuseppe Marotta, Visti e perduti, Bompiani, Milano 1960)
L'Italia è dalla Prima guerra mondiale per un 70 per cento fascista e ha in quel frangente instaurato un patto scellerato tra potere e "particolare" singolo dei sudditi, che si riconoscono in tutto nel loro rappresentante-fantoccio - compresa la triviale e annosa ignoranza, sospettosa di tutto quanto sia riconducibile a "cultura", coltivata attraverso l'offerta scolastica - uguale a loro, da allora in poi si sono avvicendati al potere dei capetti senza mai cambiare la pochezza intellettuale dei diversi pupazzi, automaticamente ribaltata sui sudditi a perpetuare un sistema di potere provinciale e stolto, e solo la levatura morale e soprattutto intellettuale del resto degli italiani, la minoranza (realmente europei al confronto di questi servi della gleba), ha imbrigliato in parte, finché c'erano ancora partigiani in vita, le pulsioni razziste, autoritarie, guerrafondaie della maggioranza del paese.
Un altro elemento si inserisce in queste amare considerazioni come premessa: era la logica conseguenza del nazionalismo imperante ai tempi del colera... collocare un fascista doc al ministero della difesa non poteva che produrre retorica, spese inutili e... propaganda, soprattutto a ridosso del IV novembre, storica data, caricata di retorica bellicista per coprire il sangue versato anche in modo feroce, sparando ai soldati che si ribellavano, che pose temporaneamente fine a un massacro, preludio di altre e più sanguinose stragi. Ecco, in fondo quella guerra ottenne a posteriori un racconto di prima mano diffuso, sia sotto forma di romanzi, sia nelle innumerevoli trasposizioni cinematografiche (anche lucide come La grande guerra, Monicelli 1959); e quasi sempre le connotazioni comuni erano molte e identificavano temi tipici di quella guerra, facilmente riconoscibili (ma non per questo immediatamente veritiere).
Questa considerazione in genere ci ha sempre condotti a pensare che sia difficile ottenere una plausibile documentazione di quella carneficina, ma le rappresentazioni delle guerre odierne ci stanno dimostrando che avvenne per quella strage di proletari di novant'anni fa, come per tutte le altre che poi si sono succedute, quale che fosse l'attributo: mondiali, coloniali, di razzia di fonti energetiche o umanitarie.
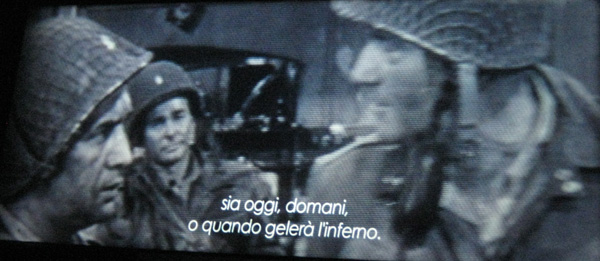 Ecco, esiste un gap tra le guerre di cui è rimasta traccia di una qualunque coscienza (magari emersa in momenti successivi: per la Prima guerra mondiale anche molto successivi come le operazioni di Gianikian e Ricci Lucchi) al contrario di questa Usa/mediorientale: dove tutto sembra embedded... a meno di essere Bigelow o De Palma. La guerra in Vietnam ebbe molte immagini in diretta non controllate e che andavano contro il comune senso di civiltà; quelle della Seconda guerra mondiale, fino a Clint Eastwood, seguivano un certo grado di retorica fondato su alcuni luoghi comuni che collocano quel periodo persino in un ambito quasi fiabesco.
Ecco, esiste un gap tra le guerre di cui è rimasta traccia di una qualunque coscienza (magari emersa in momenti successivi: per la Prima guerra mondiale anche molto successivi come le operazioni di Gianikian e Ricci Lucchi) al contrario di questa Usa/mediorientale: dove tutto sembra embedded... a meno di essere Bigelow o De Palma. La guerra in Vietnam ebbe molte immagini in diretta non controllate e che andavano contro il comune senso di civiltà; quelle della Seconda guerra mondiale, fino a Clint Eastwood, seguivano un certo grado di retorica fondato su alcuni luoghi comuni che collocano quel periodo persino in un ambito quasi fiabesco.
Sullo stesso conflitto di Iwo Jima Spike Lee ha fabbricato un film che non può tenere conto del dato di fatto che gli italiani siano propensi all'autoritarismo (neanche palese agli italiani stessi, figuriamoci a un afroamericano che ha intrattenuto soltanto rapporti con italiani stereotipati da Little Italy, come si vede nei suoi film precedenti - o al massimo gli hanno fatto incontrare Pansa), così si è fatto trascinare da un testo americano di James McBride, squilibrato e privo di analisi relative alla realtà italiana, che rimane volta per volta luogo fiabesco, ricettacolo di passioni incomprensibili, stantia sentina di retaggi immobilizzanti, patria di sordidi traditori, un po' levantini e un po' ignoranti: non vogliamo negare tutto ciò, anzi... visti i sondaggi che escono dopo sei mesi di orrori berlusconiani, piuttosto ci sembra decisamente riduttivo. Quella Italia mal descritta e fuorviata dal romanzo però era attraversata da un conflitto che non si vede mai, l'unico che interessa al regista è quello che impegna i fratelli neri, inviati qui allora, come ora sono carne da cannone là: quando sono civili italiani, partigiani toscani, donne del paesino, allora viene meno la lucidità e prende piede la fiaba o il racconto retorico, fatto di didascalismo e sentimentalismi, figure stereotipate (colpevolmente anche i fratelli neri si dispongono a rappresentare tutte le tipologie di afroamericani); curioso che diventi poco convincente quando i singoli personaggi cominciano ad assumere una dimensione a tutto tondo... e questo capita perché attinge da stereotipi che non sono nelle sue corde: l'ufficiale bianco pavido e razzista viene di peso dai film sulla Guerra di secessione, le azioni possono cercare di ricordare visioni raffazzonate e mal digerite di Paisà, il riferimento esplicito del film di John Wayne all'inizio dovrebbe metterci sull'avviso di quale sia l'universo a cui Spike attinge... ben diverso dall'uso del patrimonio di immagini "false" fabbricate da De Palma in Redacted, o, ancora meglio, quell'ambiguità dell'immagine documentaria di Simona Torretta alternata alla fiction della madre bendata nella casa con il marine che le ha ucciso il figlio, adottata da Arcopinto nel suo Angeli distratti. Ma non è tanto questo che ci interessa dirimere ora in questo film sconclusionato che a un inizio tombarolo alla Indiana Jones e la testa etrusca fa seguire un finale insensato, idillico e improbabile, fuori da ogni registro precedentemente adottato nel film.
 Non interessa un film sbagliato, ma il fatto che Spike Lee sia incorso nell'errore tipico dei registi che si sono occupati di guerra e che non si chiamano Fuller o Bigelow (o De Palma, per citare un italoamericano, di quelli che per il regista di Fa' la cosa giusta, incarnano tutto quello che può esserci di infido): la retorica va bene se è avvolta nel drappo del bianco e nero di Renoir o nei gloriosi Orizzonti kubrickiani (che però poi spostatosi in Vietnam l'ha estirpata completamente, preferendo filologicametne l'inno dei marines: Mickey Mouse), quando si vede il corpo della recluta che galleggia attorno al suo elmetto nel fiume epicamente ammantato di rosso, non viene l'indignazione contro il sistema guerrafondaio, ma contro il regista ancora fermo a questi mezzucci parapoetici, quando contemporaneamente Bigelow toglie ogni aura attraverso la vivisezione di ogni umore stillato da quei professionisti della prassi bellica. I personaggi di Lee sembrano sempre in posa, sia che stiano morendo su un sagrato da soli, ciccioni come Palladineve di Full Metal Jacket, oppure stiano per essere falciati in una mal ricostruita strage autentica e a tal punto ferita aperta nella storia italiana da rimanere sigillata per decenni in un armadio della vergogna e che non può venire ridicolizzata così, solo per consentire a un regista digiuno di storia contemporanea - come quasi tutti i suoi connazionali (la cui scuola viene presa a esempio per privatizzare la nostra) - di scempiarla nell'intento di onorare truppe afroamericane, inviate su tutti i fronti di guerra, dimenticando che anche per loro esiste l'obiezione di coscienza, il rifiuto delle gerarchie, l'orrore per l'uso delle armi... e che Colin Powell, quello che sventolando una provetta assolutamente falsa ha provocato milioni di morti iracheni, è un nero. Non interessa un film sbagliato, ma il fatto che Spike Lee sia incorso nell'errore tipico dei registi che si sono occupati di guerra e che non si chiamano Fuller o Bigelow (o De Palma, per citare un italoamericano, di quelli che per il regista di Fa' la cosa giusta, incarnano tutto quello che può esserci di infido): la retorica va bene se è avvolta nel drappo del bianco e nero di Renoir o nei gloriosi Orizzonti kubrickiani (che però poi spostatosi in Vietnam l'ha estirpata completamente, preferendo filologicametne l'inno dei marines: Mickey Mouse), quando si vede il corpo della recluta che galleggia attorno al suo elmetto nel fiume epicamente ammantato di rosso, non viene l'indignazione contro il sistema guerrafondaio, ma contro il regista ancora fermo a questi mezzucci parapoetici, quando contemporaneamente Bigelow toglie ogni aura attraverso la vivisezione di ogni umore stillato da quei professionisti della prassi bellica. I personaggi di Lee sembrano sempre in posa, sia che stiano morendo su un sagrato da soli, ciccioni come Palladineve di Full Metal Jacket, oppure stiano per essere falciati in una mal ricostruita strage autentica e a tal punto ferita aperta nella storia italiana da rimanere sigillata per decenni in un armadio della vergogna e che non può venire ridicolizzata così, solo per consentire a un regista digiuno di storia contemporanea - come quasi tutti i suoi connazionali (la cui scuola viene presa a esempio per privatizzare la nostra) - di scempiarla nell'intento di onorare truppe afroamericane, inviate su tutti i fronti di guerra, dimenticando che anche per loro esiste l'obiezione di coscienza, il rifiuto delle gerarchie, l'orrore per l'uso delle armi... e che Colin Powell, quello che sventolando una provetta assolutamente falsa ha provocato milioni di morti iracheni, è un nero.
 Sembra fuorviante, ma è questo il punto: il suo intento è di creare una bella fiaba in cui riconoscersi e questo gli fa adottare il registro che i bianchi usano per esaltare i propri eroi di guerra, solo inserendo protagonisti afroamericani, ma edulcorando quanto di matericamente repulsivo ci può essere nella guerra; quello stesso spunto che invece riesce a Bigelow di superare, perché a lei interessa la sfida (fin da Point Break)... il suo protagonista è ammalato di adrenalina, ma stavolta non lo è in modo libertario, individualista sempre, ma non è più la disfida giovane, manca persino il deuteragonista: c'è solo lui e il bisogno di misurarsi con quel pericolo sempre diverso e che lo mette a dura prova... In The Hurt Locker alle leggi della natura, alle onde dell'Oceano, si sostituisce il bisogno di superare lo squallore seducente del delirio di sudore e polvere e sangue e esplosivi e contatti a distanza con la popolazione ostile: gli iracheni sono sempre distanti, indistinti e ostili, figurine mai connotate: la macro è per loro, i professionisti della guerra, gli artificeri che non hanno nulla di eroico, anzi nascosti nella tuta perdono anche l'identità. E la vita, se sono gente qualunque, mentre se invasati dal sacro fuoco dell'irrequietudine si isolano, diventano problematici personaggi drogati di adrenalina da assumere sotto forma di esplosivi, mirini, sangue, polvere, sudore... affetto per un unico ragazzino, che addirittura non si riconosce essere altro dalla vittima che si ha sotto gli occhi, tanto si è distratti quando si tratta dell'altro da sé, appunto la stessa distrazione che Spike Lee ha nei confronti della nostra storia... delle storie di personaggi che per lui sono lo stereotipo del guerrigliero e per noi sono gli unici che nella nostra storia si sono ribellati e liberati alla faccia di quel 70 per cento del Paese da cui eravamo partiti e che è sempre stato attratto dalla deriva fascista ben esemplificata dal mercenario che va a farsi ammazzare lasciando il suo folle e invasato epitaffio - "Ora vi faccio vedere come muore un italiano" - come se non fossero passati decenni di ribellioni libertarie da Enrico Toti in avanti (pericolosamente eversivo e intriso di quella cultura che ha prodotto i germi del berlusconismo, sempre evocato con la sua inquietante stampella dai sussidiari scolastici della lunga scia Bottai-Misasi-Gelmini: non è Silvio che si è incistato nel tessuto connettivo di una società prima sana, imponendosi, ma semplicemente ha sempre avuto in sé, lui e i suoi accoliti, l'imprinting fascio e l'intuizione che il ventre molle della nazione è come lui) anche quando quel popolo di inetti, bisognosi di un capo, affidava il suo voto al Pci di Berlinguer - un partito che ha sempre preferito negarsi che la maggioranza del paese ha da sempre nostalgia di autoritarismo, lasciandosi abbindolare dal delirio securitario, meglio se intriso di un razzismo che forse è eredità di tutte le conquiste subite da parte dello straniero, magari austriacante (quando non incarna invece furbescamente la versione pavida "Franza o Spagna purché se magna", ribaltando abilmente l'invasore e l'invaso, lo sfruttatore e lo sfruttato). Sembra fuorviante, ma è questo il punto: il suo intento è di creare una bella fiaba in cui riconoscersi e questo gli fa adottare il registro che i bianchi usano per esaltare i propri eroi di guerra, solo inserendo protagonisti afroamericani, ma edulcorando quanto di matericamente repulsivo ci può essere nella guerra; quello stesso spunto che invece riesce a Bigelow di superare, perché a lei interessa la sfida (fin da Point Break)... il suo protagonista è ammalato di adrenalina, ma stavolta non lo è in modo libertario, individualista sempre, ma non è più la disfida giovane, manca persino il deuteragonista: c'è solo lui e il bisogno di misurarsi con quel pericolo sempre diverso e che lo mette a dura prova... In The Hurt Locker alle leggi della natura, alle onde dell'Oceano, si sostituisce il bisogno di superare lo squallore seducente del delirio di sudore e polvere e sangue e esplosivi e contatti a distanza con la popolazione ostile: gli iracheni sono sempre distanti, indistinti e ostili, figurine mai connotate: la macro è per loro, i professionisti della guerra, gli artificeri che non hanno nulla di eroico, anzi nascosti nella tuta perdono anche l'identità. E la vita, se sono gente qualunque, mentre se invasati dal sacro fuoco dell'irrequietudine si isolano, diventano problematici personaggi drogati di adrenalina da assumere sotto forma di esplosivi, mirini, sangue, polvere, sudore... affetto per un unico ragazzino, che addirittura non si riconosce essere altro dalla vittima che si ha sotto gli occhi, tanto si è distratti quando si tratta dell'altro da sé, appunto la stessa distrazione che Spike Lee ha nei confronti della nostra storia... delle storie di personaggi che per lui sono lo stereotipo del guerrigliero e per noi sono gli unici che nella nostra storia si sono ribellati e liberati alla faccia di quel 70 per cento del Paese da cui eravamo partiti e che è sempre stato attratto dalla deriva fascista ben esemplificata dal mercenario che va a farsi ammazzare lasciando il suo folle e invasato epitaffio - "Ora vi faccio vedere come muore un italiano" - come se non fossero passati decenni di ribellioni libertarie da Enrico Toti in avanti (pericolosamente eversivo e intriso di quella cultura che ha prodotto i germi del berlusconismo, sempre evocato con la sua inquietante stampella dai sussidiari scolastici della lunga scia Bottai-Misasi-Gelmini: non è Silvio che si è incistato nel tessuto connettivo di una società prima sana, imponendosi, ma semplicemente ha sempre avuto in sé, lui e i suoi accoliti, l'imprinting fascio e l'intuizione che il ventre molle della nazione è come lui) anche quando quel popolo di inetti, bisognosi di un capo, affidava il suo voto al Pci di Berlinguer - un partito che ha sempre preferito negarsi che la maggioranza del paese ha da sempre nostalgia di autoritarismo, lasciandosi abbindolare dal delirio securitario, meglio se intriso di un razzismo che forse è eredità di tutte le conquiste subite da parte dello straniero, magari austriacante (quando non incarna invece furbescamente la versione pavida "Franza o Spagna purché se magna", ribaltando abilmente l'invasore e l'invaso, lo sfruttatore e lo sfruttato).
 Quelli che hanno condotto la Resistenza erano una strenua minoranza di cresciuti - anche per appartenenza anagrafica - nel vero antifascismo (i Poma, cresciuto nella Guerra civile spagnola per capirci e nelle aziende tessili biellesi; i Parodi, nato nelle fabbriche torinesi del Biennio rosso e cresciuto nella formazione dei quadri dell'Urss, per fare due nomi di operai rivoluzionari armati; i Foa e le Cederna per parlare di intellettuali), gli altri, quelli troppo giovani per avere conosciuto le lotte precedenti il Ventidue - anche se convinti partigia - erano cresciuti nei sabati fasci e nella scuola del consenso che Gelmini e soci vorrebbero riesumare, così avevano aperto gli occhi soltanto nella ritirata di Russia (per esempio Lajolo, per esempio Revelli padre, lo stesso Fenoglio, addirittura un Rigoni Stern che poi invece ha sviluppato una visione lucidamente antifascista, cominciano a prendere coscienza da lì, dalla guerra in cui erano stati gettati insensatamente), erano gente che non attingeva a quella cultura e a quella tradizione interrotta e spezzata dalla rivoluzione fascista, perché era un'altra visione, un altro approccio (censurato e non popolare, inarrivabile a chi non aveva quella formazione: di nuovo, rievocando quei tempi, siamo posti di fronte all'intreccio tra diritto universale alla cultura e resistenza del potere per meglio controllare i sudditi)... la stragrande maggioranza era stata educata al fascismo dal fascismo e il loro antifascismo era una reazione, alla leva e alla guerra patita, una ribellione all'autoritarismo e alla incultura, allo sberleffo incolto e caciarone a cui contrapponevano la ragione e il fastidio, ma non era radicato realmente nel loro intimo e soprattutto nella loro testa (la differenza tra Pertini e Napolitano al di là dell'insipienza di questo borghese migliorista infrattato e mai stato ribelle, anzi sempre pronto a patteggiare con chi detiene il potere autocratico: sia esso Breznev o Berlusconi)... non capivano la pericolosità autentica anche dopo la sua sconfitta capitata il Venticinque Aprile, pensavano che quell'orrore inventato in Italia fosse un episodio pericoloso, magari ripetibile, ma privo di radici ideologiche, al punto che passò l'amnistia togliattiana, in fondo quella ignobile idea di Violante dei ragazzi di Salò nasceva già lì, in quel sostanziale riconoscere generazionalmente che, in fondo, a loro era andata ancora bene aver riconosciuto lo sconcio di quel regime, che non era da operetta e che però faceva tanto comodo considerare tale, perché significava salvaguardare l'unione nazionale e addirittura tesserare per il Pci quelli che erano stati fasci fino a poco prima (pure Spike Lee nel suo orrido film, senza capire cosa sta dicendo, riconosce il trasformismo nazionale)... ma perché erano zona grigia o qualunquisti - come dice Santomassimo nel suo articolo, riportato qui sotto -, o comunque fastidiati dagli eccessi, senza per questo riconoscere la pericolosità dei germi che hanno continuato a rimanere vivi, più o meno nascosti (strategia della tensione, ma anche scontri degli anni Settanta, e prima ancora Tambroni e dopo Bolzaneto: ricordate la lucida iconografia dei fasci in orbace e fez e con le fattezze di topi nascosti nelle fogne che dai morti di Reggio Emilia in avanti connotavano la natura di picchiatori alla Alemanno in ogni vignetta lucidamente militante e che probabilmente ha ispirato la trista figura di Sutherland/Attila in Novecento di Bertolucci?), arrivando a conclamarsi ora in questo governo che è ovvia e "giusta" espressione delle peggiori turpitudini che attraversano le menti offuscate del 70 per cento dei nostri connazionali: cittadinanza a punti, bastonate ai negri, puttane in riga e donne ai fornelli, scuola classista e dotata di grembiulino e voto di condotta alla Bottai (Gentile era troppo progressista); sindacati da soffocare e corporativismo... paternalismo berlusconide, differenze di classe e impunità, asservimento al regime e veline totali (ci sono notizie su "El Pais" che non arrivano in nessun sito on line in lingua italiana...), ma ormai dire "veline" evoca ragazzine scosciate e non prassi di censura mediatica, un segnale di come cambia la percezione della lingua e quindi del pensiero. Quelli che hanno condotto la Resistenza erano una strenua minoranza di cresciuti - anche per appartenenza anagrafica - nel vero antifascismo (i Poma, cresciuto nella Guerra civile spagnola per capirci e nelle aziende tessili biellesi; i Parodi, nato nelle fabbriche torinesi del Biennio rosso e cresciuto nella formazione dei quadri dell'Urss, per fare due nomi di operai rivoluzionari armati; i Foa e le Cederna per parlare di intellettuali), gli altri, quelli troppo giovani per avere conosciuto le lotte precedenti il Ventidue - anche se convinti partigia - erano cresciuti nei sabati fasci e nella scuola del consenso che Gelmini e soci vorrebbero riesumare, così avevano aperto gli occhi soltanto nella ritirata di Russia (per esempio Lajolo, per esempio Revelli padre, lo stesso Fenoglio, addirittura un Rigoni Stern che poi invece ha sviluppato una visione lucidamente antifascista, cominciano a prendere coscienza da lì, dalla guerra in cui erano stati gettati insensatamente), erano gente che non attingeva a quella cultura e a quella tradizione interrotta e spezzata dalla rivoluzione fascista, perché era un'altra visione, un altro approccio (censurato e non popolare, inarrivabile a chi non aveva quella formazione: di nuovo, rievocando quei tempi, siamo posti di fronte all'intreccio tra diritto universale alla cultura e resistenza del potere per meglio controllare i sudditi)... la stragrande maggioranza era stata educata al fascismo dal fascismo e il loro antifascismo era una reazione, alla leva e alla guerra patita, una ribellione all'autoritarismo e alla incultura, allo sberleffo incolto e caciarone a cui contrapponevano la ragione e il fastidio, ma non era radicato realmente nel loro intimo e soprattutto nella loro testa (la differenza tra Pertini e Napolitano al di là dell'insipienza di questo borghese migliorista infrattato e mai stato ribelle, anzi sempre pronto a patteggiare con chi detiene il potere autocratico: sia esso Breznev o Berlusconi)... non capivano la pericolosità autentica anche dopo la sua sconfitta capitata il Venticinque Aprile, pensavano che quell'orrore inventato in Italia fosse un episodio pericoloso, magari ripetibile, ma privo di radici ideologiche, al punto che passò l'amnistia togliattiana, in fondo quella ignobile idea di Violante dei ragazzi di Salò nasceva già lì, in quel sostanziale riconoscere generazionalmente che, in fondo, a loro era andata ancora bene aver riconosciuto lo sconcio di quel regime, che non era da operetta e che però faceva tanto comodo considerare tale, perché significava salvaguardare l'unione nazionale e addirittura tesserare per il Pci quelli che erano stati fasci fino a poco prima (pure Spike Lee nel suo orrido film, senza capire cosa sta dicendo, riconosce il trasformismo nazionale)... ma perché erano zona grigia o qualunquisti - come dice Santomassimo nel suo articolo, riportato qui sotto -, o comunque fastidiati dagli eccessi, senza per questo riconoscere la pericolosità dei germi che hanno continuato a rimanere vivi, più o meno nascosti (strategia della tensione, ma anche scontri degli anni Settanta, e prima ancora Tambroni e dopo Bolzaneto: ricordate la lucida iconografia dei fasci in orbace e fez e con le fattezze di topi nascosti nelle fogne che dai morti di Reggio Emilia in avanti connotavano la natura di picchiatori alla Alemanno in ogni vignetta lucidamente militante e che probabilmente ha ispirato la trista figura di Sutherland/Attila in Novecento di Bertolucci?), arrivando a conclamarsi ora in questo governo che è ovvia e "giusta" espressione delle peggiori turpitudini che attraversano le menti offuscate del 70 per cento dei nostri connazionali: cittadinanza a punti, bastonate ai negri, puttane in riga e donne ai fornelli, scuola classista e dotata di grembiulino e voto di condotta alla Bottai (Gentile era troppo progressista); sindacati da soffocare e corporativismo... paternalismo berlusconide, differenze di classe e impunità, asservimento al regime e veline totali (ci sono notizie su "El Pais" che non arrivano in nessun sito on line in lingua italiana...), ma ormai dire "veline" evoca ragazzine scosciate e non prassi di censura mediatica, un segnale di come cambia la percezione della lingua e quindi del pensiero.
 Spike Lee non si accorge che calpesta la dignità antifascista di una minoranza di antifascisti, ma non si accorge neppure che anche i suoi fratelli neri sono: uno zio Tom, un tipico mandingo sempre solo interessato alla figa, un minorato pieno di buoni sentimenti... insomma il repertorio; almeno De Palma quando mette in scena il suo di repertorio, lo fa avendo a disposizione autentici mostri della più retriva conservazione, adagiati su una bandiera secessionista... Spike Lee non si accorge che calpesta la dignità antifascista di una minoranza di antifascisti, ma non si accorge neppure che anche i suoi fratelli neri sono: uno zio Tom, un tipico mandingo sempre solo interessato alla figa, un minorato pieno di buoni sentimenti... insomma il repertorio; almeno De Palma quando mette in scena il suo di repertorio, lo fa avendo a disposizione autentici mostri della più retriva conservazione, adagiati su una bandiera secessionista...
Bastano pochi elementi, scarne idee di base per connotare le guerre del nuovo millennio: tutte fondate su immagini "personali": le torture di Abu Ghraib nella realtà (quelle che diventano componente essenziale dell'essere umano nel documentario di Errol Morris, Standard Operating Procedure), le notizie al padre Nella Valle di Elah nella fiction si fondano su tecnologie personali... al di là di sceneggiature e intrecci più o meno nazionalisti fondati su posizioni di bandiere rispetto all'asta o su bisogni di soldi per mantenersi all'università (privata, ovviamente,come la sanità) tutto si fonda su pessime immagini che rilasciano verità scomode, interpretabili e che mai restituiscono davvero la realtà a tutto tondo - che diventa scherzo tragico e scherno in Redacted quando il portoricano riprende il proprio rapimento, scomparendo con i suoi rapitori fino alla sua decapitazione, recitata come da copione web.
In Haggis addirittura non si vede mai chiaramente il volto del protagonista che diventa così potentissimo "in assenza" smaterializzato dai video realizzati col cellulare da cui il padre cerca di ricostruire la vicenda e dalla droga di cui abusa, non adrenalina ma droga vera a cui è essenziale affidarsi per tollerare l'orrore della guerra. E non c'è traccia di patriottismo nelle azioni e nelle scelte dei protagonisti (manca in Bigelow totalmente, è frustrato fino all'annullamento in Haggis), non è quel patriottismo a cui inneggia Bush nei suoi discorsi alla nazione che spinge a partire, quello per cui è giusto agli occhi di quella stessa nazione che esista Abu Ghraib per tutelare l'integrità delle famiglie americane dal terrorismo (le stesse che vengono dimezzate dalla guerra, qualsiasi guerra, in nome di quei principi, famiglie che così si autoassolvono per le proprie scelte politiche e interventiste). Questo è quanto avviene in Body of War di Phil Donahue e Ellen Spiro su Thomas Young, un giovane inchiodato sulla sedia a rotelle nei primi giorni del suo arrivo in Iraq, la sua storia viene raccontata senza infingimenti, ogni suo malessere, tutte le sue sindromi, financo la vita privata (compreso il fallimento del suo matrimonio, prevedibile) sono vivisezionati per dimostrare quanto un episodio di guerra, persino non mortale, incida nella carne viva di un'intera famiglia, oltretutto guerrafondaia: basti assistere alle reazioni del padre o del fratello, invasati di bushismo; le figure femminili si discostano molto da Sarah Palin, invece, come per tutte le storie americane (da Il Cacciatore in avanti: non si sanno dar pace e cercano di entrare nella mente giustamente ossessionata, nelle ferite dell'anima del loro caro. Senza risultati migliori di Coming Home per i reduci del Vietnam o del geniale testo della vittima del maccartismo (quello vero e non quello da operetta berlusconiano) Douglas Trumbo: E Johnny prese il fucile. In entrambi i vecchi film c'era il compiaciuto soffermarsi sulla disabilità, la ferocia dell'amputazione, qui la disabilità è perlustrata centimetro per centimetro ed è quella che diventa chilometri di pellicola e di strade percorse in funzione antiBush. Solo che a tratti diventa forse pelosa, a tratti invece sembra talmente intima e individuale, a dispetto dell'esibizione quasi oscena, che diventa impossibile estenderla a tutte le singole storie di poveri reduci. E di nuovo il tratto che differenzia il discorso retorico del passato da quelli che caratterizzano le immagini che appaiono significative si trova nel maniacale dettaglio sul lavoro professionale, sulle ferite e sulla menomazione a tutto schermo... fin qui il ruolo delle donne rimane quello delle crocerossine di Hemingway, non quello delle staffette (anche di Stazzema, ma a Valentina Cervi viene riservato il solito ruolo di corpo desiderato e non desiderante, come quello partigiano, di donne e uomini partigiani) italiane o le eroiche algerine contro i francesi... o le protagoniste di Flame.

Non esiste un'ermeneutica unica di questa guerra, ma solo il suo molteplice uso fatto da singole persone che la adoperano per fini personali (in The Hurt Locker la scarsa connotazione locale è tale che si potrebbe essere ovunque, Afganistan, Iraq), un po' come gli italiani hanno imparato a fare dalla Prima guerra mondiale che ha sviluppato i germi del fascismo: usare le contraddizioni del potere per tirare avanti senza morale.
 La differenza che fanno ingegni come quello di Bigelow e De Palma sta nel fatto che non sono vacui pacifisti sognanti e facilmente vilipesi e scherniti; a loro interessa l'odore della morte che non viene neanche percepita come tale: è solo un disagio in mezzo al resto della concitazione, del tran tran da trasfertista, lontano da casa, in mezzo a problemi da risolvere... quotidianità feroce... non c'è spazio nemmeno per la musica off, quei violini sinfonici esasperanti nel film di Spike Lee non esistono in The Hurt Locker... non potrebbero starci in un film in cui lo schermo è sempre pieno di oggetti, di forme che occupano i sensi, tutti tesi a svolgere il compito come un lavoro qualunque: l'unica musica è interna al set, sta in camera ed è un heavy metal (ma vi sembrerebbe possibile un'orchestra di violini tra i boschi di Stazzema nel 1944?!!?). La differenza che fanno ingegni come quello di Bigelow e De Palma sta nel fatto che non sono vacui pacifisti sognanti e facilmente vilipesi e scherniti; a loro interessa l'odore della morte che non viene neanche percepita come tale: è solo un disagio in mezzo al resto della concitazione, del tran tran da trasfertista, lontano da casa, in mezzo a problemi da risolvere... quotidianità feroce... non c'è spazio nemmeno per la musica off, quei violini sinfonici esasperanti nel film di Spike Lee non esistono in The Hurt Locker... non potrebbero starci in un film in cui lo schermo è sempre pieno di oggetti, di forme che occupano i sensi, tutti tesi a svolgere il compito come un lavoro qualunque: l'unica musica è interna al set, sta in camera ed è un heavy metal (ma vi sembrerebbe possibile un'orchestra di violini tra i boschi di Stazzema nel 1944?!!?).
E anche i video prodotti con i telefonini in Redacted restituiscono una quotidianità fatta di sudore che cola, checkpoint (una parola che subiscono soltanto popolazioni arabe come i palestinesi o persiane come gli afgani), noia e arroganza: una fetta di Usa trasposta dall'altra parte del mondo, presso popolazioni considerate inferiori da minus habens privi di scrupoli già a casa loro: quello che documenta De Palma attraverso falsi filmati, telefonini e interviste dirette in questa che è un'opera di fiction, è la banalità del male fatta pochezza ignoranza e disprezzo ("La prima vittima è la verità"): tutto si fonda in De Palma sul sistema delle bugie ("Tell me no lies" nell'esergo del film e poi: "Il video dice sempre bugie"; uno stato di costante diffidenza). Anche qui come in Spike i soldati sono stereotipati: bianchi da KKK e portoricano sveglio che vuol fare il filmino (e questo spiega quante immagini sull'Iraq ci sono, ma anche perché sono così tanto embedded), ma poi sarà rapito in una sequenza da comica con finale grandguignolesco; e anche qui ritorna l'ufficiale che salta sulla mina... un tropo che probabilmente in Bigelow come in De Palma vuol restituire il messaggio che non c'è professionalità o esperienza che possa salvare nessuno: semplicemente capita... Succede d'accordo, ma questa atrocità apparente si coglie in qualunque trama di guerra. In Bigelow in più si percepiscono i proiettili che bucano un corpo ma non il punto del deserto da cui è partito: l'insicurezza che è stata inculcata in patria, si moltiplica in trincea... e conduce al delirio di equiparare il primo mitico morto ucciso da se medesimi a un pesce eviscerato o teorizzare l'equiparazione tra i beduini e gli scarafaggi ("Non puoi permetterti rimorsi: diventi debole e così muori". Non troppo discosti dai messaggi spacciati da esponenti di Lega o altri fascisti in generale). Qui non interessa il buonismo della retorica dei fiori nei cannoni, quello che conta è mostrare quanto è materiale e percepibile l'innaturalità ridotta a normalità; l'atrocità con cui si convive facendola così diventare l'abitudine, di cui non si può più fare a meno, perché il mondo che propone è fondato su parametri diversi da quelli del supermercato della mogliettina in The Hurt Locker, parametri che diventano quelli veri, ponendo il dubbio su quale sia il pianeta su cui si fonda la realtà vera e quindi quali siano i fondamenti etici, le prassi corrette per un'umanità accettabile nel consesso mondiale; appunto l'assunto che De Palma propone all'inizio: solo se si capisce questo, si può capire il film che disloca il racconto in svariati testi ripresi con differenti supporti, perché così si va a creare un globalizzante luogo comune che spinge in un'unica direzione. Un universo di riferimenti in cui ogni tanto fa spicco qualche trama conosciuta e apparentemente innocua: citare Clerks diventa il cavallo di Troia: quei criminali, quegli assassini stupratori sono stati spettatori di un film come Clerks e lo hanno apprezzato; ma allora dove sta il momento che li ha resi alieni? Il disturbo della percezione della realtà si evidenzia nel film di Bigelow da quelle dissolvenze sonore incrociate in cui il sonoro non è anticipato, ma continua a persistere nella memoria degli attori il sonoro della sequenza precedente ancora in quella ormai sul piano visivo passata alla nuova situazione: è una condizione che per noi arreca un disagio, perché insolito, utile perché segnala proprio un disturbo della percezione, un ritardo rispetto alla repentinità degli altri sensi, condizionati anche dalla fattura degli attrezzi, dalle tute che rendono simili ad alieni, ma che impediscono anche i movimenti naturali e - come per le armature degli ufficiali di Un anno sull'altipiano di Lussu - spesso sono deleterie e ferali per chi le indossa pensando che siano salvifiche.
 Eppure c'è un'enorme differenza dai racconti di guerra dei Lussu (Prima guerra mondiale: la cui strage si festeggia oggi nei suoi novant'anni da Vittorio Veneto... uno degli episodi più sanguinosi per il proletariato mondiale) o dei Rigoni Stern o di Heller (Comma 22) nel Secondo massacro mondiale dell'era moderna, o S.M.A.S.H. (la prima guerra coloniale degli americani fuori del loro continente: Corea): ogni guerra ha una sua connotazione... queste mediorientali sono diverse ma i loro racconti ci offrono l'agio di capire come la attuale società è involuta e quali sono i suoi modi di raccontarsi: non ci si deve stupire, ci si può al limite indignare, ma non c'è nulla di strano: quei fenomeni raccontati da De Palma o Bigelow sono certamente disumani, ma sono lo specchio neanche troppo deformato della società creata dalla presa di potere di manigoldi cresciuti al di fuori della cultura antifascista come Reagan, Bush, Thatcher, Sharon, Aznar, Berlusconi, Putin, Sarkozy... in tutto eredi dell'ideologia militarista dell'inizio del secolo scorso. Eppure c'è un'enorme differenza dai racconti di guerra dei Lussu (Prima guerra mondiale: la cui strage si festeggia oggi nei suoi novant'anni da Vittorio Veneto... uno degli episodi più sanguinosi per il proletariato mondiale) o dei Rigoni Stern o di Heller (Comma 22) nel Secondo massacro mondiale dell'era moderna, o S.M.A.S.H. (la prima guerra coloniale degli americani fuori del loro continente: Corea): ogni guerra ha una sua connotazione... queste mediorientali sono diverse ma i loro racconti ci offrono l'agio di capire come la attuale società è involuta e quali sono i suoi modi di raccontarsi: non ci si deve stupire, ci si può al limite indignare, ma non c'è nulla di strano: quei fenomeni raccontati da De Palma o Bigelow sono certamente disumani, ma sono lo specchio neanche troppo deformato della società creata dalla presa di potere di manigoldi cresciuti al di fuori della cultura antifascista come Reagan, Bush, Thatcher, Sharon, Aznar, Berlusconi, Putin, Sarkozy... in tutto eredi dell'ideologia militarista dell'inizio del secolo scorso.
 Ecco, affrontare il fascismo di nuovo come hanno fatto quegli antifascisti che hanno preso coscienza di esserlo in guerra; difficile diffondere l'idea che siamo di nuovo - sotto diversi aspetti - di fronte a quella pericolosa forma di autoritarismo che avevano in testa i Gobetti, i Ginzburg, i Matteotti, i Rosselli... guarda caso quelli uccisi direttamente dai fascisti: gli altri hanno vinto, senza però rendersi conto che il fascismo rimaneva sotto traccia nella società e si espandeva gradualmente, trasformandosi e assumendo connotazioni insospettabili, incredibili solo pochi anni fa e che adesso si possono inserire su Youtube, come avviene nel film di Haggis, o come in quello di De Palma; un trasformismo tipicamente italico che ha fatto diventare molti pciisti dei Settanta, la base legaiola dei Novanta, perché in realtà erano quello: appartenevano alla zona grigia qualunquista o ben che andasse a quell'antifascismo che produceva canzoni con la medesima retorica e gli stessi tropi trucidi del fascismo, perché i pochi anni di scuola erano stati spesi nella educazione a immagine e somiglianza del Guf, che non è vero che era palestra di antifascismo in seno al regime. Al di là di schieramenti (anarchici, comunisti, credenti o radicali) sarebbe il caso di ricominciare a creare una rete di Resistenza, fondata sul carisma della ragione... riuscire a far percepire il pericolo dell'autoritarismo e trasmettere gli anticorpi, affinché non ci sia il rischio né di antifascisti qualunque, né di antifascisti benché intrisi della cultura fascista. Non so se si può fare riallacciandosi a quelle radici feconde di prima del fascismo, o se si dovrà inventare un approccio più adatto all'epoca, ma riconoscendo questa schiacciante maggioranza di potenziali fasci (che non sono quelli disposti a episodi di squardrismo al soldo del Kossiga di turno, come in piazza Navona sia il 29 ottobre 2008, sia il 12 maggio 1977 ), è indispensabile ricreare una serie di occasioni minimali per trasmettere ai giovani l'idea che può esistere un altro approccio al mondo, meno autoritario, monetaristico, liberista, razzista... guerrafondaio. Certo che non è la favoletta di Spike, piena di errori storici e di ingenuità politiche che può contrastare l'evocativa violenza insita nell'esaltante stupro con strage della famiglia irachena in Redacted, vittima destinale senza diritti (i cui diritti cominciano a venir meno là, quando si accetta il criterio "grigio" delle classi differenziali di Maroni-Gelmini qui) o l'adrenalina scatenata dal puntare la pistola a un automobilista, sparare su un guerrigliero di cui non vedi gli occhi a infinita distanza, o non riuscire a capire il motivo per cui tutti ti guardano in cagnesco quando vai in giro per le loro strade con tracotanza (esattamente lo stupore falso e idiota della Gelmini di fronte alle proteste: "Non capisco le proteste. Classi per stranieri? Non è razzismo; è didattica").
Ecco, affrontare il fascismo di nuovo come hanno fatto quegli antifascisti che hanno preso coscienza di esserlo in guerra; difficile diffondere l'idea che siamo di nuovo - sotto diversi aspetti - di fronte a quella pericolosa forma di autoritarismo che avevano in testa i Gobetti, i Ginzburg, i Matteotti, i Rosselli... guarda caso quelli uccisi direttamente dai fascisti: gli altri hanno vinto, senza però rendersi conto che il fascismo rimaneva sotto traccia nella società e si espandeva gradualmente, trasformandosi e assumendo connotazioni insospettabili, incredibili solo pochi anni fa e che adesso si possono inserire su Youtube, come avviene nel film di Haggis, o come in quello di De Palma; un trasformismo tipicamente italico che ha fatto diventare molti pciisti dei Settanta, la base legaiola dei Novanta, perché in realtà erano quello: appartenevano alla zona grigia qualunquista o ben che andasse a quell'antifascismo che produceva canzoni con la medesima retorica e gli stessi tropi trucidi del fascismo, perché i pochi anni di scuola erano stati spesi nella educazione a immagine e somiglianza del Guf, che non è vero che era palestra di antifascismo in seno al regime. Al di là di schieramenti (anarchici, comunisti, credenti o radicali) sarebbe il caso di ricominciare a creare una rete di Resistenza, fondata sul carisma della ragione... riuscire a far percepire il pericolo dell'autoritarismo e trasmettere gli anticorpi, affinché non ci sia il rischio né di antifascisti qualunque, né di antifascisti benché intrisi della cultura fascista. Non so se si può fare riallacciandosi a quelle radici feconde di prima del fascismo, o se si dovrà inventare un approccio più adatto all'epoca, ma riconoscendo questa schiacciante maggioranza di potenziali fasci (che non sono quelli disposti a episodi di squardrismo al soldo del Kossiga di turno, come in piazza Navona sia il 29 ottobre 2008, sia il 12 maggio 1977 ), è indispensabile ricreare una serie di occasioni minimali per trasmettere ai giovani l'idea che può esistere un altro approccio al mondo, meno autoritario, monetaristico, liberista, razzista... guerrafondaio. Certo che non è la favoletta di Spike, piena di errori storici e di ingenuità politiche che può contrastare l'evocativa violenza insita nell'esaltante stupro con strage della famiglia irachena in Redacted, vittima destinale senza diritti (i cui diritti cominciano a venir meno là, quando si accetta il criterio "grigio" delle classi differenziali di Maroni-Gelmini qui) o l'adrenalina scatenata dal puntare la pistola a un automobilista, sparare su un guerrigliero di cui non vedi gli occhi a infinita distanza, o non riuscire a capire il motivo per cui tutti ti guardano in cagnesco quando vai in giro per le loro strade con tracotanza (esattamente lo stupore falso e idiota della Gelmini di fronte alle proteste: "Non capisco le proteste. Classi per stranieri? Non è razzismo; è didattica").
 Ecco, il rapporto implicito del fascismo con la guerra si esplicita anche in questo caso di ultraliberismo conclamato... la nuova raffigurazione del fascismo del XXI secolo: in Redacted e The Hurt Locker si coglie e si respira; in Sant'Anna di Stazzema non c'è nulla di nuovo e invece per documentare le nuove forme dell'autoritarismo ci vogliono le macro sull'immobilità professionale dei militari americani nel deserto della Bigelow, o la denuncia su Youtube di De Palma... O meglio ancora la figura femminile filmata e inserita da una donna in un film tutto al maschile, che spinge alle estreme conseguenze la donna di Falluja di Arcopinto: una donna irachena, non la vediamo bene (come tutti gli iracheni del film, ma qui rappresenta tutte le donne, compresa la ragazzina stuprata dai marines di Redaxted); questa donna da sola si avventa sull'intruso americano in casa sua e disarmata lo caccia fuori in un carrello indietro che coinvolge anche la macchina da presa, mentre il marito intellettuale sarebbe anche disposto a parlare per capire cosa lo spinge a essere lì, ospite non richiesto.
Ecco, il rapporto implicito del fascismo con la guerra si esplicita anche in questo caso di ultraliberismo conclamato... la nuova raffigurazione del fascismo del XXI secolo: in Redacted e The Hurt Locker si coglie e si respira; in Sant'Anna di Stazzema non c'è nulla di nuovo e invece per documentare le nuove forme dell'autoritarismo ci vogliono le macro sull'immobilità professionale dei militari americani nel deserto della Bigelow, o la denuncia su Youtube di De Palma... O meglio ancora la figura femminile filmata e inserita da una donna in un film tutto al maschile, che spinge alle estreme conseguenze la donna di Falluja di Arcopinto: una donna irachena, non la vediamo bene (come tutti gli iracheni del film, ma qui rappresenta tutte le donne, compresa la ragazzina stuprata dai marines di Redaxted); questa donna da sola si avventa sull'intruso americano in casa sua e disarmata lo caccia fuori in un carrello indietro che coinvolge anche la macchina da presa, mentre il marito intellettuale sarebbe anche disposto a parlare per capire cosa lo spinge a essere lì, ospite non richiesto.
Il fascismo ASSIMILATO - UN SENTIERO DI LETTURA SULLA MEMORIA DIVISA
Una «dittatura da operetta» per un popolo che voleva badare ai propri interessi privati. Un luogo comune duro a morire. Recentemente però sono maturati percorsi di ricerca che propongono con forza un'analisi sulla natura e sul consenso che ebbe il regime mussoliniano
Gianpasquale Santomassimo
Nella notte del 25 aprile 1943 il fascismo «si sciolse come neve al sole»: una metafora diffusa e ricorrente nel corso dei decenni e che riaffiora nelle narrazioni storiche e nelle memorie personali di tanti, volta a suggerire inconsistenza e carattere effimero del segno impresso dal regime nella cultura e nella mentalità degli italiani. L'intera nazione aveva «riacquistato in una notte il suo sicuro, istintivo senso della realtà storica» (l'Unità, 27 luglio 1943). Un evento miracoloso, di fatto inesplicato e inesplicabile, ma corrispondente alla percezione di moltissimi italiani, nel volgere accelerato della disfatta bellica, dei lutti e dei disastri che avevano accomunato l'intera penisola. Il rito collettivo della cancellazione dei segni esteriori del fascismo è stato rievocato da tanti storici e memorialisti: non solo l'uccisione in effige del duce e i fasci scalpellati dagli edifici pubblici, ma anche la sparizione dei distintivi, delle divise confezionate su misura, delle foto di famiglia in orbace ostentate nei salotti, di medaglie e attestati, fez, labari e gagliardetti. Sommatoria di milioni di azioni private compiute in silenzio, in parallelo al clamore delle manifestazioni pubbliche.
Rimozione concordata
Più difficile è valutare, al di là della rapida distruzione di simboli, il percorso individuale e collettivo di fuoruscita dal fascismo. Non solo e non tanto il tema dell'epurazione (che pure incide moltissimo nella sua tortuosa ambiguità nell'esistenza di molti italiani) o della continuità di apparati, strutture e istituzioni. Ma qualcosa di più corposo e al tempo stesso sfuggente, il quadro etico e politico che sottende all'uscita dall'esperienza fascista, il confronto pubblico con la fitta trama di relazioni intrattenute dalla società italiana con il regime. E' questo il tema del libro di Luca La Rovere, L'eredità del fascismo. Gli intellettuali, i giovani e la transizione al postfascismo 1943-1948, (Bollati Boringhieri, pp. 377, euro 30), che offre per la prima volta una lettura ad ampio spettro di questa complessa dimensione del dibattito postbellico. È il tema che potremmo definire della metabolizzazione del fascismo da parte degli italiani.
Diciamo subito che proprio per la ricchezza e la complessità delle voci che si agitano in questa discussione, la disputa sul passato non era in grado di offrire risposte univoche (e neppure di suggerirle retrospettivamente). Certo il risultato finale è quello di una sorta di rimozione concordata, ma è appunto un esito non scontato di un dibattito che offre suggestioni ancora attuali. Il limite dell'analisi di La Rovere è probabilmente quello di aver ricostruito essenzialmente un dibattito «colto», nutrito dai giornali e dalle riviste che danno vita a una effettiva polemica politica sull'eredità del fascismo, un'orbita che non interseca rotocalchi, stampa popolare, nascente cultura di massa (che è tema ora del libro di Cristina Baldassini, L'ombra di Mussolini. L'Italia moderata e la memoria del fascismo (1945-1960), Rubbettino, pp. 353, euro 18).
Un confuso tramestio di idee
Pur con questo limite, va detto che in quella discussione tutto o quasi tutto affiora, e che i temi portanti del dibattito italiano sul fascismo sono in nuce contenuti o abbozzati sin dal primo apparire. Non è neppur vero affermare, come si è spesso fatto, che non emerga il tema della colpa, quasi per una riluttanza dell'animo italiano ad affrontare un tema così severo. Certo mancano voci paragonabili alla profondità delle lezioni tenute a Heidelberg da Karl Jaspers nel 1946 sulla «situazione spirituale» della Germania. L'esito diverso della catastrofe legittimerà posizioni molto difformi, e in Italia proprio l'uso strumentale e immediato di quella Resistenza, poi detestata o confutata, offrirà a molte voci «moderate» il destro di utilizzarla come lavacro collettivo della coscienza nazionale. In ambito cattolico fioriscono alcune delle riflessioni più addolorate e consapevoli della profondità del baratro da cui si tenta di emergere: colpiscono le riflessioni di un giovane Aldo Moro sul fascismo nella sua dimensione totalitaria in quanto vera e propria apostasia dal cristianesimo. Ma anche nella cultura laica, complessa e divisa, emerge una consapevolezza sia pure intermittente della gravità del problema. Nello stesso Croce notiamo un singolare impasto di pessimismo realistico e fiduciosa negazione del peso che grava sulla coscienza nazionale; talora nella stessa argomentazione si può ricondurre il fascismo a «confuso tramestio di idee», e quindi parentesi destinata a non lasciar traccia, ma nella consapevolezza dei guasti arrecati in profondità al tessuto etico della società italiana. Piuttosto, va notata una ricorrente ambiguità nel modo in cui viene declinato il tema della colpa collettiva, a cui non è estraneo anche il carattere confuso e farraginoso del processo epurativo, e dove proprio le estremizzazioni lasciano il campo a una sostanziale irresolutezza della questione. Si può affermare - e si afferma - che tutti erano colpevoli e tutti erano innocenti, risoluzioni solo apparentemente opposte, perché se tutti erano colpevoli nessuno lo era veramente e dunque diveniva irrilevante accertare le responsabilità individuali.
In nome dell'uomo qualunque.
La convergenza più sorprendente è tuttavia un'altra. Semplificando al massimo, possiamo dire che si assiste alla fine alla confluenza di un paradigma antifascista e di un paradigma qualunquista nell'identico esito assolutorio. Con motivazioni del tutto opposte, nel primo caso negazione della effettiva presa del fascismo nell'animo italiano, tirannide di pochi aguzzini destinata ad essere spazzata via da un popolo «naturalmente» antifascista, nel secondo caso riduzione del regime fascista a fondale di cartapesta estraneo ai veri interessi e alle autentiche passioni dell'italiano qualunque, che tiene famiglia e guarda oculatamente al suo particolare, questi due schemi sommari procedono di fatto nella stessa direzione. Cioè nella banalizzazione del fascismo, nella sua riduzione a fenomeno esteriore che non ha inciso e non poteva incidere in profondità nelle coscienze degli italiani. Fatti salvi gli aspetti repressivi e criminali del regime, il tratto che emerge e che durerà a lungo nell'opinione degli italiani è quella sensazione di inconsistenza, propria di una «dittatura da operetta», priva dei caratteri di tragica determinazione propri dell'esperienza tedesca. Su questo processo di «nullificazione» del fascismo torna Emilio Gentile nella nuova edizione de La via italiana al totalitarismo (Carocci, pp. 420, euro 26,50), con nuove aggiunte all'impianto precedente e qualche giusta notazione polemica sulle pensose banalità di Hanna Arendt sul fascismo italiano.
Ma in questo quadro, di sostanziale e finale concordia assolutoria, stride e diviene particolarmente delicata la questione della «generazione fascista», dei giovani cresciuti integralmente nell'aura del regime, della loro collocazione nella nuova Italia democratica. Con accenti di maggiore o minore severità, di propositi «rieducativi» o di fiduciosa ma vigile inclusione, è tema che occupa tutte le forze politiche e culturali, parte integrante del dibattito generale sul postfascismo. Il percorso della generazione dei Guf era stato al centro del libro precedente di La Rovere (Storia dei Guf. Organizzazione, politica e miti della gioventù universitaria fascista 1919-1943, prefazione di Bruno Bongiovanni, Bollati Boringhieri, pp. 408, euro 34), a cui si aggiunge ora il libro di Simone Duranti Lo spirito gregario. I gruppi universitari fascisti tra politica e propaganda (1930-1940) (prefazione di Enzo Collotti, Donzelli, pp. 403, euro 27), più attento ai contenuti del dibattito interno tra i giovani fascisti. Opere che in ogni caso hanno posto in dubbio, e fondatamente, quella immagine un po' inverosimile di «palestra di antifascismo» che tante memorie avevano attribuito a quella organizzazione.
Le consolazioni del moderato
E proprio la memoria generazionale di questi giovani entra a far parte del dibattito: dove emerge con chiarezza che quel «lungo viaggio attraverso il fascismo», tante volte rievocato da Zangrandi in poi, si svolge in realtà in gran parte all'interno della democrazia, e che è soprattutto storia del rapporto istituito a posteriori con quel passato, tra buona e malafede, consistenti abbagli, rimozioni.
Anche qui, per semplificare al massimo, possiamo sottolineare la singolare convergenza, anche terminologica, tra personaggi così diversi come Ruggero Zangrandi e Indro Montanelli, accomunati dalla milizia giovanile in chiave di «sinistrismo» fascista, ma poi su sponde opposte nella vita e nella cultura dell'Italia repubblicana. Per Zangrandi il fascismo dei giovani era stato «socialismo inconsapevole», «criptoantifascismo» che conduceva naturalmente agli esiti dell'antifascismo attivo. Zangrandi teorizzava esplicitamente la necessità di elaborare una «strategia della memoria», che consentisse di «riconnettere» il passato con il presente. Che in pratica significava agire sulla memoria del passato per renderlo compatibile con le scelte attuali.
Montanelli sarà invece il massimo divulgatore di quella immagine del fascismo come «pagliacciata all'italiana», che avrà tanta fortuna nell'opinione pubblica moderata, rassicurante fondamento di una memoria consolatoria del fascismo. Ma il Montanelli del '45 argomenta le sue posizioni in termini convergenti con quelli di Zangrandi: «fascismo antifascista», «antifascismo in camicia nera», rivendicato come «vero antifascismo» e contrapposto a quello dei «professionisti dell'antifascismo» di sinistra. «Il Paese siamo noi, impuri antifascisti, che all'antifascismo siamo arrivati attraverso il fascismo» Dietro la condanna facile e ripetuta del «moralismo» si cela il rifiuto di qualsiasi moralità nell'agire politico.
In conclusione, poniamoci una domanda invitabile: si trattò di una occasione mancata che condizionò tutto lo sviluppo successivo del rapporto degli italiani con il passato fascista? La risposta che mi sentirei di dare è molto più sfumata e problematica rispetto a quanto siamo soliti affermare. Certamente il periodo del 1943-48 è una fase delicatissima perché in essa si formano luoghi comuni, stereotipi destinati ad operare a lungo e nel profondo dell'animo italiano.
Alcuni di essi giungono direttamente fino a noi, e danno corpo a un campionario di banalità rassicuranti che vediamo riaffiorare con quella inquietante naturalezza che è crosta di una ignoranza disperata e sostanziale (la «dittatura benefica» asserita pochi anni fa dal presidente del consiglio in carica).
E indubbiamente l'occasione non viene colta in tutte le potenzialità che avrebbe potuto offrire; ma realisticamente bisogna pur dire una modica (magari meno tossica) quantità di rimozione e di edulcorazione era inevitabile e fisiologica per guardare avanti. Oblio e memoria sono in eguale misura indispensabili per una società che non voglia farsi schiacciare dal passato e che non voglia vivere in un presente eterno e immobile, senza radici. Del resto lo stesso fenomeno di rimozione del passato fascista, in forme ancor più opache e preoccupanti, avvenne, come è noto, in Germania. Ma sono le occasioni successive, irrimediabilmente non colte, che formano la vera particolarità italiana. La rivolta degli anni Sessanta sarà in Germania occasione per fare i conti col passato, mettendo per la prima volta sotto accusa la «generazione dei padri» per il suo coinvolgimento attivo nella dittatura. In Italia si riprodurrà invece l'ennesima polemica sulla Resistenza come rivoluzione tradita o mancata.
Negli anni Ottanta nella coscienza occidentale verrà alla luce in tutta la sua portata l'enormità dello sterminio e il complesso e lacerante capitolo delle sue implicazioni. La coscienza italiana si proclamerà subito «fuori del cono d'ombra dell'Olocausto», nella formulazione del più noto storico del fascismo, e coltiverà con intensità ancora maggiore lo stereotipo del «buon italiano» vittima incolpevole della storia.
L'introduzione della problematica del consenso sarà un trauma per i tedeschi, costringerà a un esame di coscienza collettivo e senza sconti. In Italia la stessa problematica verrà accolta quasi con sollievo, vissuta come conferma definitiva del luogo comune della dittatura bonaria e modernizzatrice.
apparso su "il manifesto" dell'8 ottobre 2008
|

