|
|
NearDark
database di recensioni
Per ricercare nel database di NearDark, scrivete nel campo qui sopra una stringa di un titolo, di un autore, un paese di provenienza (in italiano; Gran Bretagna = UK, Stati Uniti = USA), un anno di produzione e premete il pulsante di invio.
È possibile accedere direttamente agli articoli più recenti, alle recensioni ipertestuali e alle schede sugli autori, per il momento escluse dal database. Per gli utenti Macintosh, è possibile anche scaricare un plug-in per Sherlock.
Visitate anche la sezione dedicata all'Africa!
Ararat
Anno: 2002
Regista: Atom Egoyan;
Autore Recensione: adriano boano
Provenienza: Canada;
Data inserimento nel database: 10-05-2003
Ararat: Atom Egoyan fa i conti con l'identità
Atom EgoyanArarat
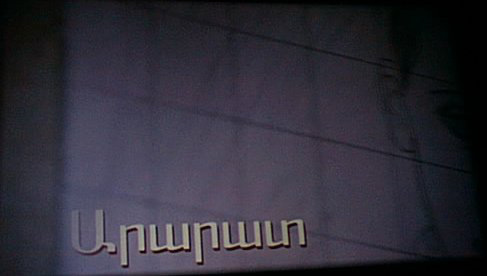
|

|
|
Regia: Atom Egoyan
Sceneggiatura: Atom Egoyan
Fotografia: Paul Sarossy
Montaqgio: Susan Shipton
Musica: Michael Danna
|
CAST
Starring: David Alpay Arsinee Khanjian Charles Aznavour Christopher Plummer Eric Bogosian Elias Koteas Brent Carver Bruce Greenwood Raoul Bhaneja Marie-Josée Croze
|
Durata: 126'
Anno: 2002
Nazione: Canada
-
|
Dopo un'altra guerra contro un popolo destinato a perdere la sua identità e quotidianamente martellati dalla presenza imposta da qualsiasi mezzo di comunicazione dell'immagine duplicata di un rais brianzolo, niente di meglio che Ararat di Atom Egoyan per rimeditare sia sul massacro, sia sull'uso dell'immagine in modo esasperante e globalizzante.

|
Ararat è un testo a disposizione di qualunque genocidio a partire da quello capostipite del "secolo breve" e costellato di massacri: attraverso di lui c'è una base per depositare un fondamento (quasi un sistema filosofico) sul quale impedire ogni subdola o sorniona negazione. A questo scopo si costruisce un impianto che tende a giungere al grado zero dell'elementarità, perché non ci siano ambiguità - fino alla fine con quell'assoluzione finale almeno per buona fede (e perché dalla parte giusta si avverte la sicurezza di non poter fare cose turpi: un'asserzione che stempera e inficia in parte la rigida ricostruzione e ricerca di ragioni inattaccabili) - fino a risultare didattico.
 Un amico - fors'anche giustamente - dice che "i cambi di spazio-tempo sembrano piu' casuali (un pizzico di prezzemolo, un po' di erba cipollina e sale q.b.) che manovrati da una mente umana". Quell'urgenza di legare generazioni diverse, storia di decenni di diaspora si scontra anche con la difficoltà - che però va messa in scena anch'essa - a mantenere la distanza giusta per focalizzare eroismi e leggende, ragioni e mistificazioni... sempre rimpallato tra due approcci alla materia (forse di nuovo si ripropone la dicotomia di The Sweet Hereafter?) come poteva Egoyan fare tutto ciò se non assegnando a ciascun ambito adottato una peculiarità stilistica che non poteva che frammentare il film in modo casuale - inserendosi nella linearità perduta del testo, in apparenza scardinandola in modo aleatorio, o forse quella casualità era voluta per mantenere vivo il livello di dubbio da rintuzzare in ogni sua parte. Per questo artificialmente mantiene sempre una tensione data da qualche interlocutore che si incarica di incarnare l'opinabile: il doganiere nel settore abitato dal giovane in cerca della certezza delle origini che affondano nell'armenità; mentre l'altro elemento ribelle è la sua ragazza "sorellastra", che rivendica una diversità dai racconti stereotipati di resistenza di un mondo scomparso, un'alternativa anche alla morte forzatamente eroica a cui dare un senso nella Storia che si va raccontando, che abita la rivalità femminile, il mondo che guarda le proliferazioni d'immagini come "disperato bisogno di essere ricordati", ma anche come via di mezzo tra nostalgia di qualcosa che è solo parte di un racconto e quindi diventa enigma da svelare e ingombranti padri fantasmatici; e poi c'è l'"ufficiale turco", che anche nella sua forma mondana di attore dubbioso avanza perplessità sull'eventualità che sia il caso di far risalire a eventi quasi secolari i rapporti tra discendenti di vittime e pronipoti di carnefici.
Un amico - fors'anche giustamente - dice che "i cambi di spazio-tempo sembrano piu' casuali (un pizzico di prezzemolo, un po' di erba cipollina e sale q.b.) che manovrati da una mente umana". Quell'urgenza di legare generazioni diverse, storia di decenni di diaspora si scontra anche con la difficoltà - che però va messa in scena anch'essa - a mantenere la distanza giusta per focalizzare eroismi e leggende, ragioni e mistificazioni... sempre rimpallato tra due approcci alla materia (forse di nuovo si ripropone la dicotomia di The Sweet Hereafter?) come poteva Egoyan fare tutto ciò se non assegnando a ciascun ambito adottato una peculiarità stilistica che non poteva che frammentare il film in modo casuale - inserendosi nella linearità perduta del testo, in apparenza scardinandola in modo aleatorio, o forse quella casualità era voluta per mantenere vivo il livello di dubbio da rintuzzare in ogni sua parte. Per questo artificialmente mantiene sempre una tensione data da qualche interlocutore che si incarica di incarnare l'opinabile: il doganiere nel settore abitato dal giovane in cerca della certezza delle origini che affondano nell'armenità; mentre l'altro elemento ribelle è la sua ragazza "sorellastra", che rivendica una diversità dai racconti stereotipati di resistenza di un mondo scomparso, un'alternativa anche alla morte forzatamente eroica a cui dare un senso nella Storia che si va raccontando, che abita la rivalità femminile, il mondo che guarda le proliferazioni d'immagini come "disperato bisogno di essere ricordati", ma anche come via di mezzo tra nostalgia di qualcosa che è solo parte di un racconto e quindi diventa enigma da svelare e ingombranti padri fantasmatici; e poi c'è l'"ufficiale turco", che anche nella sua forma mondana di attore dubbioso avanza perplessità sull'eventualità che sia il caso di far risalire a eventi quasi secolari i rapporti tra discendenti di vittime e pronipoti di carnefici.
|
Con tutto ciò i vari livelli di fattura (che non corrispondono alle letture applicabili) sono sovrapposti con maestria ma non sono sicuro che funzionino al loro interno: troppo scevri di qualsiasi passione in una materia così retorica che diventa la retorica dell'antiretorica, qualche perplessità si annida persino nel bell'incipit immerso nei colori delle fiabe alla Paradzanov, che inscena il "melograno" come luogo topico di quella terra (Sajat Nova - Il colore del melograno è uno dei film più famosi del regista caucasico perseguitato in Urss perché armeno e omosessuale), come sapore - senso che forse può aiutare meglio della vista che registra subito incongruenze come l'Ararat evocativo ma invisibile da Van (e proprio quell'allusione pone in campo l'altra faccia della medaglia che confuta l'impianto lucido e rigoroso e che - ci si chiede - può essere attaccato, se preferisce inserire licenze poetiche al rigore); poi il frutto è ripreso due volte, una prima volta per essere dileggiato ferocemente nella sua poeticità fiabesca (denunciando così che non è quello il registro che si vuole seguire) e una seconda per ottenere da Aznavour una sua ricontestualizzazione proponibile anche in chiave di recupero della propria appartenenza.





|
Di nuovo l'amico dice che è didattico l'intero stralcio del doganiere non informato del genocidio "in certi momenti una vera palla; un minimo di sillogismi, rapporti causa-effetto niente: un vero empirico". E, aggiungerei, impossibilitato a saltare anche il più semplice passaggio, perché lì potrebbe annidarsi l'inganno, il dato non analizzabile. Anche su questo non c'è dubbio che la sua funzione iniziale sia quella di offrire il destro alla ricostruzione pedissequa da lezioncina sul massacro degli armeni, ma proprio questo suo empirismo di partenza è l'unica vera crescita di un personaggio nel film, confermando così che si tratta della proiezione dello spettatore ingenuo sullo schermo: però la crescita è davvero una rivoluzione copernicana di tolleranza, arrivando a non applicare più quella rigidezza che abbiamo imputato al regista e al suo plot, accettando non solo il beneficio del dubbio che ha sempre avversato - anche verso il figlio gay - ma arriva a scagionare in modo irrazionale, dare ragione all'intenzione di per sé giusta, all'aspetto romantico dell'argomentazione più che ai fatti: dunque non si può negare comunque l'esistenza del popolo armeno, che ha subito persecuzioni già solo per il fatto che ne esiste il racconto appassionato. E a quel risultato non si poteva pervenire di certo attraverso le conferenze su Arshile Gorky. ma certo non si poteva arrivarci senza quell'immagine che proviene dal passato e ritorna ossessivamente sotto ogni formato, in ogni riproduzione possibile: in video sovrapposta al ragazzo che la testimonia così con il suo volto giustapposto alla immagine del portale a cui fa riferimento il pittore esule, di cui è affascinante la ricostruzione della ispirazione almeno quanto è imbarazzante l'indulgenza sulla nostalgia espressa in termini scontati e ridicoli (il balletto inscenato nell'atelier) e nella foto d'epoca, ingrandita o sotto forma di foto confiscata dai turchi al ragazzino Arshile con parole che potrebbero essere dell'esercito di Sharon adesso o di gerarchi nazi un tempo. Quell'immagine non più ricostruibile - come dimostra il set in interni con cui si ripropone all'inizio del film lo scatto - ha lo stesso valore delle figurine del ghetto di Varsavia rilasciate da Polanski: denuncia una cultura che non c'è più e per la quale si prova nostalgia (non foss'altro perché era diversa, mentre la sorellastra è parte del mondo globalizzato) e racchiude un enigma, quello alla base del quadro senza mani: il non poterla ripristinare nella sua interezza, manca la fragranza (quella assenza che il set in interni artefatti palesemente restituisce integralmente)
Dunque la nuova critica - correttissima - è che Arshile è un po' troppo estetizzante e una vera ossessione quella foto, ma proprio quello dovrebbe essere il bello del film: il fatto che ritorna per ogni dove sotto formati diversi incarnando il ricordo indelebile della nazione armena. S'insinua irriducibile e in quel modo incarna la resistenza fatta dai padri, morti, rinnovata nel ricordo affidato alla linea matrilineare, depositaria del racconto e della spiritualità, duplicati entrambi nella ricostruzione, nella foto, nel farsi della foto, e nel farsi del quadro ispirato a quella posa, nei video e nei portali che animano quei video dimostrando la fonte di ispirazione, che però rimane tale con la mediazione dei mezzi di rappresentazione: di qui l'urgenza di andare ad annusare quegli insegnamenti in loco.
|
Di fronte a questo si può ritenere legittimamente che la solita vetusta idea di trincerarsi nel meta-film risponda all'esigenza di frapporre un ulteriore livello di semantizzazione che indebolirebbe la denuncia. In realtà è ribaltabile il ragionamento: quello è un modo immediato di far sentire che "non c'è più nulla del suo mondo", si può dire che lo ribadisce forse troppo, addirittura nomina questo messaggio: "il quadro è un sacro codice che spiega da dove veniamo e perché siamo qui", dice in conferenza la scrittrice. e insiste nel ribadire che non c'è la prova che inchioda i criminali, ma solo testimoni e ricostruzioni (le ragazze bruciate vive producono nel testimone il moto contrario a quello ricercato: "come faccio a togliermele dagli occhi?"), vorrebbero eliminare le immagini di quello a cui hanno assistito, ma si ripropone sempre (di nuovo nella ricostruzione in interni, come lo scatto della foto) mentre il video consegna a una freddezza da archivio il ricordo, inconfutabile, tanto da convincere anche il doganiere. Ma non solo il video, bensì anche - e soprattutto - le parole ripetute all'ossessione fanno sì che "ad ogni parola che diceva si avvicinava alla verità"
Ciò che è universale e che è una vera contrapposizione agli statunitensi è quella percezione del dolore che proviene dalla consapevolezza di essere stati e di continuare a essere odiati senza motivo (e già questo differenzia dagli statunitensi), ma soprattutto ciò che è insostenibile è che l'umanità dice di non odiarli... E allora perché?
Probabilmente voleva realmente non ammettere repliche, nel senso che voleva eliminare qualsiasi eccezione di rifiuto dell'effettivo evento del massacro. E per farlo si è gettato su ogni aspetto tenendo però separati gli ambiti narrativi e riuscendo solo parzialmente nel finale a ricomporre vagamente un'unità tra tutti i percorsi che non gli è riuscita. Troppo preso a anticipare ogni eventuale turco negazionista o disposto a mettere una pietra sopra (come l'attore, quello sì, veramente stereotipo del turco anche come fisico: forse il momento più intenso del film).
Un'altra amica si esprime così nei confronti del film: "non mi ha convinta; domina l'incertezza e la paura di osare. Sarebbe carino se questa paura fosse il filo conduttore (tipo I sommersi e i salvati di P. Levi), ma è un obiettivo decisamente alto e non mi risultano film che siano riusciti a dirla. Qui è uno 'scusarsi' dall'inizio alla fine, ansia di spiegare, di dire che è tutto vero, insomma Egoyan non si fida e contravviene a una delle principali regole della narrazione, il patto con il lettore/spettatore".
Non si può non essere d'accordo: e arriva persino a spiegare questo dubbio che inficia lo sforzo didattico durato tutto il film, perché il doganiere lo assolve perché era comunque in "buona fede", come se lasciasse un'ultima chance qualora si volesse negare le dimensioni del massacro - e davvero non fossero stati un milione e mezzo i morti - comunque rimane il gesto, la convinzione di essere nel giusto, un "sublime atto di autodifesa" (che come definizione della resistenza armena mi sembra nuova), e soprattutto il potere taumaturgico della parola che gradualmente una dopo l'altra avvicina alla "verità", valida soprattutto per gli ispirati che sono convinti di non essere in grado di fare certe cose.
Questo è l'aspetto che nella sua contraddittorietà rimane però la componente più interessante di un testo per altro invece apparentemente granitico nella sua requisitoria attorno a una foto ossessiva quanto il ricordo che rappresenta. E quel ritornare sotto varie spoglie della foto - ritratto - riproduzione ricostruita mentre viene scattata in interni falsissimi come il ricordo del pittore stereotipato (sublime nell'abisso di kitsch che avvolge l'inaccettabile pittore nel suo studio che più scontato non si può) è forse l'aspetto a un tempo più bello del film e più irritante, appunto. come quando esplicita persino l'ovvio, usa le conferenze come se lo spettatore fosse una tabula rasa da incidere ex novo, eppure anche così ci sono talvolta dei guizzi che fanno indovinare qual era l'intento: intrecciare in modo che si riproponesse lo stesso meccanismo dell'indimostrabile anche in un evento diverso dall'eccidio, ma che scatena le medesime reazioni ("non c'è modo di dimostrare che quello che mi ha detto è inventato") al punto che mi sembra diventi invece il motivo centrale del film che trascende il portale nel video e tutte quelle carinerie metalinguistiche.
Salverei il tentativo di sviscerare lucidamente - direi gelidamente e senza partecipazione - quali sentimenti muovono chiunque si trovi coinvolto come vittima di fronte a una travisamento della storia: un argomento di triste attualità. Che lo faccia senza passione ma affidandosi a molti racconti obliqui è forse l'unico reale motivo di interesse linguistico del film, che però ha il pregio di affermare che qualunque lotta contro soprusi e prepotenze perpetrati ai danni di popolazioni su basi etniche è di per sé da combattere: è legittimo ribellarsi alle aggressioni, comunque e sempre. Ora serve solo un altro film che sottolinei quanto sia innaturale dividersi per nazioni e tribù... ma questo è un altro tema, privo di immagini, di orgoglio sbandierato e di fondamenti culturali, perché non si può ricondurre a nessun nazionalismo, anzi ne è fieramente immune (e forse per questo Egoyan non sembra nelle corde del film: magari il motivo è il contrario di quello spacciato, dai ferventi nazionalisti di ogni parte che lo leggono come un'eccessiva adesione al tema).
|

