“In
un’Argentina devastata dalla crisi economica, nasce un tenero e insolito
legame tra Felix, un giovane vagabondo, e Chango, un bimbo di appena un
anno. Nella campagna della Pampas, Felix è assunto come bracciante da
Roberto, il padre di Chango. Mentre in casa cresce la tensione tra Roberto e
la moglie, Felix comincia a prendersi cura del neonato. Tra i due nasce un
grande affetto. Felix, orfano dei genitori, sente che deve dare al bambino
l’amore negatogli dalla famiglia. Emarginato dalla società e solitario,
il giovane ha trovato uno scopo nella vita: salvare il bimbo dal caos”
(dal Catalogo del 15° Festival del Cinema Africano, d’Asia e America
Latina, Editrice Il Castoro, Milano 2005, pag. 25).

Leonardo Ramirez offre una prova attoriale stupenda nel ruolo del giovane
padre adottivo: risultano sincere e convincenti le attenzioni e le cure
prestate al piccolo Chango, dal momento in cui si accorge della sua presenza
e soprattutto quando si rispecchia nella sua condizione, che lo porta
gradualmente a ripercorrere alcuni frammenti della sua infanzia e
soprattutto a ricordare nel finale il volto della nonna, che si era occupata
di lui, una volta diventato orfano.
L’inserimento di flashback, dapprima sfocati o in bianco e nero e poi man
mano maggiormente nitidi e a colori, dedicati al flusso di memoria del
giovane, punteggia lo sviluppo della vicenda, arricchendo il personaggio di
un fascino misterioso e facendo assumere alla sua recitazione una sorta di
legittimo riscatto del proprio passato.
Felix sta scappando da un mondo che non è dato conoscere (di lui si saprà
soltanto che è nativo del Paranà): lo vediamo scrutare il paesaggio, che
si va facendo sempre più brullo e desertico, dal finestrino di un treno in
corsa, che si lascia alle spalle anche le manifestazioni dei piqueteros
ai bordi della ferrovia; senza biglietto in tasca è costretto a lanciarsi
dal vagone al sopraggiungere del controllore e a proseguire arrancando lungo
le rotaie, che lo portano a raggiungere la stazione di un villaggio nel
Chaco, privo di grandi attrattive, dove il tempo sembra essere sospeso o
scandito soltanto dal rito di una birra, consumata da un unico avventore
intento a seguire alla televisione un incontro di pugilato. Il giovane è in
cerca di un lavoro qualsiasi, mentre all’uomo interessa soltanto poter
rinverdire le proprie trascorse prodezze boxistiche, in memoria dei bei
tempi andati. L’adulto offre ospitalità e un’occupazione temporanea al
ragazzo: dovrà occuparsi della fattoria e dare una mano alla moglie nella
raccolta della frutta, destinata a trasformarsi in confettura da vendere
agli angoli di una, poco frequentata, strada principale.

Felix accetta di buon grado quella sistemazione precaria in un casale
desolato, dove le giornate, illuminate da un tiepido sole malsano,
trascorrono apparentemente sempre uguali a se stesse (siamo nel nord
dell’Argentina e non nell’evocativa Patagonia), ma il suo sguardo, muto
e indagatore, si rende conto fin dall’inizio che qualcosa non va in quella
coppia mal assortita. Roberto, il marito, è un sempliciotto rimasto
disoccupato, pronto a divertirsi al tiro al bersaglio, usando come prede dei
mandarini; ritiene sia necessario con i tempi che corrono viaggiare armati;
inoltre è un beone e, quando alza il gomito, non si fa problemi a picchiare
la moglie. Quest’ultima appare come una creatura mite e succube degli
eventi domestici, i suoi lineamenti indigeni la rendono ancora più indifesa
nei confronti delle violenze fisiche e psicologiche cui la sottopone il
marito, mentre il suo comportamento discreto e silenzioso l’aiuta fin
dall’inizio a sentirsi timidamente solidale nei confronti dell’estraneo.
Oltre alla coppia nella cascina c’è Changuito, il figlio di un anno
appena, che risveglia in Felix un’ondata di tenerezza, che, stupisce
persino il giovane medesimo, incredulo di fronte alla sua capacità di
saperci fare con un neonato. Tra i due scatta fin da subito qualcosa di
travolgente: un’attrazione reciproca, fatta di sguardi, smorfie, abbracci,
carezze, dita afferrate con la forza di un pugnetto (“Tu mi hai stretto la
mano, non resterai mai solo, io mi occuperò di te”).
Al ragazzo viene naturale cullare Chango, cantargli la ninna-nanna, sfamarlo
con il biberon, farlo divertire, eseguendo anche giochi di abilità con le
mani, usando i mandarini non come bersagli da abbattere, bensì come
attrezzi del mestiere degni di un clown. Inoltre intesse lunghi monologhi
con il bambino, che gli consentono di riattraversare repertori della sua
infanzia, permettendo così anche allo spettatore di comprendere la valenza
di quei siparietti onirici, destinati a materializzare dal subconscio le
fattezze della nonna, il cui volto, dimenticato, prenderà forma soltanto
nel tragico finale, mentre dapprima di lei il ragazzo riesce a mettere a
fuoco soltanto dettagli di gambe, mani e spalle.
Le inquadrature volte a mostrare l’apertura o la chiusura di porte e
finestre finiscono per dare un ritmo alla convivenza stessa del quartetto,
diventando al contempo cifra metaforica del dramma che si sta allestendo in
quel microcosmo, che attribuisce sempre più al giovane il compito di muto
testimone di una catastrofe familiare e al contempo di aiutante magico nei
confronti della creatura più indifesa. Inoltre l’abbondante utilizzo di
primi piani di Felix finisce con il registrare puntualmente i suoi stati
d’animo: preoccupati e pensierosi da un lato, quando spia la relazione tra
i coniugi; affettuosi e amorevoli dall’altro, man mano si rende conto
dell’importanza che sta assumendo la presenza di Chango nella sua vita,
alimentata anche dal sospetto che la madre del piccolo abbia deciso di
metter fine alla propria, affidandogli indirettamente il figlio, che sa
allevare così bene. Simbolica di questa variazione all’interno della
ripetitività delle giornate un’altra inquadratura ricorrente mostra in
campo lungo un muro perimetrale rossiccio, nel quale si confondono un po’
le figure del giovane e della madre, poste alle due estremità del quadro
statico, ma in realtà dinamico perché i due si scambieranno i ruoli: Felix
si trova con il bambino in braccio a osservare la donna che mangia al posto
che lui occupava nell’inquadratura precedente. Lo scambio è avvenuto in
una specie di montaggio delle attrazioni di stile ejzenstejniano.
Quando la tragedia si consuma e la donna sparisce (forse confondendo il
proprio corpo proprio con le acque del fiume, vissuto come un orizzonte di
salvezza), mentre il marito finisce con l’impazzire e distruggere la
fattoria, in perenne stato di ubriachezza, il giovane decide di riprendere
il viaggio di partenza, portando con sé il bambino e un gruzzolo di
banconote.
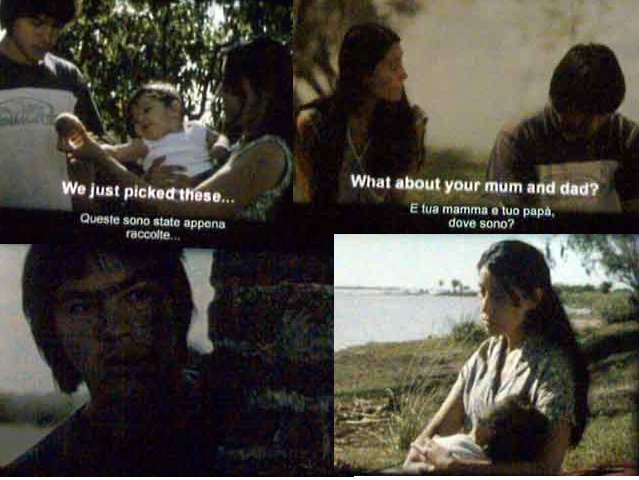
Il film avrebbe potuto concludersi su questo finale positivo, capace di
restituire una sorta di speranza all’esistenza di due creature sfortunate,
che condividono il medesimo senso di orfanitudine, invece si scopre che il
vero intento della regista argentina (che mette come chiosa la sinistra
dicitura “Benedetti i nostri figli”) consiste nell’operare a questo
punto una sorta di astrazione dalla fiaba per concentrarsi soprattutto sulla
natura dell’oggetto d’affezione: l’analisi del rapporto tra Felix e
Chango da un’angolazione diversa, capace di mostrare luci e ombre su
questa totale dedizione all’altro da sé, colma di temperie emotive, che
non lasciano margini a consapevolezze razionali. In preda all’euforia
scatenata dall’avere finalmente uno scopo nella vita, qualcuno di cui
occuparsi, il giovane dimentica di non poterlo mantenere: trascorre il suo
tempo ad allestire una casa “a misura bambino”, dove poter vivere con
Chango, scoprire il piacere di imbandire una tavola per due e dormire,
cullandolo tra le sue braccia. Ma la realtà è amara come il suo sogno
ricorrente, che rivela finalmente la sua portata anticipatoria: la sua
manina di bambino intenta a rimestare l’acqua, in un secchio che ne
riflette l’immagine, diventa rossa come il colore improvvisamente assunto
da quella superficie liquida.
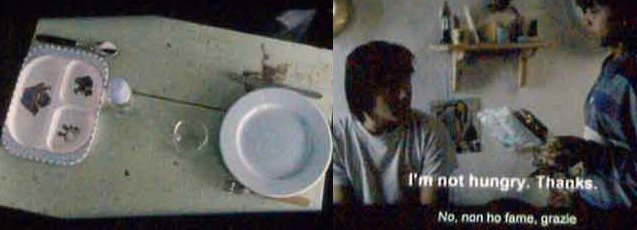
Colto impreparato di fronte alla morte della nonna, Felix trova un suo
equilibrio nella seconda situazione, quando decide di abbandonare
l’ambiente di fiumi e acquitrini della sua infanzia; trova un ruolo nel
Chaco, sostituendosi a una madre, a sua volta impreparata, tanto che decide
di suicidarsi, gettandosi proprio nell’acqua; risulta ancor di più
sprovvisto di strumenti per sopravvivere all’interno di una città, quando
si risolve nell’adozione del bambino. Come avviene normalmente nella
cinematografia del nord dell’Argentina, si pensi a Los Muertos di
Lisandro Alonso o ai film di Lucrezia Martel, questo può far pensare che
l’uso dell’ambiente sia metaforico della cultura o dell’attuale società
Entre Rios.


