|
Editoriale
Primo Maggio 2008
Tornando a parlare di lavoro: morte e precariato
Ricominciare dall'autogestione spontanea
L'implosione della sinistra concertativa, socialdemocratica, quella che ha sempre svolto essenzialmente il ruolo di bloccare ogni iniziativa, di frapporsi tra le lotte antagoniste e i bersagli di queste (padroni e sistema capitalistico) si è manifestata alla fine quando è risultato palese il fallimento del suo compito essenziale: l'emancipazione delle classi subordinate, la liberazione dal lavoro e dal ricatto di chi ha imposto sempre condizioni di lavoro peggiorative e sottopagate (quelle raccontate fin dagli anni Cinquanta da film come Giovanna di Pontecorvo). Ora non c'è più quasi nessuno garantito e il precariato non è interessato a rivendicare capacità, know how, esperienza, orgoglio del lavoro di contro al suo sfruttamento: non è più al centro la dignità come nella prima metà del Novecento, e neanche la consapevolezza di una forza che avrebbe potuto cambiare le condizioni alienanti in officina (Tempi moderni) o i sogni di appropriarsi almeno della produzione... Il lavoro dei sindacati pompieri è riuscito finalmente e dunque il precario non è interessato a perpetuare il suo sfruttamento e non si fa rappresentare da organismi compromessi con chi li sfrutta e soltanto pronti a contrattare sempre più al ribasso le condizioni; il precario non crede che un qualunque parlamento lo rappresenti (perché i danni che può arrecare sono infimi rispetto a quelli che serpeggiano nella società civile e che esperisce sulla sua pelle a prescindere che le mazzate arrivino da sinistra o da destra), non nota differenze per la sua condizione, ma neanche ormai lo spaventano loschi figuri fascisti là dentro, quando le loro stesse idee hanno potuto sfondare fuori nella totale distrazione di ogni ambiente infiltrato dal germe neofascista del feroce liberismo abbracciato da tutta la sinistra (parlamentare o extra che sia) che compartecipando alla organizzazione capitalistica non rappresenta più nessuno.
E avendo terminato il proprio lavoro di sopire le coscienze, quelli che si candidano a rappresentare per azzerare le proteste, non hanno più ragione di esistere
 Nemmeno può rappresentare quel lucidissimo Carlo Barrapodi, che durante una trasmissione televisiva ha spiegato come lui - operaio da quando aveva 15 anni, migrante dalla Calabria a Torino, per finire ora cassintegrato alla Thyssen - vuole cogliere l'occasione per comprendere fino in fondo il "Tempo della Consapevolezza", come lo chiama lui: si tratta degli stadi attraverso i quali passa chiunque abbia svolto mansioni non particolarmente soddisfacenti per l'orgoglio di lavoratore e per i risultati, ma che si trovava a essere abbastanza garantito dal miraggio raggiunto di un posto fisso rivelatosi per quello che è quel tipo di lavoro: una gabbia (per i suoi colleghi tramutatasi in bara). Il primo è che "Si finisce con il credere di passare a migliorare la vita" in futuro, proseguendo; il secondo è la sensazione di rimanerci dentro intrappolato ("Te ne accorgi con le ferie"). Al terzo ci si libera o si finisce i propri giorni (bruciando vivi o consumandosi lentamente fino alla pensione-chimera): lui, Barrapodi, non ha più intenzione di buttare via la vita per un padrone cinico ed è tornato in Calabria.
Nemmeno può rappresentare quel lucidissimo Carlo Barrapodi, che durante una trasmissione televisiva ha spiegato come lui - operaio da quando aveva 15 anni, migrante dalla Calabria a Torino, per finire ora cassintegrato alla Thyssen - vuole cogliere l'occasione per comprendere fino in fondo il "Tempo della Consapevolezza", come lo chiama lui: si tratta degli stadi attraverso i quali passa chiunque abbia svolto mansioni non particolarmente soddisfacenti per l'orgoglio di lavoratore e per i risultati, ma che si trovava a essere abbastanza garantito dal miraggio raggiunto di un posto fisso rivelatosi per quello che è quel tipo di lavoro: una gabbia (per i suoi colleghi tramutatasi in bara). Il primo è che "Si finisce con il credere di passare a migliorare la vita" in futuro, proseguendo; il secondo è la sensazione di rimanerci dentro intrappolato ("Te ne accorgi con le ferie"). Al terzo ci si libera o si finisce i propri giorni (bruciando vivi o consumandosi lentamente fino alla pensione-chimera): lui, Barrapodi, non ha più intenzione di buttare via la vita per un padrone cinico ed è tornato in Calabria.
Ma lui è un caso, perché invece un suo collega è fiero di fare 15 ore di lavoro di fila per pagarsi la macchina da 32 mila euro, come si inorridisce a sentire nel documentario di Simona Ercolani (La classe operaia va all'Inferno), prodotto da Fabrizio Rondolino, pagato dalla Film Commission di Torino, presentato in un luogo fighetto come la Fondazione Sandretto - un ex luogo di lavoro - al cospetto di Sergio Chiamparino (senza fascia, ma impegnato a stringere mani)... realizzato con l'intento di elaborare il lutto, un film consolatorio che sortisce il suo effetto (vicina, assisteva alla proiezione la figlia di Rocco Marzo: ha pianto per tutto il tempo... le hanno fabbricato un modo per incanalare la sua giusta rabbia, per tollerare la perdita assurda).
Il film voluto da Fabrizio Rondolino - ex braccio destro di D'alema al tempo del suo premierato - comincia con le immagini televisive dell'assemblea annuale Thyssen, roba da indignarsi, per preparare gli animi, poi compare il neodeputato Boccuzzi, parlandone da ancora non eletto, che comincia a raccontare, una prolessi dell'incidente probatorio inscenato teatralmente, a sancire l'intento: è una tragedia greca con tanto di corifei, anzi di coro femminile, perché subito si rileva che le superstiti sono le donne di quegli operai, lasciate sole con le medaglie (il Primo Maggio, oggi, Napolitano le insignirà delle medaglie).
La retorica si fa lugubre e un po' pesante: le prime testimonianze si alternano con una fresa, dapprima non si capisce, poi l'inquadratura si allarga e si vede cosa sta incidendo quella fresa: i nomi sulla lapide... poi l'elenco degli oggetti collocati nelle bare: una serie che denuncia gli interessi di quei poveri cristi costretti, condannati a gettare il loro cervello in 15 ore di seguito di lavoro, per cui poi rimaneva lo spazio solo per la Juventus del padrone, il sogno della Ferrari o i vestiti firmati (non un grande ritratto della classe operaia, che vota Berlusconi).
La regista a questo punto capisce che il registro è spettrale e allora devia nella raffazzonata storia delle Ferriere, tirata giù in pochi minuti e neanche una sequenza d'archivio... poi finalmente ci sono i cinque minuti dedicati all'impegno e alla denuncia (gli straordinari accettati per solidarietÓ con i compagni di lavoro che sarebbero stati messi in libertà senza salario per carenza di operai nel turno, due ragazzi deferiti per essersi rifiutati di fare straordinario, 12 o 15 ore di lavoro come regola: "I sindacati non vanno più a favore dell'operaio" è il massimo di ribellione consentito, come a voler stigmatizzare l'accusa con le sequenze successive dove i delegati con megafono si danno da fare... con le istituzioni che promettono, con il padrone, ottenendo lo stretto indispensabile per mettere la sordina alla ribellione: rabboniscono con un pugno di mosche, come sempre (ma questo giudizio non si evince dal film).
Il primo film sulla tragedia della Thyssen (bruciato sul filo di lana Calopresti) non si fa mancare niente, perché prende spunto da assunti che documenta senza creatività, semplicemente per accumulazione: quindi, in rapida successione, assistiamo al tema della mancanza che produce nuove vittime (i superstiti delle famiglie che si accorgono dei vuoti e non sanno come riempirli: alcuni sono così fragili da finire nelle grinfie dei Geova), a cui fa seguito subito la solidarietà tra incidenti diversi: il film sulla Thyssen ospita i morti del Molino Cordero di Fossano, da dove proviene una testimonianza meno connotabile del lumpenproletariat delle Ferriere: si analizza la destabilizzazione della famiglia e si denuncia l'incapacità di comprendere il dramma che si cela dietro la notizia sul giornale: "Non ci si può immedesimare. Quando ti tocca, capisci quanto è assurdo". Poi l'esempio più chiaro, toccante, condivisibile: una sera, avendo realizzato che non era ancora arrivato, gli ha telefonato e il cellulare di lui ha preso a squillare lì vicino, riportandola alla realtà. Feroce e molto autentico, in contrasto con il resto del film, soprattutto con l'altra sezione (persino più breve e insensata), forse pretesa da Chiamparino, dedicata a cattivissimi romeni insidiati in un capannone vicino alla Thyssen in dismissione per depredarla del rame: una sequenza piena di divise di carabinieri e razzismo, degno del primo cittadino persecutore dei rom.
Il film stancamente raggiunge la fine attraverso due altri spezzoni forti di retorica che non conduce a nulla (sintomatico che non sia mai nominato Guariniello e la sua testimonianza sia espunta): la rievocazione del memorandum del direttore della Thyssen, pieno di ignobili allusioni alle colpe degli operai e al fatto che siano organizzati (e forse pure Comunisti o Anarchici); l'altro è segnato dal giusto livore della sorella di Demasi, che si augurano finiscano bruciati i responsabili con le loro famiglie, ma quei "loro" sono indefiniti, defilati: senza un'analisi che ci si aspetterebbe da un documentario preparato in cinque mesi quel primo piano sulla ragazza ferita risulta monca, come il film. Un pezzo da tv del dolore (ma da Fabrizio Rondolino, lo scrittore erotico che per questo si Ŕ giocato il ruolo di portavoce di un premier, ce lo possiamo aspettare)
 "Con il dilagare della disoccupazione, della precarizzazione e del ricatto al lavoro che entrambe queste condizioni accentuano, l'illusione di potersi emancipare attraverso il lavoro e la produttività è visibilmente svanita insieme alla retorica nostalgica di un movimento operaio che del lavoro era ed è rimasto succube fino alla sua consunzione" (Sergio Ghirardi, Lettera aperta ai sopravvissuti, Nautilus, Torino 2007, p. 22). Non si tratta sicuramente più delle illusioni de La Califfa dileggiate da Doberdò (che almeno sapeva di cosa parlava, ora il capetto che cancella ogni parvenza di coerenza capisce solo le cifre del foglio di calcolo fornito dalla Direzione e non sa nemmeno quale sia il prodotto dell'azienda di cui è servo), non sono sicuramente più le assemblee di Volontè ne La classe operaia va in paradiso, dove già traspariva la disperazione perché si presagiva la mancanza di futuro... un futuro che sicuramente non troverà rappresentanza presso il sindacato legaiolo, ma per ora è in quel cimitero che si rifugiano gli impauriti - e storditi - operai residuali, con ancora un contratto che non sarà più né nazionale, né uguale per tutti. Già non lo è adesso. "Con il dilagare della disoccupazione, della precarizzazione e del ricatto al lavoro che entrambe queste condizioni accentuano, l'illusione di potersi emancipare attraverso il lavoro e la produttività è visibilmente svanita insieme alla retorica nostalgica di un movimento operaio che del lavoro era ed è rimasto succube fino alla sua consunzione" (Sergio Ghirardi, Lettera aperta ai sopravvissuti, Nautilus, Torino 2007, p. 22). Non si tratta sicuramente più delle illusioni de La Califfa dileggiate da Doberdò (che almeno sapeva di cosa parlava, ora il capetto che cancella ogni parvenza di coerenza capisce solo le cifre del foglio di calcolo fornito dalla Direzione e non sa nemmeno quale sia il prodotto dell'azienda di cui è servo), non sono sicuramente più le assemblee di Volontè ne La classe operaia va in paradiso, dove già traspariva la disperazione perché si presagiva la mancanza di futuro... un futuro che sicuramente non troverà rappresentanza presso il sindacato legaiolo, ma per ora è in quel cimitero che si rifugiano gli impauriti - e storditi - operai residuali, con ancora un contratto che non sarà più né nazionale, né uguale per tutti. Già non lo è adesso.
 Dopo le rievocazioni di facciata su come erano emozionanti le lotte operaie quando si facevano (fino al 1980, poi più niente) con modalità da sceneggiato televisivo, oppure prendendo per buone le veline d'epoca dei tg targati Fiat, l'annata cinematografica si è lungamente occupata di lavoro... probabilmente non in omaggio ai reiterati inviti di Napolitano (uno che non ha mai messo piede in fabbrica, nemmeno per comizi) a considerare le morti cosiddette bianche come emergenza di una società che si considera civile e fondata sul lavoro, quanto piuttosto alla sua spettacolarizzazione: è trendy mostrare lavoratori o precari, magari inventando improbabili ambienti che risultano macchiette d'atmosfera (Littizzetto con camera annessa di Cover boy, ma anche stanza da scapolo di Signorina Effe), così abbiamo visto Antonio Boccuzzi, delegato Uilm (!!), inscenare lacrime di fianco a genitori di operai bruciati vivi nella sua fabbrica - forse già pensando al suo scranno parlamentare-, abbiamo partecipato a manifestazioni toccanti di una città improvvisamente consapevole della propria vocazione a produrre sacrifici umani al lavoro: il corteo era davvero (per una volta le immagini dei tg non riuscivano a occultare) una imponente massa emotiva che si trascinava per le vie del centro di Torino come una bolla di esacerbato mutismo che conteneva una accusa senza risposta (nonostante l'impegno di Guariniello), eppure le immagini di Boccuzzi e del corteo stesso erano oscene (nel solito senso di estraneità alla scena), con qualcosa che dal vivo era superato dall'emozione e che nella rievocazione acquisivano quella stessa patina da velina di regime dei filmati d'archivio del film della Comencini... infatti poi le morti sono proseguite, anzi si sono intensificate, l'unica differenza rispetto ai primi 11 mesi del 2006 (e agli anni precedenti) è che i tg adesso registrano ogni morte sul lavoro, anestetizzandole in questo modo, facendole diventare un bollettino che non attira nemmeno l'attenzione del telespettatore, perso dietro a baggianate elettorali. E Boccuzzi in questo modo farà carriera politica come molti altri sindacalisti che lo hanno preceduto sugli scranni più alti del parlamento. Non arriverà a tanto (come neanche Ciro Argentino, Fiom!!), anche perché il suo film personale di lavoratore lo vede impegnato non tanto tempo fa a fondare club di Forza Italia e a impedire di mettere alle strette la Thyssen proprio in materia di sicurezza dall'alto della sua delega sindacale (Uilm!!!)... ma questo i film prodotti in Italia non lo raccontano. E nemmeno i giornali. Forse lo fa quello di Daniele Segre (non siamo ancora riusciti a vederlo... ci sarà un motivo, no?), magari quello di Mimmo Calopresti, che però ha appena finito le riprese nei pressi della Thyssen... speriamo nel suo acume di documentarista e nella sua ascendenza familiare... a questo punto possiamo cercare di capire qualcosa del cinismo del mondo del lavoro soltanto rivolgendoci all'estero (a parte una sorpresa e mezza, che ci sono state rivelate passando tra le pieghe della censura). Dopo le rievocazioni di facciata su come erano emozionanti le lotte operaie quando si facevano (fino al 1980, poi più niente) con modalità da sceneggiato televisivo, oppure prendendo per buone le veline d'epoca dei tg targati Fiat, l'annata cinematografica si è lungamente occupata di lavoro... probabilmente non in omaggio ai reiterati inviti di Napolitano (uno che non ha mai messo piede in fabbrica, nemmeno per comizi) a considerare le morti cosiddette bianche come emergenza di una società che si considera civile e fondata sul lavoro, quanto piuttosto alla sua spettacolarizzazione: è trendy mostrare lavoratori o precari, magari inventando improbabili ambienti che risultano macchiette d'atmosfera (Littizzetto con camera annessa di Cover boy, ma anche stanza da scapolo di Signorina Effe), così abbiamo visto Antonio Boccuzzi, delegato Uilm (!!), inscenare lacrime di fianco a genitori di operai bruciati vivi nella sua fabbrica - forse già pensando al suo scranno parlamentare-, abbiamo partecipato a manifestazioni toccanti di una città improvvisamente consapevole della propria vocazione a produrre sacrifici umani al lavoro: il corteo era davvero (per una volta le immagini dei tg non riuscivano a occultare) una imponente massa emotiva che si trascinava per le vie del centro di Torino come una bolla di esacerbato mutismo che conteneva una accusa senza risposta (nonostante l'impegno di Guariniello), eppure le immagini di Boccuzzi e del corteo stesso erano oscene (nel solito senso di estraneità alla scena), con qualcosa che dal vivo era superato dall'emozione e che nella rievocazione acquisivano quella stessa patina da velina di regime dei filmati d'archivio del film della Comencini... infatti poi le morti sono proseguite, anzi si sono intensificate, l'unica differenza rispetto ai primi 11 mesi del 2006 (e agli anni precedenti) è che i tg adesso registrano ogni morte sul lavoro, anestetizzandole in questo modo, facendole diventare un bollettino che non attira nemmeno l'attenzione del telespettatore, perso dietro a baggianate elettorali. E Boccuzzi in questo modo farà carriera politica come molti altri sindacalisti che lo hanno preceduto sugli scranni più alti del parlamento. Non arriverà a tanto (come neanche Ciro Argentino, Fiom!!), anche perché il suo film personale di lavoratore lo vede impegnato non tanto tempo fa a fondare club di Forza Italia e a impedire di mettere alle strette la Thyssen proprio in materia di sicurezza dall'alto della sua delega sindacale (Uilm!!!)... ma questo i film prodotti in Italia non lo raccontano. E nemmeno i giornali. Forse lo fa quello di Daniele Segre (non siamo ancora riusciti a vederlo... ci sarà un motivo, no?), magari quello di Mimmo Calopresti, che però ha appena finito le riprese nei pressi della Thyssen... speriamo nel suo acume di documentarista e nella sua ascendenza familiare... a questo punto possiamo cercare di capire qualcosa del cinismo del mondo del lavoro soltanto rivolgendoci all'estero (a parte una sorpresa e mezza, che ci sono state rivelate passando tra le pieghe della censura).
Si tratta di ritornare a meditare quali siano le condizioni di lavoro attuali, non serve nemmeno più fabbricare mostre sul passato. Per esempio, Rossa nell'orrido Palafuksas, retaggio delle olimpiadi che ha cercato di ferire Porta Palazzo e invece risulta essere semplicemente un corpo estraneo che il resto della piazza multietnica, da sempre autonoma e autogestita nel Balon, ha semplicemente ignorato: una mostra dove si fa evidente la differenza di approccio al lavoro della Cgil tra prima e dopo la guerra, il dopo - dal maccarthysmo a Mirafiori in avanti - è omertoso sulle autentiche responsabilità del declino della classe operaia per mano dei suoi dirigenti. L'unico valore della mostra è lo sproposito di materiali che fanno urlare vendetta per le vacue scelte di Comencini per realizzare un montaggio di veline rai nel suo In Fabbrica. La precarizzazione ha prodotto nelle fabbriche una lumpen-borghesia rancorosa e razzista (ma ancora garantita dal contratto a tempo indeterminato), che ben che vada è composta da sfiduciati capetti come quelli intervistati nel finale del film della Comencini, fino a quei neri da piantagione, contenti del loro padrone e del loro livello di sfruttamento senza prospettive al di fuori del lavoro, per capire di preciso lo stato delle cose non si può rimestare i vecchi documentari sulle lotte operaie di Gobetti (o più recentemente di Daniele Gaglianone o Guido Chiesa, suoi rigorosi discepoli), prima che si arrivi a quella consapevolezza ne passa ancora di tempo: bisogna piuttosto andare a leggersi i classici, come Jack London per capire il livello di violenza e di prevaricazione, quanta merda e quanto sangue occupi il mondo del lavoro adesso, come a fine Ottocento.
 Il petroliere... grandiosa la pervicacia con cui Lewis è completamente chiuso a qualsiasi "superstizione religiosa" (la chiama proprio così, testuale, a riconoscimento di quale serio problema sia il conforto confessionale, che cancella la rabbia con i suoi riti magici e le fittizie liete novelle: un conforto rimosso perché potrebbe sviarlo dal suo percorso di invasato lavoratore, dedito a un unico obiettivo, al di là della possibile remunerazione che ne proviene, è la passione per il lavoro) ed è il perno su cui ruota il film, perché da lì deriva la sua personale etica che lo muove e apparentemente lo rende cosigrave; censurabile secondo la morale comune, mentre è invece solo inflessibile e spietato, innanzitutto con se stesso: gli anarcoidi, anche quando non sono anime belle, sono mossi da un rigore maggiore di qualsiasi cattolico magari aduso alla confessione, perché quella "fede" è personale e non transige... ma qui i primi venti minuti muti, completamente senza parole, sono un sunto di cosa sia lavoro (fatica, merda, dolore, sangue, attrezzi, liquami, sporco, sforzi... collaborazione e rivalità: praticamente un compendio eccellente dei racconti dello Yukon del cercatore d'oro in Klondike, Jack London); si percepisce che il rapporto tra la persona che opera e la materia su cui agisce sono brutali o giocati sul genio, ma sempre è una lotta per ridurre alla volontà tecnologica del lavoratore la natura. Il petroliere... grandiosa la pervicacia con cui Lewis è completamente chiuso a qualsiasi "superstizione religiosa" (la chiama proprio così, testuale, a riconoscimento di quale serio problema sia il conforto confessionale, che cancella la rabbia con i suoi riti magici e le fittizie liete novelle: un conforto rimosso perché potrebbe sviarlo dal suo percorso di invasato lavoratore, dedito a un unico obiettivo, al di là della possibile remunerazione che ne proviene, è la passione per il lavoro) ed è il perno su cui ruota il film, perché da lì deriva la sua personale etica che lo muove e apparentemente lo rende cosigrave; censurabile secondo la morale comune, mentre è invece solo inflessibile e spietato, innanzitutto con se stesso: gli anarcoidi, anche quando non sono anime belle, sono mossi da un rigore maggiore di qualsiasi cattolico magari aduso alla confessione, perché quella "fede" è personale e non transige... ma qui i primi venti minuti muti, completamente senza parole, sono un sunto di cosa sia lavoro (fatica, merda, dolore, sangue, attrezzi, liquami, sporco, sforzi... collaborazione e rivalità: praticamente un compendio eccellente dei racconti dello Yukon del cercatore d'oro in Klondike, Jack London); si percepisce che il rapporto tra la persona che opera e la materia su cui agisce sono brutali o giocati sul genio, ma sempre è una lotta per ridurre alla volontà tecnologica del lavoratore la natura.
 Qui si vede cosa sia morte sul lavoro, non ci sono edulcorazioni come nelle signorineffe e nelle comencinate - gli operai non sono di per sé un organismo unico fatto di eroi, ma un'accozzaglia di persone tutte diverse e per lo più squallide, come capita in tutti gli altri ambienti... ne sa qualcosa chiunque abbia tentato di trovare un sistema per frantumare i piani dei padroni trovandosi di fronte qualche volta dei minus habens inetti e malfidati, più spesso degli elementi pronti a vendere la madre per poter fare qualche ora di straordinario in trasferta alloggiati in una roulotte per guadagnare sulla diaria al gelo del Nordeuropa, come straccioni.
Qui si vede cosa sia morte sul lavoro, non ci sono edulcorazioni come nelle signorineffe e nelle comencinate - gli operai non sono di per sé un organismo unico fatto di eroi, ma un'accozzaglia di persone tutte diverse e per lo più squallide, come capita in tutti gli altri ambienti... ne sa qualcosa chiunque abbia tentato di trovare un sistema per frantumare i piani dei padroni trovandosi di fronte qualche volta dei minus habens inetti e malfidati, più spesso degli elementi pronti a vendere la madre per poter fare qualche ora di straordinario in trasferta alloggiati in una roulotte per guadagnare sulla diaria al gelo del Nordeuropa, come straccioni.
 Il film è girato benissimo, con inquadrature sempre filologiche per riferimenti oggettuali all'epoca e situazioni in cui mai vengono prima esigenze di spettacolo rispetto a quelle di lavoro; un affresco perfetto del periodo e viene fuori esplicitamente l'America e il suo capitalismo spietato, che passa sopra a tutti per un'idea fissa che non è nemmeno fare soldi, quanto fervida visione di realizzare imprese impossibili (un Herzog/Fitzcarraldo per niente palloso e senza musica lirica, per fortuna). Anderson è uno che riesce a dare un'idea globale di qualsiasi epoca che si impegna ad affrescare a tutto tondo: uno dei pochi che non coglie atmosfere solo locali, ma si perita di collocare quel luogo in un preciso decennio, badando a ogni dettaglio. Il film è girato benissimo, con inquadrature sempre filologiche per riferimenti oggettuali all'epoca e situazioni in cui mai vengono prima esigenze di spettacolo rispetto a quelle di lavoro; un affresco perfetto del periodo e viene fuori esplicitamente l'America e il suo capitalismo spietato, che passa sopra a tutti per un'idea fissa che non è nemmeno fare soldi, quanto fervida visione di realizzare imprese impossibili (un Herzog/Fitzcarraldo per niente palloso e senza musica lirica, per fortuna). Anderson è uno che riesce a dare un'idea globale di qualsiasi epoca che si impegna ad affrescare a tutto tondo: uno dei pochi che non coglie atmosfere solo locali, ma si perita di collocare quel luogo in un preciso decennio, badando a ogni dettaglio.
 Quello era il mondo del lavoro da rimeditare, perché siamo tornati alla stessa ferocia e alla stessa concorrenza spietata... e probabilmente rinascerà una nuova coscienza di classe su altri presupposti e - sperabilmente - senza ripetere l'errore di affidarsi all'unica opzione moderata e comprommissoria, quella che impedisce le rivendicazioni che potrebbero scardinare il sistema neoliberista ora, capitalista trent'anni fa. Richiedere solo condizioni migliori significa accettare la logica del lavoro, del suo sfruttamento e dello sviluppo sfrenato... Quello era il mondo del lavoro da rimeditare, perché siamo tornati alla stessa ferocia e alla stessa concorrenza spietata... e probabilmente rinascerà una nuova coscienza di classe su altri presupposti e - sperabilmente - senza ripetere l'errore di affidarsi all'unica opzione moderata e comprommissoria, quella che impedisce le rivendicazioni che potrebbero scardinare il sistema neoliberista ora, capitalista trent'anni fa. Richiedere solo condizioni migliori significa accettare la logica del lavoro, del suo sfruttamento e dello sviluppo sfrenato...
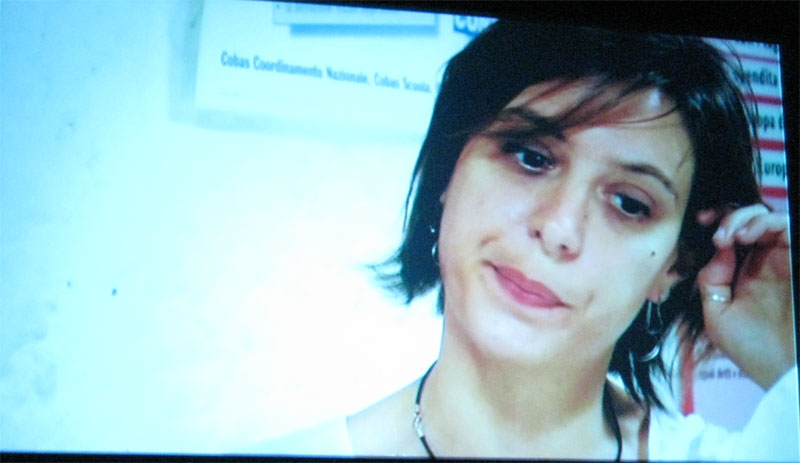 Ma c'è ancora la mezza sorpresa: finché esistono ancora Parole Sante di Ascanio Celestini (prodotto dal coraggioso Procacci) rimane una speranza che non si dia peso a presunte sconfitte (elettorali) per non vedere quelle vere (l'assenza di solidarietà e propensione all'autogestione). Le stupidaggini elettorali sono inezie, ma il suo geniale film inchioda con grazia alle loro ignobili inettitudini le organizzazioni sindacali e politiche, senza i toni truci di militanti, ma con la leggerezza dell'ironia, che si trasmette all'autore a partire dai protagonisti della sua inchiesta (e non viceversa!), stringente, intensa, essenziale, dove ogni parola, ogni testimonianza, qualunque fotografia o rievocazione non aggiunge nemmeno una parola di troppo.
Ma c'è ancora la mezza sorpresa: finché esistono ancora Parole Sante di Ascanio Celestini (prodotto dal coraggioso Procacci) rimane una speranza che non si dia peso a presunte sconfitte (elettorali) per non vedere quelle vere (l'assenza di solidarietà e propensione all'autogestione). Le stupidaggini elettorali sono inezie, ma il suo geniale film inchioda con grazia alle loro ignobili inettitudini le organizzazioni sindacali e politiche, senza i toni truci di militanti, ma con la leggerezza dell'ironia, che si trasmette all'autore a partire dai protagonisti della sua inchiesta (e non viceversa!), stringente, intensa, essenziale, dove ogni parola, ogni testimonianza, qualunque fotografia o rievocazione non aggiunge nemmeno una parola di troppo.
 Non ci sono mostri devitalizzati dalle isole di lavorazione ritagliate sullo sfondo di un reparto asettico, ma giovani consapevoli, che raccontano la loro decisione di ribellarsi tutti insieme ma senza premeditazione, ottenendo risultati (poi invariabilmente gettati alle ortiche da un sindacato corrotto e compromissorio). Una rivolta divertita e sorprendente: per primi loro stessi, i protagonisti, non sono organizzati... semplicemente sono disponibili a mettersi in gioco; e infatti tutti perderanno il precarissimo posto, rifiutando le condizioni capestro accettate dal sindacato, dopo che invece il movimento autorganizzato aveva ottenuto ben altro a termini di legge, finché il governo Prodi, sedicente amico, era arrivato al punto di legiferare in modo da vanificare la loro lotta. Ecco Ascanio Celestini, senza protagonismo, fa parlare i protagonisti, a loro l'onere di ricostruire passo passo l'appassionante vicenda, con coloriti ritratti di vessatori e pelosi sindacalisti e sottosegretari rifondaroli, preludio della ribellione in massa alla rappresentanza di quegli apparati rivelatisi troppo scopertamente socialdemocratici.
Non ci sono mostri devitalizzati dalle isole di lavorazione ritagliate sullo sfondo di un reparto asettico, ma giovani consapevoli, che raccontano la loro decisione di ribellarsi tutti insieme ma senza premeditazione, ottenendo risultati (poi invariabilmente gettati alle ortiche da un sindacato corrotto e compromissorio). Una rivolta divertita e sorprendente: per primi loro stessi, i protagonisti, non sono organizzati... semplicemente sono disponibili a mettersi in gioco; e infatti tutti perderanno il precarissimo posto, rifiutando le condizioni capestro accettate dal sindacato, dopo che invece il movimento autorganizzato aveva ottenuto ben altro a termini di legge, finché il governo Prodi, sedicente amico, era arrivato al punto di legiferare in modo da vanificare la loro lotta. Ecco Ascanio Celestini, senza protagonismo, fa parlare i protagonisti, a loro l'onere di ricostruire passo passo l'appassionante vicenda, con coloriti ritratti di vessatori e pelosi sindacalisti e sottosegretari rifondaroli, preludio della ribellione in massa alla rappresentanza di quegli apparati rivelatisi troppo scopertamente socialdemocratici.
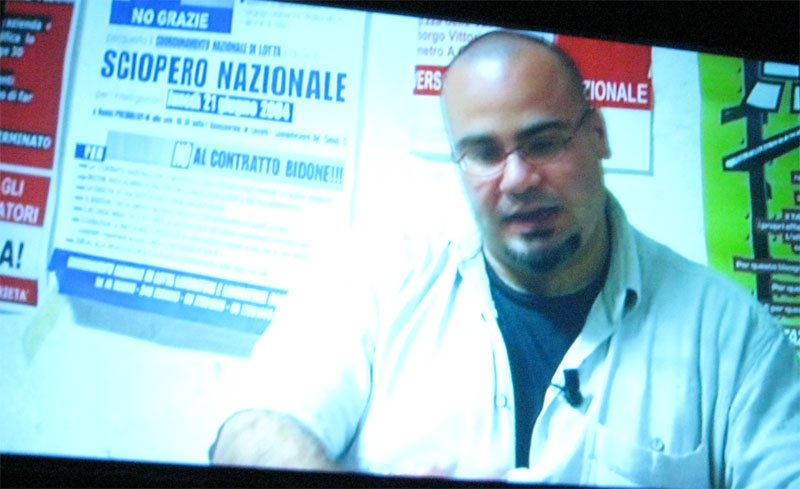 Quello che risulta incredibile è la capacità di essere appassionante, divertente, pur essendo un film costituito all'80 per cento da testimonianze dirette in mdp, perché quelli vitali sono gli affabulatori, bei volti, svegli e decisi, disillusi e sarcastici, politicizzati a seguito della lotta, senza essere intruppati in organizzazioni che fagocitano e mettono a tacere. Qui è bella l'idea e la realizzazione, azzeccati i racconti di contorno, simpatici i protagonisti... emblematica la lotta, che dimostra e denuncia la solitudine dei lavoratori, l'insipienza e l'ipocrisia di tutta la sedicente sinistra di governo (allora non ancora extraparlamentare) o sindacale, un ritratto ben conosciuto da chi ha avuto a che fare con i bonzi sindacali, ma molto meno documentata al cinema (e del tutto sconosciuta in tv) e una fotografia spietata del mondo del lavoro, ora.
Quello che risulta incredibile è la capacità di essere appassionante, divertente, pur essendo un film costituito all'80 per cento da testimonianze dirette in mdp, perché quelli vitali sono gli affabulatori, bei volti, svegli e decisi, disillusi e sarcastici, politicizzati a seguito della lotta, senza essere intruppati in organizzazioni che fagocitano e mettono a tacere. Qui è bella l'idea e la realizzazione, azzeccati i racconti di contorno, simpatici i protagonisti... emblematica la lotta, che dimostra e denuncia la solitudine dei lavoratori, l'insipienza e l'ipocrisia di tutta la sedicente sinistra di governo (allora non ancora extraparlamentare) o sindacale, un ritratto ben conosciuto da chi ha avuto a che fare con i bonzi sindacali, ma molto meno documentata al cinema (e del tutto sconosciuta in tv) e una fotografia spietata del mondo del lavoro, ora.
 Ma il meglio è lo spontaneismo che traspare dall'ironia a posteriori, come dall'entusiasmo nel momento centrale, quando Celestini comincia il racconto di quello che nel 2005 (quando l'attore incontra i precari di Atesia) è ancora in corso e che alla fine trova un epilogo amaro - ma ancora sorridente, perché non ci si fa illusioni e si riesce a sorridere di situazioni tragiche e palesi truffe istituzionali. Un percorso di grande libertà e vitalità proprio perché privo di alcun potere e di qualsiasi manto istituzionale: nessuno ha nulla da guadagnarci o un futuro luminoso, semplicemente si finisce coinvolti nella lotta perché non può essere diversamente. La spontaneità per assenza di secondi fini: qui Boccuzzi non avrebbe spazio, e si vede chiaramente che uno qualunque di questi giovani sfruttati dal call center hanno sviluppato una sensibilità tale che capterebbero immediatamente la falsità dell'atteggiamento di un qualunque arrivista (attivista) politico-sindacale.
Ma il meglio è lo spontaneismo che traspare dall'ironia a posteriori, come dall'entusiasmo nel momento centrale, quando Celestini comincia il racconto di quello che nel 2005 (quando l'attore incontra i precari di Atesia) è ancora in corso e che alla fine trova un epilogo amaro - ma ancora sorridente, perché non ci si fa illusioni e si riesce a sorridere di situazioni tragiche e palesi truffe istituzionali. Un percorso di grande libertà e vitalità proprio perché privo di alcun potere e di qualsiasi manto istituzionale: nessuno ha nulla da guadagnarci o un futuro luminoso, semplicemente si finisce coinvolti nella lotta perché non può essere diversamente. La spontaneità per assenza di secondi fini: qui Boccuzzi non avrebbe spazio, e si vede chiaramente che uno qualunque di questi giovani sfruttati dal call center hanno sviluppato una sensibilità tale che capterebbero immediatamente la falsità dell'atteggiamento di un qualunque arrivista (attivista) politico-sindacale.
|

