|
Editoriale
|
"L'erba proibita" rappresenta la maggior evidenza della stanchezza e totale assenza di incisività che grava su certe forme adottate per collazionare prodotti che si rivolgono alle coscienze. Intanto il supporto, il dvd (al Greenwich Village di Torino hanno dimostrato una totale incompatibilità con le nuove tecnologie: luci che si accendevano neanche fosse The Trip di Corman; interruzione della banda audio all'improvviso; attesa infinita della ripresa della proiezione per vedere, come immaginato, il dvd ricominciare da capo con il tg1 sull'Aspromonte in mezzo a una piantagione...), denuncia il target poi gonfiato alla sala in concomitanza con la giornata anti-proibizionista. Però non con intenti di amplificazione, piuttosto con bisogno di pubblicità.
Sponsorizzazioni gratuite per tutti i coinvolti: dall'orrido Pannella in un insopportabile "Come eravamo" (d'altronde si diceva un tempo che l'hashish si manteneva nel piscio di cammello: una leggenda metropolitana del deserto o un delizioso cocktail per digiunatori?) a un bolso Paolo Rossi, non più capace di azzeccare una battuta che possa in qualche modo legare il materiale disparato proposto - era meglio il figlio di Piero Angela, almeno è il suo lavoro - che comprende tutti i luoghi comuni più triti, risultando la copia speculare degli ancora più risaputi argomenti dei nazi-proibizionisti.
Controinformazione deve essere giocata su ritmi e terreni incontaminati da quella fascista, sennò si confonde, diventa un tutt'uno con il becero berciare dei La Russa, clonati o meno dalla Tv. Per quanto i dati siano incontestabili e si debbano pubblicizzare in tutte le scuole del regno (luogo deputato alla proiezione di questo documentario senza invenzioni linguistiche), proprio questo dato sulla destinazione d'uso dovrebbe farci meditare: se un prodotto è scolastico, significa che è affetto da didatticismo, normalmente risulta un po' noioso e con quell'etichetta vogliamo liberarcene, scaricandolo sui poveri giovani che «devono imparare, fabbricarsi una coscienza». Si risponde al proibizionismo con una nuova imposizione: «devi informarti!» e quindi ci troviamo di fronte a un'infilata di repertori e testimonianze, tutte prive di côté accattivante. E poi gli officianti al rito sono sulla falsariga del conduttore: vecchi pachidermi della correttezza libertaria. Infatti il problema è proprio nel fatto che Dario Fo, David Riondino, Dario Vergassola risultano patetici e anche un po' demotivati testimonial innanzi tutto di loro stessi. O meglio di quello che furono, un po' sbiaditi, come le immagini di repertorio che documentano le coltivazioni: mica tutti possono avere un padre come il mio, che nei suoi racconti della gioventù passata a lavorare la campagna ti fa annusare davvero l'odore nauseante della canapa che macerava, o dei riti spontanei di una superstizione laica per far venire più alta la propria pianta da tessere. Infatti a dispetto di affabulatori premi nobel il più efficace è l'anziano che all'inizio, privo di ogni aura sacerdotale dei narratori, sbarra tanto d'occhi a sentire che la pianta da lui coltivata così a lungo da giovane è proibita perché stupefacente, strappando con la sua - incredula - l'unica risata della sala, questa sì liberatoria. La catarsi non è solo, quella ovvia, nei confronti dei soprusi del potere che proibisce, ma anche di tutti quelli compenetrati nel loro ruolo di "testimoni", insegnanti, un po' tronfi e ... irrimediabillmente vacui, accomunati ai paludati proibizionisti. Dei Gran Sacerdoti che con la loro sola presenza hanno dato spazi, reso tollerabili - perché simili nella loro simmetricità - a quei fantasmi che stanno aggirandosi per l'Europa. Ennesimo esempio di come non le idee di liberazione, ma i loro autonominati sacerdoti vadano rimossi. Tutti, non solo gli impresentabili politici di una sedicente sinistra.
La fattura del video dimostra la sparizione di ogni inventiva e lo stanco ripetersi del rito collettivo, come in fondo era già denunciato - forse inconsapevolmente - da Alberto Camerini 25 anni fa con Bambulè: una formula religiosa, che viene rievocata con evidenza nelle figure del coltivatore svizzero, sfuggito da un'icona degli anni settanta: pochi minuti prima si era detto giustamente che il proibizionismo è una pura e semplice ideologia senza alcuna ragione, senza argomentazioni credibili, contronatura, una religione scatenata da invasati iperreligiosi; e poi ci viene offerta la vista di una piantagione in un palazzo, con luce artificiale, un guru che sgrana il rosario delle diverse specie raccolte in India (!!!??!) per tredici anni (cazzo, mentre noi dovevamo lavorare per mantenerci, questo svizzero si poteva permettere di scorazzare per l'India, magari travestito da arancione, a raccogliere semi) e che ci presenta un oggetto di culto degno di un film dell'orrore: la "pianta madre". Il trittico di quell'icona è completato da Zulu dei 99, in posa per tutto il tempo che dura l'innocua intervista e dall'altro lato dal topo di laboratorio che continua a chiedere con la levetta un'altra dose, un'ostia di canapa.
|
|
|
|
E veniamo al punto dolente. Credo che l'espressione di punti di vista sia sempre più fagocitata da un sistema che alla fine può giocare sempre al meglio le sue carte per indirizzare le masse da una parte o dall'altra. Le complicità e le varie responsabilità dei singoli davvero non possono essere prese in considerazione di fronte a quella deriva della maggioranza che corrisponde alla cecità di fronte ai più grandi temi che riguardano l'umanità. Del resto è detto solo velocemente anche nel documentario. La canapa poteva essere un ottimo carburante non inquinante ma il petrolio ha poi vinto , ancora gli interessi beceri che hanno colpito l'immaginazione di Adriano (quando mi citava da un altro film, L'ora di religione). Siamo insomma sempre davanti a interessi di alcuni personaggi di cui si può forse parlare in una prospettiva storica appena distaccata, ed interessi che rimangono sostanzialmente invisibili nel presente, perché nascosti. Forse è questo il tormentone che dovremmo ripeterci ogni giorno. Apriamo gli occhi, apriamoli il più possibile, perché la nostra libertà è continuamente insidiata da questa melassa della disinformazione democratica, dove le istituzioni con la loro devastante iconografia sono il più fetido travestimento della menzogna. Scarabbocchiamo sulle immagini come Castellitto, è l'unico gesto liberatorio, in senso metaforico significa ridere di fronte alla messa in scena del quotidiano-immaginario, rivedendolo nella suà sincera nullità di Italiano per principianti, senza messa in scena, scritto solo sui corpi, davvero ultimi segni autentici e non simulacri.
|
|
Allo stesso modo Costa-Gavras non riuscirà mai ad arrivare alle corde di un pubblico disabituato al freddo rigore delle sue immagini, alla statica ricostruzione di intrighi, alle bordate nascoste sotto i colpi di fioretto. Con i movimenti di macchina calibrati, fin dall'inizio sappiamo che il film sarà rigoroso come il chiostro di cui vediamo il lungo corridoio nelle prime inquadrature che poi correttamente (troppo) spaziano in panoramica su quegli ambienti, già contenuti nei loro significati metaforici nei programmatici tagli che già si ammantano di gesuitismo, di sotterfugi temporali ammantati da sverniciate di falsa spiritualità. La sensazione è però che si rimanga nel risaputo, nella denuncia sterile e priva soprattutto di passione; questo presupporrebbe un approccio che privilegi l'amaro distacco, cinico e disincantato, che invece non supera le risapute battute feroci che non riescono a stigmatizzare neanche l'orrore del razzismo nazista («Quel che è potabile per uno slavo non è detto che lo sia per un essere umano», sappiamo che quelli sono i cattivi, non c'è bisogno che si sottolinei): il dramma è ben oltre queste freddure. Non si tratta di non condividere la visione di una chiesa stereotipata nel suo conformismo, come vaneggia Massimo Bernardini su «L'Avvenire» del 19 aprile, ma di rilevare come il regista si trovi costretto dall'ovvietà della condanna della politica vaticana a realizzare un film che fin dalle prime inquadrature è fatto di immagini e soprattutto battute che scivolano su serie di temi (dall'eutanasia agli ospedali psichiatrici per gli improduttivi) ridotti a estemporanei flash, figurine di un'agiografia laica che sottraggono spazio alla tragedia di chi si trincera o si macera nella scusa «Noi eseguiamo solo», che diventerà per Eichmann (evocato anche qui con un bozzetto degno di maggior spazio) fierezza burocratica. La messa in scena dei corridoi in cui si muove il pretino stride con l'unico momento visivamente intenso - quello degli spioncini che diventano metafora dell'osceno, mantenuto rigorosamente al di là di un buco troppo piccolo per una visione collettiva, vero riassunto di un religioso incontro con Dio (che non può darsi se non singolarmente, motivo per cui il cinema è uno spazio laico per vocazione) - e che coincide con la perdita dell'innocenza: quando si diventa testimoni, quando la manifestazione della divinità sotto forma di evento rivelato a cui non ci si può più sottrarre, impedisce il mantenimento di una posizione equidistante. Ma è un confronto involontario tra la statica atmosfera bimillenaria di San Pietro, dove si fagocita la Storia rendendola piatta ripetizione di se stessa - consentendo così di affrontarla senza emozioni, senza pietà, in modo temporalisticamente atemporale - e l'indicibile sopraffazione emotiva dell'Evento storico che impone di schierarsi.
Ecco, la mancanza dell'emergenza di tutto questo è la delusione del film, che dopo quella verginità persa nei buchi sulla stanza irrorata di Zyklon B perde il gusto della forte tensione spirituale, diventando piatto sermone laico, fatto di frasi che sembrano titoli di giornali, bignami («Hitler ha sconfitto il comunismo in Germania, perciò è diventato un mito per i cattolici») che nella loro incontrovertibilità non aggiungono nulla alla tensione che si poteva ricavare dalla vicenda, inchiodando maggiormente alle loro responsabilità gli alti prelati da sempre proni al potente di turno - sudditanza che per altro non si evince con la dovuta forza - proprio sviscerando quel concetto kierkegaardiano di "spia di dio", solo accennato, lasciato sospeso come se gli autori quando intravedono un possibile argomento degno di approfondimento, recedano di fronte al compito di tradurlo in cinema e preferiscano proseguire il raccontino dell'intreccio di livello più superficiale, abbandonando gli aspetti filosofici con cui condannare non solo politicamente l'operato del papa, ma anche sul piano che più gli competerebbe, quello spirituale; proprio con quel concetto disperato si sarebbe potuto ottenere qualcosa di più della denuncia alle coscienze rese sorde da una fattura troppo cerebrale e artificiosa: si sarebbe ottenuta la condanna della voluta cecità ecclesiale di fronte all'evidenza negata. Quello è il vero peccato, perché lo è anche agli occhi della comunità religiosa: stornare lo sguardo è un crimine che rende complici del misfatto, lo stesso grado di chi nega responsabilità, per aver solo eseguito ordini. Quel «Gente che ha imparato a sottomettere la propria coscienza» è una potente accusa valida in ogni periodo e che richiede uno svolgimento dopo l'enunciazione del titolo, che investa non solo l'aspetto temporale, ma anche quello filosofico e morale, ma le stanze ovattate dal bisogno di seguire il plot costruendo il santino del nazi pentito senza elaborazione interiore sterilizzano in realtà l'operazione che sarebbe meritevole, se creasse un nuovo rito laico per suggerire modalità di incontro con la propria coscienza, ne abbiamo bisogno dopo aver visto dai buchi nei muri le foto di Jenin. Il colpevole silenzio radiofonico del papa risulterebbe assordante se il film sfruttando il duplice percorso offerto dai due protagonisti utilizzasse le sequenze romane per verificare che l'atteggiamento temporale della santa romana chiesa cattolica apostolica paradossalmente non possiede nei suoi fondamenti irreali la capacità di riconoscere la portata morale degli eventi umani, trincerandosi dietro a una ragion di stato millenaristica, che subordina i precetti (e qui sta forse la forza del testo di Hochhuth mancante nella riduzione cinematografica).
|
|
|
|
La madre del pretino di Costa-Gavras compare solo in un ritratto agiografico, come avviene per la madre di Castellitto nel più intenso film di Bellocchio, che ha un altro tratto comune con Amen nell'uso delle panoramiche che danno la cifra dell'untuoso avvolgimento dei modi gesuitici, il regista di Il sogno della farfalla con un parterre di attori eccezionali a tratti raggiunge vette di distacco da quel realismo che ancora consentono all'attenzione di aggrapparsi a quelle situazioni al limite dell'assurdo senza mai farle scivolare nel grottesco (in agguato nell'episodio del duello, come nell'incipit imbarazzante con il figlioletto che parla con Dio, per fortuna prontamente recuperati da geniali sarcasmi conseguenza ultima di quel sorriso a fior di labbra che il pittore - un creatore di illusioni, dunque - ha ereditato dalla madre), preferendo mantenere ampi spazi di credibilità attraverso i quali stigmatizzare ferocemente l'approccio temporale alla spiritualità: Massimo Bernardini infatti, accecato dalla sua fede, non ha capito che il bersaglio degli autori non è la Chiesa, ma la sua riduzione ad apparato e il suo uso simoniaco. Castellitto è una maschera laica schifata dai maneggi di quella palude Stigia che è il Vaticano, in cui finisce con l'essere fatalmente infitto Filippo Argenti, egli si sottrae all'ipocrisia dell'ex iracondo del canto VIII reso mansueto non da Flegias, ma dal miraggio del denaro - come «i ribelli falliti come me» che popolano il film, - un opportunismo adottato come tratto caratteristico che esce fuori da qualsiasi approccio con il mondo ecclesiale. Questo sguardo originale di un sentimento vecchio come la riforma protestante, questo stare a guardare fino alla scopata finale - nella quale si consuma il suo travaglio e la sua ribellione alla famiglia (vecchio pallino dai Pugni in tasca, come riappare il tema del disturbo mentale del vecchio basagliano Matti da slegare - ora rinnegato per eccesso ideologico - e in La balia), ancora più affetta da atmosfera di sacrestia del cardinale - è ciò che conferisce valore al film, poiché cerca di individuare uno sguardo laico, che si sottrae ai lacci della memoria, dell'emozione, della seduzione - falsa - di quel conformismo fatto di «interessi beceri», come li chiama efficacemente Andrea Caramanna in reVision; la scopata è liberatorio allontanamento da quell'appicicaticcio sistema di inghippi e sotterfugi gesuitici, perpetrati senza l'intelligenza degli originali da laici convertiti per interesse a diventare controfigure macchiettistiche di quel mondo di maneggi tipicamente cattolico.
Da ciò ne risulta un'ottima figura per la libertà con cui affronta la situazione anche quando non può più trincerarsi dietro il sorriso enigmatico e canzonatorio che già era della madre: l'atelier, dove consuma liberamente la passione per la splendida Chiara Conti (in effetti impossibile immaginarla insegnante di religione, ma allora chi è? L'angelo custode venuto a salvarlo dalle tentazioni del diavolo travestito da Chiesa?), è una bella risposta all'angoscia indotta nel figlio dalle soffocanti attenzioni della famiglia ("Dio è dappertutto: non sono più libero di stare da solo"). Nel caso dell'illustratore Picciafuoco la religiosità trova spazio nelle pieghe del dubbio agnostico che si converte in sardonico giudizio dei neoconvertiti come dei pelosi abboccamenti con alti prelati nazional-popolari in una delle situazioni di più tipica convivialità: lì Bellocchio ottiene l'immagine summa dell'ipocrisia ecclesiale, quella sfuggita a Costa-Gavras. I due interelocutori ripresi sull'angolo del tavolo con Mefistofele porporato che espone la situazione: è il momento in cui viene nominato il sorrisetto, è quello in cui il pittore rimane con il cappotto, non spezza il pane con l'ospite, si chiude a riccio, subodorando l'inghippo, la congiura. La trappola.
È uno dei film più laici degli ultimi anni, perché suggerisce una via di fuga dall'accerchiamento cui è sottoposto Picciafuoco e questo affrancamento è racchiuso nel rallenti che ha sancito la censura per i giovani: la bestemmia. Hanno ragione i censori: nulla è più liberatorio e il loro ruolo è proprio quello di applicare nuovamente il codice dismesso sotto la spinta della liberazione degli anni settanta. In quel «Porco Dio, porca madonna» c'è la rabbia per l'educazione subita, il disagio per la condizione di confusione e la ribellione. Finalmente si torna a rifiutare i modelli che più fanno comodo, contrapponendo una sana scopata («Innamorarmi è la più grande professione di ateismo»), un urlo degno di Munch, l'iconoclastia sognata nell'animazione (ottimo uso delle potenzialità linguistiche) relativa all'ossessione del Pantheon - casa di tutti gli dei già fatta oggetto di attenzione da Greenaway, - un rapporto serio con un figlio a cui con toni pacati offrire un immaginario non più popolato dai mostri inculcati dall'oscurantismo a cui sta tornando certa controriforma strisciante, che rende meccanismo vacuo il segno della croce, gesto utile per far presa sulle fantasie dei minori, quelle davvero da censurare in quanto turpi manipolazioni delle menti che rimangono turbate per sempre (si pensi a Il quarto uomo di Verhoeven, quando era ancora olandese). Mentre la sua dichiarazione di libertà, come nei dipinti, si esplica «negli spazi inutili e secondari, dove libera il suo talento»; in quel mondo interstiziale Castellitto riesce ad abitare il suo essere sempre altrove («Io devo andare» è il tormentone più ripetuto). Ma soprattutto dove ha diritto di cittadinanza la coerenza. Che è il perno attorno a cui ruota tutta la ricerca, quella che per Costa-Gavras era la rivelazione dell'esistenza dell'orrore, qui diventa il perseguimento di una strada per la scelta della quale non provare mai rimorsi.
Il concetto più volte sbandierato e altrettante rimosso dalle istituzioni ecclesiali di pace con la propria coscienza. Su questo i due film sono correlati, ma un prezzolato come Bernardini non lo capirà mai. Foa, presente nell'inquadratura finale sul televisore volto ad analizzare gli eventi del G8 e della nascita dello stato di polizia alla Bloody Saturday, invece lo capisce benissimo.
|
|
Ma un altro concetto di dolore - sempre di matrice scandinava e riformata - sugli schermi in questi giorni mette alle corde quella presenza di Dio per i credenti meno accettabile: il dispensatore di dolore e lutti di «Italiano per principianti», dove fin dall'inizio si esperisce come una colpa l'assenza di Dio, che nella prima sequenza viene immediatamente nominata negandola («Qui si sente la presenza di Dio», dice la "perpetua" addicted, che ha sostituito Dio alla droga, completando l'anello di questo lungo editoriale) ma la sola traccia di questa presenza fantomatica e terribile è la saliva del parroco, che nella scena più sincera e bella del film nega l'esistenza di un Dio che gli ha ucciso la moglie tra mille tormenti. E questi ultimi - i dolori, il male di vivere avrebbe detto Montale - sono i veri protagonisti di un film ufficialmente "dogmatico". Dove però le inquadrature non sono traballanti e dove i contenuti non sono vecchi, i trucchi dello spontaneismo non sbriciolano visualmente i rapporti umani già smembrati definitivamente da una rabbiosa insofferenza che sostituisce la pietas, anche quando si applica l'eutanasia della madre terminale alcolista.
Qui le panoramiche non avvolgono, ma fanno toccare con lo sguardo la compresenza dei personaggi in un unico spazio: quelle inconsulte sciabolate alla ricerca del parlante non avvolgono, accentuano le dispute. Lo scontro si consuma tra un giovane speranzoso pastore, capace di innamorarsi - come tutti nel film, ampiamente ricambiati dai concupiti - e di stupirsi, e un vecchio pastore convinto che «Noi siamo colpevoli» e per questo nega non solo Dio - che sarebbe il meno - ma anche la possibilità di interpretare le scritture, congelandole in un lungo rosario di dolori; uno psicodramma che non risparmia afrori e vomiti, non riuscendo però a nascondere la presenza della mdp tra i personaggi: è come se non riuscissero mai a dimenticare che da qualche parte deve stare per raccontare e quindi si trova o a pochi centimetri dalle epidermidi o collocata in mezzo ai contendenti a fare da incomodo. Il vero Dio, che documenta e sancisce le morti, gli amori, le palpitazioni, gli incontri e soprattutto i feroci dialoghi che si scambiano quasi in trance (la scommessa vincente è quella di inzuppare il dogma nello stile Kaurismäki. La ricorrenza di situazioni (i tagli di capelli, le lezioni di italiano) sono sintomi della costruzione narrativa aborrita dai seguaci di von Trier, ma proprio in queste ricorrenze si trova la possibilità di porre nuove basi per intessere rapporti.
Anche il corredo di morti fa parte del grottesco, ma il gusto del ridicolo non riesce a cancellare l'angoscia, che trova conferma nelle morti e no ne discende, perché preesiste: è connaturata con l'esistenza e con la consapevolezza che non c'è redenzione, perché «Dio è un'astrazione e non riuscirai a farlo capire», visto che il lutto fa perdere Dio in quanto incomprensibile e sostanzialmente ingiusto, dunque. Ecco siamo passati dall'ipocrisia cattolica al vero rigore giansenista e riformato, dove nemmeno una individuale coerenza fa da baluardo: vince solo la morte, che sottrae qualsiasi speranza.
Poi però l'Italia stereotipata (dopo Ioseliani è il secondo di quest'anno a indugiare su Venezia - forse sulle orme di Thomas Mann), incarnazione del bello - fraintendimento evidente nella mitizzazione della squadra di maledetti gobbi - fa scoccare nuovamente il sentimento di amore collettivo, salvandoci dal cupio dissolvi della ferrea dottrina scandinava."
|
Nel flusso di immagini che continuamente ci attraversa volevo ribadire il rapporto tra carne, intesa come corpo e sesso, da una parte, e dall'altra il cosiddetto spirito. Non è peregrina come chiave di lettura, poiché nei film citati da Adriano è proprio questo ininterrotta interazione tra corpo ed anima (alla Piscicelli dovremmo ripetere sempre Il corpo dell'anima), laddove la sessualità si manifesta insieme all'immagine trascendente, tradizionale o non. O meglio il tradizionale corrisponde all'ipocrisia della dottrina, di tutte le dottrine religiose.
Iconografie, riti sacerdotali, messe, cerimonie, preghiere, rosari, ecc. In Italiano per principianti una delle ultimi immagini ci ricorda quanto vicina sia la dimora dell'anima, non dentro l'edificio, chiesa, ma nella volontà (sincera, laica) e dunque esterna alla ecclesia. L'italiana Giulia chiede a Mortessen di allontanarsi un secondo, per andare in chiesa e decidere sulla proposta di matrimonio. In realtà gira appena l'angolo e poi ritorna subito indietro, ha già deciso per il sì. Questo comportamento è interessante, perché se risponde all'obbligo per la ragazza di "consultarsi" con il divino, dall'altro lo nega, o semplicemente ne riduce il senso poiché la decisione matura quasi immediatamente sgorgando dalla sua scelta volontaria e quindi non dipendente da un consiglio "superiore". Si figura dunque quella sostanziale (nei fatti) assenza di Dio di cui si parlava (anche nel film), infatti il pastore sottolinea che Dio può esserci solo se l'uomo ha fede. E ciò spiega il mutabile atteggiamento del parroco, che manifesta un opinione contro la presenza di Dio, semplicemente perché la sua fede è venuta meno per l'evento luttuoso, la terribile perdita della moglie. Vale a dire che la fede dipende alla fine sempre dal corpo, il corpo malato, agonizzante, che ci è riproposto in una ripetizione di malattie e morti, una di seguito all'altra, davvero grottesca, tanto è vero che si consuma pure quello scherzo della confusione di funerali. Molto più profondo Italiano per principianti di quello che sembra, subito dopo la proiezione, poiché fonda quel principio "laico" di trascendenza nell'avvicinamento dei corpi, non solo tra amanti, ma anche le due sorelle, evitando così i siparietti da commedia romantica, anzi ribadendo tutta la goffaggine del romanticismo. Cinico e goffo potrebbero essere i due aggettivi per leggere in maniera adeguata questo film monco, non scritto, né messo in scena, solo sviluppato attraverso lo scivolamento dei primi piani, di attori bravissimi e anche strafottenti.
|
 Forse nell'editoriale non è giusto parlare ancora di film, ma da due film, L'ora di religione e Italiano per principianti, ci rendiamo conto quanto l'attualità ci proponga invece un rapporto virtuale col corpo, fingendo libertà che non esistono. Adriano infatti sottolinea le liberatorie scopate, e anche le bestemmie come senso di rivolta. Ma il nostro agire quotidiano, di un agire quotidiano in effetti si parla nel film dogma e di Bellocchio, sembra censurato e censurabile, privo di immaginario, cosicché intenderei quella definizione di esempio di gran giornalismo (su revision) data a proposito di L'erba proibita solo a patto di identificare una chiarezza forse inesistente nella sostanza e solo formale (ma già una forma degradata o non più efficace). Mi spiego meglio. L'insofferenza di Adriano nei confronti di quel documentario mi trova parecchio concorde. Forse nell'editoriale non è giusto parlare ancora di film, ma da due film, L'ora di religione e Italiano per principianti, ci rendiamo conto quanto l'attualità ci proponga invece un rapporto virtuale col corpo, fingendo libertà che non esistono. Adriano infatti sottolinea le liberatorie scopate, e anche le bestemmie come senso di rivolta. Ma il nostro agire quotidiano, di un agire quotidiano in effetti si parla nel film dogma e di Bellocchio, sembra censurato e censurabile, privo di immaginario, cosicché intenderei quella definizione di esempio di gran giornalismo (su revision) data a proposito di L'erba proibita solo a patto di identificare una chiarezza forse inesistente nella sostanza e solo formale (ma già una forma degradata o non più efficace). Mi spiego meglio. L'insofferenza di Adriano nei confronti di quel documentario mi trova parecchio concorde.
 
E sono sempre più propenso a considerarla come un difetto grave di immaginazione, e senso di rivolta, o senso di irriverenza, o come il già assimilato "disobbedienza". Il documentario irriverente non può ridursi in una sequenza di immagini appunto "integrate". Avevo fatto l'esempio di quelle testimonianze risibili di alcune vittime, semplici consumatori di marijuana, figure piatte, mi chiedo cosa aggiungano a quello che già si sapeva sulla canapa. Ancora la dimostrazione che basta l'esistenza di un documentario che esponga "l'altra voce" per continuare democraticamente ad accettare anche quella opposta che vuole il proibizionismo, giustificandolo a sua volta non con ideologie ma con dati di fatto.
|


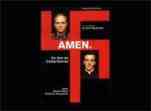








 Forse nell'editoriale non è giusto parlare ancora di film, ma da due film, L'ora di religione e Italiano per principianti, ci rendiamo conto quanto l'attualità ci proponga invece un rapporto virtuale col corpo, fingendo libertà che non esistono. Adriano infatti sottolinea le liberatorie scopate, e anche le bestemmie come senso di rivolta. Ma il nostro agire quotidiano, di un agire quotidiano in effetti si parla nel film dogma e di Bellocchio, sembra censurato e censurabile, privo di immaginario, cosicché intenderei quella definizione di esempio di gran giornalismo (su revision) data a proposito di L'erba proibita solo a patto di identificare una chiarezza forse inesistente nella sostanza e solo formale (ma già una forma degradata o non più efficace). Mi spiego meglio. L'insofferenza di Adriano nei confronti di quel documentario mi trova parecchio concorde.
Forse nell'editoriale non è giusto parlare ancora di film, ma da due film, L'ora di religione e Italiano per principianti, ci rendiamo conto quanto l'attualità ci proponga invece un rapporto virtuale col corpo, fingendo libertà che non esistono. Adriano infatti sottolinea le liberatorie scopate, e anche le bestemmie come senso di rivolta. Ma il nostro agire quotidiano, di un agire quotidiano in effetti si parla nel film dogma e di Bellocchio, sembra censurato e censurabile, privo di immaginario, cosicché intenderei quella definizione di esempio di gran giornalismo (su revision) data a proposito di L'erba proibita solo a patto di identificare una chiarezza forse inesistente nella sostanza e solo formale (ma già una forma degradata o non più efficace). Mi spiego meglio. L'insofferenza di Adriano nei confronti di quel documentario mi trova parecchio concorde.
