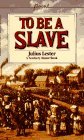|
|
Editoriale
28/9/2001
Mentre il mondo viene distratto da scenari di guerra perseguiti da anni e preparati dai potenti della terra come ultima occasione per perpetuare il sistema di valori agonizzante, chiamato liberismo e noto come feroce ultimo stadio del capitalismo; il cinema, più attento alle tragedie quotidiane di tutto l’Occidente, sembra attratto dall’universo del lavoro, vera vittima di quel pensiero liberale corrottosi con la pratica del potere e la collusione con i trust mondiali. Dalla retorica del lavoro umano al rifiuto di qualunque controllo sul proprio agire professionale, dalla solidarietà spontanea con il collega immigrato al riconoscimento del proprio dramma nella storia di un altro di cui solo il nome coincide, fino a rinnegare l’appartenenza in una prospettiva di sconfitta irrimediabile oppure farsi clandestino a propria volta per salvarsi l’anima, il cinema, saccheggiato nel suo immaginario catastrofista dalle azioni di terroristi e servizi segreti, si ricorda di quante torri gemelle ci vorrebbero per contenere i morti sul lavoro volute da quel sistema che nel WTC trovava il centro direzionale di un mondo che nega la centralità del lavoro per poterlo meglio sfruttare. Il lavoro è il momento catalizzante intere esistenze, la pietra angolare che discrimina gli individui e li compone in categorie: gli "ultimi", quelli destinati a lavori faticosi, oppressi, sfruttati, senza barlumi di speranze per il futuro, alla ricerca di un riscatto Tornando a casa; i "garantiti", fatti scivolare ("scivolo" è il termine usato dal doppiaggio di The Navigators per definire l’indennità di licenziamento che attira nella più pericolosa flessibilità) verso il precariato, il caporalato e la perdita dei diritti attraverso la morte bianca ignominiosamente camuffata (e quello che elimina ogni speranza è il fatto che la messinscena ora sono i colleghi stessi a organizzarla, sostituendosi nel lavoro sporco a quella che normalmente era la ferocia degli apparati aziendali), perdendo se stessi, ridotti a farfugliare scuse; i "professionisti" in carriera, colti da dubbi riguardo alla loro fede e poi riaccompagnati all’ovile da Cantet, ormai esperto a occupare tutti gli spazi di liberazione dal lavoro con nuove teste chine di fronte ai bisogni del mercato e dello sfruttamento; gli "insoddisfatti", che si accorgono dell’inaccettabile vacuità della loro occupazione e cercano un riscatto nel Blue des villes, perseguendo il proprio piacere; finché l’uomo in più si suicida per sottrarsi al gioco di chi decide per lui quale sia il ruolo giusto, ma con la speranza dell’altro uomo in più che rifiuta tutti gli ingaggi giudicandoli insulti (dopo averli lungamente attesi davanti al telefono), recupera la dimensione esatta della propria esistenza e vendica se stesso e l’alter ego, sublimando il rifiuto del lavoro in una cornice popolare e partenopea, tornando così al più rigoroso e ferreo film di Marra, entrambi prevedono ancora un riscatto. Attraverso questi cinque film si attraversano le più importanti problematiche attuali dei lavoratori, globalizzati loro malgrado o spinti a inventarsi nuovi spazi di lavoro, liberati dalla costrizione.
Sintomatico a questo proposito è che la battuta-condanna del padrone ("Questa barca per te è galera e casa") riceva la corretta risposta-ribellione a partire dall’abbandono della barca con un tuffo che non lascerebbe spazio alla speranza, ma avviene in seguito a un impulso generoso: abbandonando la "galera" si trova riscatto e dignità, mentre aggrappandosi al peschereccio — come fa il proprietario — si finisce con il cadere nelle mani della mafia. Solo tagliando di netto ogni rapporto con un lavoro totalizzante, che prosciuga e sottrae completamente il tempo della vita, annullando prospettive diverse da quelle delle lunghissime lontananze dagli affetti ("Ma non ti manca Rosa?"), può miracolosamente avvenire la palingenesi. Ma il lavoro… Rappresentato in tutta la sua totale assenza di poesia (l’unica concessine è la reiterata proposta della scia della barca nel buio, quasi a voler sottolineare un sentiero obbligato nonostante la superficie libera del mare): non ha nulla dei ricordi letterari. Qui ci sono solo quattro disperati che in silenzio, nel buio per sottrarsi ai guardacoste tunisini, con gesti netti, decisi e cadenzati, raccolgono reti e puliscono il pescato velocemente sempre oppressi dalla paura di essere mitragliati nel mare maghrebino. I movimenti di macchina vanno alla ricerca della tensione riconoscibile sui volti preoccupati. Ma il lavoro si capisce che viene inteso come un’interpretazione della parabola dei talenti che Rosa insegna ai bambini e che nella realtà si trasforma in rapporto servo/padrone riprodotto all’infinito: non ci si salva. Non c’è redenzione e il lavoro, si capisce, è una condanna a vita: faticare a faticà. E mentre si profila un perpetuarsi di questa condanna e la prospettiva del suicidio (come nell’Uomo in più) si fa attraente, il destino propone una scomparsa meno ipnotica di quelle a cui ci ha abituato Cantet fin da Les Sanguinaires: la carrellata sui piedi dei migranti ammassati mentre narrano di provenienze (passati atroci) e destinazioni sperate (futuri negati, per ora) diventa umanità a cui aggrapparsi. La fuga dal lavoro è una casualità che consente la fuga altrove, uno spiraglio; un percorso inverso, verso l’Africa.
Si tratta di una seconda tappa del viaggio di naviganti nel mare del lavoro rivoluzionato dalla globalizzazione neo-liberista: Marra vedeva uno spiraglio nella sparizione del pescatore senza diritti e con un’enorme piaga al posto del cuore, Loach piange la sparizione del gruppo di lavoratori che condividono una condizione e possono così opporvisi con l’unione. La fine del sindacalismo di massa e non ancora l’inizio della rivendicazione dei diritti dei precari flessibilizzati si prospetta con il carico di insicurezza, morti bianche e, quel che è peggio, con la progressiva perdita dei valori e di un comportamento etico che era appannaggio del gruppo e non del singolo: quando Mick si ribella, anche da interinale, lo fa chiedendo appoggio ai compagni, che però non sono più un unico corpo, e questo è il motivo — evidenziato dalla regia — per cui viene isolato e, una volta resosi consapevole dell’isolamento e della solitudine, costretto a assumere poi un atteggiamento individualista e addirittura colposo. Rimane in mezzo al guado tra il film a tesi e le intuizioni più appassionate di Piovono pietre: è fedele al suo, giusto — giustissimo! — spunto di ogni lavoro proposto dal regista britannico, il cui scopo essenziale è documentare il rispetto per se stessi delle classi subalterne inserendo ciò che vede nella tradizione labour: con azioni dirette come in Riff Raff e il catartico incendio finale, o con lotte collettive (Bread&Roses); è una prassi che lo vede comporre il riscatto comunque sempre in un’ottica che si muove all’interno dell’ambito voluto e regolato dal capitalismo. In quei rari casi in cui si vince, ciò avviene sempre accettando di confrontarsi sul piano in cui loro dettano le regole: avviene in modo estemporaneo, momentaneo e lo scacco al capitalismo sa di amaro proprio per l’episodicità dell’evento. Si tratta di un mondo di vinti, che fino ad ora riuscivano a trattenere con i denti il rispetto per se stessi attraverso moti di ribellione inani, ora il capitalismo ha sfondato: non c’è riscatto e con la graduale perdita della coscienza di classe si arriva a smarrire la coscienza di sé, alla accettazione della logica avversata da sempre. (... continua ...) Adriano Boano |