|
Nasrallah, Ruiz, Sorrentino e Spielberg:
i quattro angoli del mondo collegati da soglie invisibili sfuggenti trasparenti;
riflessi nell'attrazione esercitata dalla morte sulla forma narrativa
Bab el Shams (La porte du Soleil), Dias de campo, Le conseguenze dell'amore, Terminal
Riflessi in obiettivi d'oro tra i Non luoghi di Marc Augè e il Tristano di Tabucchi
 "Superficie prima e immobile di un corpo che ne circonda un altro o, per essere più chiari, lo spazio in cui un corpo è posto. Ogni corpo occupa il suo luogo. Ma questa occupazione singola ed esclusiva somiglia più a quella del cadavere nella sua tomba che non a quella del corpo che nasce o vive". "Superficie prima e immobile di un corpo che ne circonda un altro o, per essere più chiari, lo spazio in cui un corpo è posto. Ogni corpo occupa il suo luogo. Ma questa occupazione singola ed esclusiva somiglia più a quella del cadavere nella sua tomba che non a quella del corpo che nasce o vive".
(Marc Augè, Non luoghi. Introduzione a una antropologia della surmodernità, Elèuthera, Milano 1993, p. 52)
 Tre film diversissimi per autore, provenienza, destinazione d'uso, genere e successo ultimamente si mantengono sullo stesso crinale verso soluzioni irriconducibili tra loro, ma con lo stesso uso dello spazio ingombro di limiti trasparenti invalicabili e con la stessa pulsione a varcarne la soglia: in tutti e tre si supera la concezione dell'Angelo sterminatore buñueliano, perché anche ciò che sta al di là è ben presente e la dimensione claustrofobica non interviene come dato oppressivo insostenibile, ma è una condizione che non prostra, piuttosto inquieta il passaggio attraverso riflessi, immagini virtuali, telecamere, vetri infrangibili... e in tutti e tre i casi i diaframmi trasparenti appaiono assumere valenze differenti. Tre film diversissimi per autore, provenienza, destinazione d'uso, genere e successo ultimamente si mantengono sullo stesso crinale verso soluzioni irriconducibili tra loro, ma con lo stesso uso dello spazio ingombro di limiti trasparenti invalicabili e con la stessa pulsione a varcarne la soglia: in tutti e tre si supera la concezione dell'Angelo sterminatore buñueliano, perché anche ciò che sta al di là è ben presente e la dimensione claustrofobica non interviene come dato oppressivo insostenibile, ma è una condizione che non prostra, piuttosto inquieta il passaggio attraverso riflessi, immagini virtuali, telecamere, vetri infrangibili... e in tutti e tre i casi i diaframmi trasparenti appaiono assumere valenze differenti.
A questi si aggiunge un affresco di storia palestinese, dove la soglia non è solo nel titolo, ma è chiusa irrimediabilmente alla fine: il sole non passa più, i mondi non sono più collegati.
Uno è il notevole film di Spielberg, poco compreso giustappunto perché non si è conferito il dovuto rilievo proprio alle soglie che lo costellano, nonostante il film sia fatto di inquadrature e queste a loro volta siano - quasi per forza - rimpinguate da porte scorrevoli, telecamere che rimandano ad altri mondi virtuali, ma autocentrati, specchi che lasciano immaginare l'esterno senza permettere di esperirlo.  Persino il mcguffin, il pretesto del film: la scatola di fotografie deve arrivare a comporre un universo che si era costituito altrove in un tempo diverso, e anche quello, come in uno specchio deformante, è frutto dello specchio musicale a cui si attribuisce un valore che nella realtà non si trova... ebbene anche quel contenitore di noccioline è una porta sul mondo vero che non si è aperta prima della morte del padre del protagonista, una sorta di bara per un sogno, un impegno totalizzante una vita. E così quell'espediente si ammanta di un'aura rituale di tristezza e di operazione di lutto, rimanendo racconto, storia da raccontare al di qua del coperchio, unica soglia apparentemente non trasparente, salvo poi trovare evidenze "trasparenti" nella fotografia di gruppo. "Sussiste oggi qualcosa del fascino incerto dei terreni incolti, delle sodaglie e degli scali, dei marciapiedi di stazione e delle sale d'attesa dove i passi si perdono, di tutti i luoghi dell'incontro fortuito dove si può provare fuggevolmente la possibilità dell'avventura [Zeta Jones], la sensazione che c'è solo da "veder cosa succede"?" (Augè, Non luoghi cit, p. 9) Persino il mcguffin, il pretesto del film: la scatola di fotografie deve arrivare a comporre un universo che si era costituito altrove in un tempo diverso, e anche quello, come in uno specchio deformante, è frutto dello specchio musicale a cui si attribuisce un valore che nella realtà non si trova... ebbene anche quel contenitore di noccioline è una porta sul mondo vero che non si è aperta prima della morte del padre del protagonista, una sorta di bara per un sogno, un impegno totalizzante una vita. E così quell'espediente si ammanta di un'aura rituale di tristezza e di operazione di lutto, rimanendo racconto, storia da raccontare al di qua del coperchio, unica soglia apparentemente non trasparente, salvo poi trovare evidenze "trasparenti" nella fotografia di gruppo. "Sussiste oggi qualcosa del fascino incerto dei terreni incolti, delle sodaglie e degli scali, dei marciapiedi di stazione e delle sale d'attesa dove i passi si perdono, di tutti i luoghi dell'incontro fortuito dove si può provare fuggevolmente la possibilità dell'avventura [Zeta Jones], la sensazione che c'è solo da "veder cosa succede"?" (Augè, Non luoghi cit, p. 9)

 Già solo "vedere" rimanendo invisibili, cominciare a capire i meccanismi del gioco, significa comprendere dove sono i buchi nell'involucro trasparente; come fa l'inserviente indiano (che però così ritroverà la propria consapevolezza di migrante)... invece il protagonista procede nella sua lotta contro il potere ottuso e burocratico nel suo arroccamento antimigrazione in modo diverso: è sovraesposto in ogni telecamera, e questa è l'anomalia per il non luogo, disabituato all'invisibile, o meglio: suscettibile solo alle disparità, alle figure che nello specchio mantengono uno spessore non riconducibile a uno stereotipo rassicurante, perché conosciuto. Altra anomalia è che agisca fuori dalle regole e soprattutto insegni la dignità che esula sempre dalla burocrazia che la sottomette come suo primo obiettivo, quella dignità che emancipa dalle procedure, fredde insensibili e fondate sulla presunzione di autorità. Già solo "vedere" rimanendo invisibili, cominciare a capire i meccanismi del gioco, significa comprendere dove sono i buchi nell'involucro trasparente; come fa l'inserviente indiano (che però così ritroverà la propria consapevolezza di migrante)... invece il protagonista procede nella sua lotta contro il potere ottuso e burocratico nel suo arroccamento antimigrazione in modo diverso: è sovraesposto in ogni telecamera, e questa è l'anomalia per il non luogo, disabituato all'invisibile, o meglio: suscettibile solo alle disparità, alle figure che nello specchio mantengono uno spessore non riconducibile a uno stereotipo rassicurante, perché conosciuto. Altra anomalia è che agisca fuori dalle regole e soprattutto insegni la dignità che esula sempre dalla burocrazia che la sottomette come suo primo obiettivo, quella dignità che emancipa dalle procedure, fredde insensibili e fondate sulla presunzione di autorità.  Quella autorità che preclude le frontiere, simboleggiate dalle opulente porte scorrevoli che lasciano vedere il mondo lì fuori, permettono di indovinare il modo in cui si potrebbe coronare il sogno del padre jazzofilo e il suo strano modo di ritessere la memoria, ricostruendo un'immagine, da cui scaturisce il romanzo... Addirittura dare una testa, un volto ai manichini nelle vetrine attraverso il riflesso: il massimo della provocazione: prendere possesso dei luoghi effimeri e per antonomasia impalpabili - quindi non espropriabili: vera spesa proletaria - e conferirgli il proprio gusto. Quella autorità che preclude le frontiere, simboleggiate dalle opulente porte scorrevoli che lasciano vedere il mondo lì fuori, permettono di indovinare il modo in cui si potrebbe coronare il sogno del padre jazzofilo e il suo strano modo di ritessere la memoria, ricostruendo un'immagine, da cui scaturisce il romanzo... Addirittura dare una testa, un volto ai manichini nelle vetrine attraverso il riflesso: il massimo della provocazione: prendere possesso dei luoghi effimeri e per antonomasia impalpabili - quindi non espropriabili: vera spesa proletaria - e conferirgli il proprio gusto.
Lo sguardo attraverso le porte e i vari diaframmi, frapposti tra noi e l'universo del cittadino sospeso tra due frontiere - entrambe precluse -, si mantiene costantemente "dall'altra parte" a rendere palpabile la presenza del muro invisibile: lo vediamo sempre al di là di "contenitori" di vetro e plastica (a volte le infinite scatole che lo rinchiudono si moltiplicano come babuške, come nel caso del connazionale pizzicato con pillole proibite) che lo collocano per la nostra percezione di spettatori come in un acquario, al di là di tutte quelle superfici ingannevoli, che fanno apparire la società americana come appetibile, mentre invece può soltanto essere funzionale al compimento di un sogno lungo un giorno, in cui l'ultima firma giustapposta alla fotografia completerà quel mondo. Solo che noi, o meglio il nostro sguardo è collocato inconsapevolmente sull'altro lato della porta scorrevole. che lo collocano per la nostra percezione di spettatori come in un acquario, al di là di tutte quelle superfici ingannevoli, che fanno apparire la società americana come appetibile, mentre invece può soltanto essere funzionale al compimento di un sogno lungo un giorno, in cui l'ultima firma giustapposta alla fotografia completerà quel mondo. Solo che noi, o meglio il nostro sguardo è collocato inconsapevolmente sull'altro lato della porta scorrevole.
L'altra pellicola della strana accoppiata è il film di Paolo Sorrentino, Le conseguenze dell'amore, dove le superfici riflettenti non sono tanto trasparenti sull'esterno, piuttosto preferiscono sfocare l'immagine non in campo, isolando nella sua claustrofobica solitudine il faccendiere.

In questo caso lo sguardo dello spettatore condivide gli spazi abitati da Servillo: quello che le superfici dividono rimane assolutamente distinto, inavvicinabile come la splendida cameriera, nonostante lei si offra, proprio come la realtà al di là della vetrina - però Servillo non la capisce, o per lo meno la interpreta in modo errato: lei non è accompagnata da molti amanti, ma da parenti e amici. Tutto tende a diventare una tombale opacità come quella degli infiniti ascensori, avvolti da superfici che non riflettono più nulla, se non ombre opacizzate dai materiali, anche se sono metallici e quindi dovrebbero restituire una qualche immagine riflessa, ma - proprio perché lo sguardo all'esterno è vacuo e poco interessato - tutto viene catturato, assorbito, inglobato, escluso dall'"esterno", anche le ombre, anche i riflessi, tranne l'avvenente figura della ragazza, che gli specchi dietro al bancone del bar rimandano in frammenti e le vetrine ritagliano dalla strada: infatti lei diventa l'unica ancora per ritrovare il "fuori" dall'albergo ticinese. Il resto è ripreso come se nessun gioco di specchi potesse lasciar uscire l'immaginazione intrappolata nell'albergo... o nel pilastro di cemento, che sancisce l'impossibilità di varcare la soglia e dimostra il legame tra impossibilità di superare quella soglia, di liberarsi dei limiti - innanzitutto architettonici, e poi mentali - per superare l'inibizione derivante dal raccontare la morte, anticipata dallo stato di recluso e dall'invalicabilità delle superfici che allontanano il mondo sia quando, come in Sorrentino, fanno dell'opacità la distanza dall'esterno (l'altro lato del confine), sia quando come in Terminal quel limite si evidenzia nella più cristallina trasparenza, altrettanto insuperabile. Tutto tende a diventare una tombale opacità come quella degli infiniti ascensori, avvolti da superfici che non riflettono più nulla, se non ombre opacizzate dai materiali, anche se sono metallici e quindi dovrebbero restituire una qualche immagine riflessa, ma - proprio perché lo sguardo all'esterno è vacuo e poco interessato - tutto viene catturato, assorbito, inglobato, escluso dall'"esterno", anche le ombre, anche i riflessi, tranne l'avvenente figura della ragazza, che gli specchi dietro al bancone del bar rimandano in frammenti e le vetrine ritagliano dalla strada: infatti lei diventa l'unica ancora per ritrovare il "fuori" dall'albergo ticinese. Il resto è ripreso come se nessun gioco di specchi potesse lasciar uscire l'immaginazione intrappolata nell'albergo... o nel pilastro di cemento, che sancisce l'impossibilità di varcare la soglia e dimostra il legame tra impossibilità di superare quella soglia, di liberarsi dei limiti - innanzitutto architettonici, e poi mentali - per superare l'inibizione derivante dal raccontare la morte, anticipata dallo stato di recluso e dall'invalicabilità delle superfici che allontanano il mondo sia quando, come in Sorrentino, fanno dell'opacità la distanza dall'esterno (l'altro lato del confine), sia quando come in Terminal quel limite si evidenzia nella più cristallina trasparenza, altrettanto insuperabile.
Ma il contributo più importante all'arte della superficie trasparente e che rende a questo punto più evidente l'apporto narrativo dell'uso smodato di riflessi e vetri nel film è offerto da Ruiz in Dias de campo: qui quei materiali che lasciano passare lo sguardo, anche artisticamente deformanti e popolati da figure ectoplasmatiche, si frappongono tra universi ma non sono invalicabili, nonostante siano posti tra ambito della "vita" e spazio dei "morti", fino a renderli intercambiabili nella narrazione frammentata e mescolata nella decostruzione del racconto.  Concludendo questa trilogia di vetri, si potrebbe dire che Ruiz offre un punto di vista che in parte spiega i due precedenti, accentuando il livello di indefinitezza legata a questi diaframmi diafani, mentre dall'altro li lega alla pulsione a porre al centro un personaggio che conosciamo anziano, percorre la memoria - per esaudire una nostra urgenza in questo senso - e muore, come avviene negli ultimi lavori di Tabucchi, Eco, Orengo... quasi che in punto di morte si riveda davvero la vita almeno a frammenti. Soltanto... in questo caso la sua morte è annunciata all'inizio e poi si insegue per tutto il film al di là dei tramezzi trasparenti. Concludendo questa trilogia di vetri, si potrebbe dire che Ruiz offre un punto di vista che in parte spiega i due precedenti, accentuando il livello di indefinitezza legata a questi diaframmi diafani, mentre dall'altro li lega alla pulsione a porre al centro un personaggio che conosciamo anziano, percorre la memoria - per esaudire una nostra urgenza in questo senso - e muore, come avviene negli ultimi lavori di Tabucchi, Eco, Orengo... quasi che in punto di morte si riveda davvero la vita almeno a frammenti. Soltanto... in questo caso la sua morte è annunciata all'inizio e poi si insegue per tutto il film al di là dei tramezzi trasparenti.
Stessa cosa avviene nel capolavoro di Nasrallah Bab el Shams, dove l'agonia di Younes fa da sfondo all'impellente bisogno di ritessere la storia della infinita Nakba (un Heimat dell'atroce diaspora palestinese, inaccettabile per chiunque non sia faziosamente - e ideologicamente - schierato a favore degli interessi dell'integralismo sionista, nascosto sotto la coperta della presunta democrazia), salvo poi scoprire che le vicissitudini dell'eroe sono la componente epica di ben più significativi racconti al femminile di resistenza e salvaguardia della cultura, solo visti dall'altra parte della soglia, sull'altro lato del confine; e stavolta il confine è di quelli più escludenti.  Colpisce a distanza di pochi giorni dall'agonia di Arafat vedere sullo schermo una situazione simile corredata dagli stessi travagli, ma soprattutto al nostro discorso interessa da un lato il fatto che il regista egiziano affronti il tema del momento della morte vissuto come occasione per fare un consuntivo utile come memoria, sollecitata da chi la raccoglie (quasi un "essere per la morte" heideggeriano, che ammanta di tragico il formalismo derridiano di Ruiz) e dall'altro sorprende per quella Porta (il titolo del film è La porta del sole): cioè l'ennesima soglia incantata che protegge gli incontri del fedayyn esiliato in Libano con la moglie rimasta nei Territori occupati. Colpisce a distanza di pochi giorni dall'agonia di Arafat vedere sullo schermo una situazione simile corredata dagli stessi travagli, ma soprattutto al nostro discorso interessa da un lato il fatto che il regista egiziano affronti il tema del momento della morte vissuto come occasione per fare un consuntivo utile come memoria, sollecitata da chi la raccoglie (quasi un "essere per la morte" heideggeriano, che ammanta di tragico il formalismo derridiano di Ruiz) e dall'altro sorprende per quella Porta (il titolo del film è La porta del sole): cioè l'ennesima soglia incantata che protegge gli incontri del fedayyn esiliato in Libano con la moglie rimasta nei Territori occupati.
Non ci sono più gli artifizi trasparenti di Spielberg, e lo spazio agito non è più quello di Sorrentino, pur rimanendo in più riprese la claustrofobia dell'imposizione, il panico di chi è preso in trappola soprattutto con i propri fantasmi, ma quella grotta sul cui limite tutto cambia e si lascia penetrare dai racconti eroici del moujaydin alla sua sposa, diventa uno spazio da Mille e una notte: la roccia diventa permeabile alle storie e - per quanto lo spazio sia demarcato al punto che l'interno è preparato da petali e candele in modo da esaltarne la differenza con l'esterno - si fa spazio in cui si sacralizza il rito del tramandare il mito epico (lo dice anche esplicitamente Khalil al corpo in coma: "I tuoi tempi erano eroici, mitici. I nostri non hanno più nulla di eroico") senza dimenticare che l'amore è un altro approccio al mito e... al racconto della morte.
Ma soprattutto diventa uno spazio a cui si contrappone quell'altro a pochi passi, sotto - quasi "dentro" - un ulivo che risale all'epoca romana (poi ripreso dal destinatario della lettera finale, che evoca l'antica Roma per segnalare il legame con l'epilogo), dove la donna racconta - fuori dalla grotta che pure è a pochi passi - la propria storia di eroismo quotidiano, di violenze sioniste, di lotta per la sopravvivenza della numerosa famiglia: i 7 (numero biblicamente significativo) figli dànno alla luce almeno un figlio che si chiama Younes e questi sette nipoti verranno chiamati a chiudere la soglia alla morte di Younes, "finché non tornerà", ottenendo la sovrapposizione di Mr Palestine con la sua terra.  Nahila, la sposa non ha bisogno di epici racconti in una cornice, lei è già la Palestina e lo è anche Shams, la ragazza di Khalil, uccisa per vendetta dopo che ha ammazzato un'amante che l'aveva ingannata, la cui storia evidenzia l'altro destino delle donne palestinesi: guerrigliera e, prima, moglie sottomessa a un bruto maschilista; ribelle e, poi, ancora vittima della struttura tribale, militante Olp solo dopo essersi emancipata come donna e, in quanto donna, ricacciata tra i reprobi. Nahila, la sposa non ha bisogno di epici racconti in una cornice, lei è già la Palestina e lo è anche Shams, la ragazza di Khalil, uccisa per vendetta dopo che ha ammazzato un'amante che l'aveva ingannata, la cui storia evidenzia l'altro destino delle donne palestinesi: guerrigliera e, prima, moglie sottomessa a un bruto maschilista; ribelle e, poi, ancora vittima della struttura tribale, militante Olp solo dopo essersi emancipata come donna e, in quanto donna, ricacciata tra i reprobi.
 I racconti dello "specchio" (trasformato in grotta incantata) si ritagliano una loro indipendenza dal contesto politico, che li rende possibili e che viene suggestivamente e passionalmente riproposto in un tripudio di bandiere e armi e volontà di rivolta e resistenza dal regista, il quale dimostra una capacità di giudizio assolutamente indipendente: non verrà distribuito in un Occidente impaurito dall'Altro e che ha abbracciato ciecamente la censura della storia dei crimini sionisti, non lo sarà sicuramente in Israele - uno stato razzista, integralista e terrorista - e nemmeno i fedifraghi arabi, che appoggiano la lotta palestinese senza amare i palestinesi, non lo accoglieranno nelle loro sale, eppure è un film lucidissimo sugli eventi susseguitisi dal 15 maggio 1948, forse perché fa uso di quell'infinità di soglie senza quasi mostrarle, solo alludendovi con quella luce solare di una grotta pronta a riaprirsi. I racconti dello "specchio" (trasformato in grotta incantata) si ritagliano una loro indipendenza dal contesto politico, che li rende possibili e che viene suggestivamente e passionalmente riproposto in un tripudio di bandiere e armi e volontà di rivolta e resistenza dal regista, il quale dimostra una capacità di giudizio assolutamente indipendente: non verrà distribuito in un Occidente impaurito dall'Altro e che ha abbracciato ciecamente la censura della storia dei crimini sionisti, non lo sarà sicuramente in Israele - uno stato razzista, integralista e terrorista - e nemmeno i fedifraghi arabi, che appoggiano la lotta palestinese senza amare i palestinesi, non lo accoglieranno nelle loro sale, eppure è un film lucidissimo sugli eventi susseguitisi dal 15 maggio 1948, forse perché fa uso di quell'infinità di soglie senza quasi mostrarle, solo alludendovi con quella luce solare di una grotta pronta a riaprirsi.  Ma ora avvolta dalle tenebre per l'intervento di una figura femminile che sdoppia le fattezze di Shams, uccisa, con quelle di Nahila, scomparsa, facendo entrare in scena una fantomatica figura velata, che alle arance dell'inizio sostituisce un formaggio, talismano altrettanto utile per entrare in sintonia con la propria terra usurpata. Ma ora avvolta dalle tenebre per l'intervento di una figura femminile che sdoppia le fattezze di Shams, uccisa, con quelle di Nahila, scomparsa, facendo entrare in scena una fantomatica figura velata, che alle arance dell'inizio sostituisce un formaggio, talismano altrettanto utile per entrare in sintonia con la propria terra usurpata.
Usando figure alla stessa stregua ambigue, formate da figure molteplici incontrate nel film stesso, e con caratteristiche attribuibili a personaggi diversi e che servono a confondere i piani e gli spazi, collocando l'intreccio ora da un lato, ora dall'altro dell'uscio lasciato socchiuso alla macchina da presa che registra i riflessi sui vetri, Ruiz confeziona un film che rimedita sulla soglia, ancora una volta sul limite che mette in comunicazione due mondi in un bagno surreale. Questa volta però la soglia è quella della morte non soltanto quella del non-luogo aeroportuale o dell'albergo dove si sospende la vita tra una valigia (di soldi) e l'altra. O meglio in Ruiz si coglie il tentativo di investigare quel momento che segna l'esserci e... di contro l'esserci in una dimensione diversa, di morte o forse - meglio - di consapevolezza della morte, ovvero un non-esserci che mantiene in parte qualche caratteristica dell'entità. Un tassello in più alle sue infinite storie di attività onirica intrecciate a "realtà" destrutturata e di nuovo la sovraesposizione segnala differenze, forse in quei casi si tratta di inscenare un sogno di un sogno, ma potrebbe essere quella la realtà di partenza. Come sempre a tratti ironico e molto sottile, il regista cileno si diverte a contrappuntare il tema con dialoghi surreali che "giocano" con le situazioni di vita e morte, spesso semplicemente collocando in luoghi e tempi adiacenti nella diegesi situazioni distanti nel tempo (richiamate da splendidi montaggi, agganciati da parole riprese o da richiami formali, come gocce che travalicano frontiere narrative e temporali e continuano "infiltrazioni erranti") o - spesso - attraverso l'attività esplicitamente onirica, che destruttura il racconto mescolando piani temporali infiniti che vincono il momento di divisione tra vita e morte (la radio che ripete ossessiva: "lo scrittore è morto", che è sì il protagonista, ma anche l'autore stesso), tra esistenza e racconto. Come sempre a tratti ironico e molto sottile, il regista cileno si diverte a contrappuntare il tema con dialoghi surreali che "giocano" con le situazioni di vita e morte, spesso semplicemente collocando in luoghi e tempi adiacenti nella diegesi situazioni distanti nel tempo (richiamate da splendidi montaggi, agganciati da parole riprese o da richiami formali, come gocce che travalicano frontiere narrative e temporali e continuano "infiltrazioni erranti") o - spesso - attraverso l'attività esplicitamente onirica, che destruttura il racconto mescolando piani temporali infiniti che vincono il momento di divisione tra vita e morte (la radio che ripete ossessiva: "lo scrittore è morto", che è sì il protagonista, ma anche l'autore stesso), tra esistenza e racconto.
 Proprio le gocce sono utili a capire quanta parte abbia la fantasia in questo gioco di specchi surreali, che come tali fungono da passaggio tra l'aldiqua e l'aldilà: anche le gocce ne fanno parte in quanto "non arrivano da nessuna parte", cadono su una radio (forse quella dell'annuncio di morte: "I morti non sognano, questo vi dico. I defunti sognano soltanto nelle notti di pioggia. Per il resto sono sognati", dice Ermelindo Mucanga, un morto che sta Sotto l'albero del Frangipani di Mia Couto), riapparendo in un cortile di un altro tempo, ma rimanendo al centro della conversazione: sembra che continuino un discorso, ma in realtà fanno parte dell'alea che ammanta il romanzo che si va dipanando al di là dei vetri. Proprio le gocce sono utili a capire quanta parte abbia la fantasia in questo gioco di specchi surreali, che come tali fungono da passaggio tra l'aldiqua e l'aldilà: anche le gocce ne fanno parte in quanto "non arrivano da nessuna parte", cadono su una radio (forse quella dell'annuncio di morte: "I morti non sognano, questo vi dico. I defunti sognano soltanto nelle notti di pioggia. Per il resto sono sognati", dice Ermelindo Mucanga, un morto che sta Sotto l'albero del Frangipani di Mia Couto), riapparendo in un cortile di un altro tempo, ma rimanendo al centro della conversazione: sembra che continuino un discorso, ma in realtà fanno parte dell'alea che ammanta il romanzo che si va dipanando al di là dei vetri.
L'altro tormentone del film che si colloca nella stessa direzione di esporre la difficoltà di esprimere la soglia senza averla esperita (e quando la si esperisce diventa arduo poterla comunicare) è la consueta - per i film del regista cileno - battuta ripetitiva che si trova in ogni film di Ruiz, in questo caso tocca a "Come va la novella?"... un'altra soglia tra detto e mostrato: l'immagine si fa pagina scritta trasformandosi sotto i nostri occhi (infatti vediamo dapprima il protagonista da giovane che si accinge a scrivere e poi da sotto il foglio comincia a prendere forma lo scritto fino a venire in primo piano e poi offuscare l'immagine evidenziando lo scritto), ma il romanzo che nei decenni non si finisce di raccontare è quella storia che è dovuta alla protagonista, che si era ritrovata in vita al mattino successivo alla sua morte.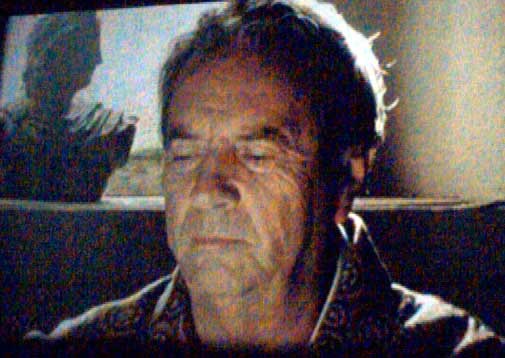 Laddove la scienza non può arrivare, subentra il romanzo, il palliativo del riflesso illuminante, il succedaneo del vetro che ci invita al di là... che però non riesce a formarsi, rimanendo evocato al di qua dei vetri, riflesso da specchi infiniti, mediato da superfici che si frappongono a dividere senza per questo essere diaframmi definitivi, come se la Recherche non possa mai concludersi, perché il romanzo può vedere dall'altra parte, può anche descrivere il mondo dall'altro lato dello specchio, ma non lo può abitare, ottenendo di poter solo far percepire la sensazione di quella soglia, senza mai nasconderla definitvamente o consentirne il disvelamento, appunto quel posto definitivo nell'indefinito. Laddove la scienza non può arrivare, subentra il romanzo, il palliativo del riflesso illuminante, il succedaneo del vetro che ci invita al di là... che però non riesce a formarsi, rimanendo evocato al di qua dei vetri, riflesso da specchi infiniti, mediato da superfici che si frappongono a dividere senza per questo essere diaframmi definitivi, come se la Recherche non possa mai concludersi, perché il romanzo può vedere dall'altra parte, può anche descrivere il mondo dall'altro lato dello specchio, ma non lo può abitare, ottenendo di poter solo far percepire la sensazione di quella soglia, senza mai nasconderla definitvamente o consentirne il disvelamento, appunto quel posto definitivo nell'indefinito.
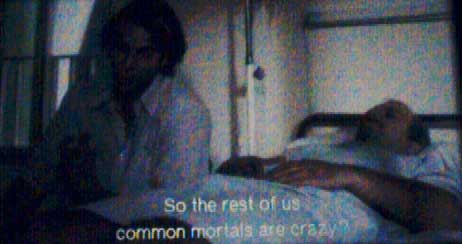 "Mi pare che ci sia ancora il moscone, lo faccia uscire, non voglio che mi si posi sulla bocca quando l'avrò chiusa. Quando scriverà questa storia, se ne farà un libro, sul libro ci metta il suo nome, il mio non ce lo voglio, non voglio esser quello che racconta, voglio essere raccontato... Lei una volta ha scritto che Tristano conobbe la paura e io l'ho confermato. Ma la vera paura è un'altra, quella era una paura da poco, perché aveva il privlegio dell'aleatorio, poteva andargli male, ma poteva anche cavarci le gambe... La vera paura è quando l'ora è fissata e sai che sarà inevitabile... è una strana paura, insolita, si prova una volta sola nella vita, e non si proverà mai più, è come una vertigine, come se si spalancasse una finestra sul niente, e lì il pensiero si annega davvero, come se si annientasse. È questa la vera paura... Fra poco, quando non sentirà più il mio respiro, spalanchi quella finestra, lasci entrare la luce e i rumori del mondo vivo, appartengono a lei, il silenzio è mio. E vada subito via,chiuda la porta e lasci qui il cadavere, quello non sono io, ho già dato disposizioni alla Frau per sbarazzarsene in fretta... C'è un amore religioso della morte che ha qualcosa di necrofilo, quasi che si amasse di più un cadavere di un vivo... Una bella morte... che sciocchezza, la morte non è mai bella, la morte è laida, sempre, è la negazione della vita... Dicono che la morte è un mistero, ma il fatto di essere esistito è un mistero maggiore, apparentemente è banale, e invece è così misterioso... Sa, per esempio il fatto che lei e io ci troviamo qui, nella stessa stanza, in questo preciso momento, è molto misterioso, o comunque abbastanza singolare, non le pare?... La ringrazio... " "Mi pare che ci sia ancora il moscone, lo faccia uscire, non voglio che mi si posi sulla bocca quando l'avrò chiusa. Quando scriverà questa storia, se ne farà un libro, sul libro ci metta il suo nome, il mio non ce lo voglio, non voglio esser quello che racconta, voglio essere raccontato... Lei una volta ha scritto che Tristano conobbe la paura e io l'ho confermato. Ma la vera paura è un'altra, quella era una paura da poco, perché aveva il privlegio dell'aleatorio, poteva andargli male, ma poteva anche cavarci le gambe... La vera paura è quando l'ora è fissata e sai che sarà inevitabile... è una strana paura, insolita, si prova una volta sola nella vita, e non si proverà mai più, è come una vertigine, come se si spalancasse una finestra sul niente, e lì il pensiero si annega davvero, come se si annientasse. È questa la vera paura... Fra poco, quando non sentirà più il mio respiro, spalanchi quella finestra, lasci entrare la luce e i rumori del mondo vivo, appartengono a lei, il silenzio è mio. E vada subito via,chiuda la porta e lasci qui il cadavere, quello non sono io, ho già dato disposizioni alla Frau per sbarazzarsene in fretta... C'è un amore religioso della morte che ha qualcosa di necrofilo, quasi che si amasse di più un cadavere di un vivo... Una bella morte... che sciocchezza, la morte non è mai bella, la morte è laida, sempre, è la negazione della vita... Dicono che la morte è un mistero, ma il fatto di essere esistito è un mistero maggiore, apparentemente è banale, e invece è così misterioso... Sa, per esempio il fatto che lei e io ci troviamo qui, nella stessa stanza, in questo preciso momento, è molto misterioso, o comunque abbastanza singolare, non le pare?... La ringrazio... "
(Antonio Tabucchi, Tristano muore, Feltrinelli, Milano 2004, p. 161)
|


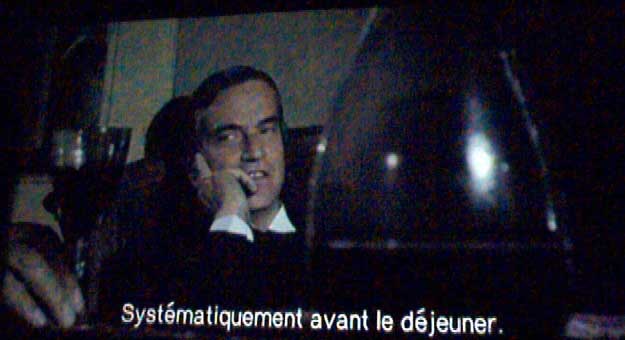

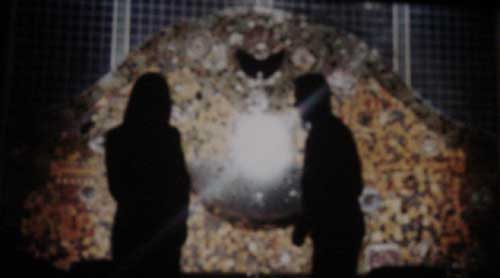
 "Superficie prima e immobile di un corpo che ne circonda un altro o, per essere più chiari, lo spazio in cui un corpo è posto. Ogni corpo occupa il suo luogo. Ma questa occupazione singola ed esclusiva somiglia più a quella del cadavere nella sua tomba che non a quella del corpo che nasce o vive".
"Superficie prima e immobile di un corpo che ne circonda un altro o, per essere più chiari, lo spazio in cui un corpo è posto. Ogni corpo occupa il suo luogo. Ma questa occupazione singola ed esclusiva somiglia più a quella del cadavere nella sua tomba che non a quella del corpo che nasce o vive". Tre film diversissimi per autore, provenienza, destinazione d'uso, genere e successo ultimamente si mantengono sullo stesso crinale verso soluzioni irriconducibili tra loro, ma con lo stesso uso dello spazio ingombro di limiti trasparenti invalicabili e con la stessa pulsione a varcarne la soglia: in tutti e tre si supera la concezione dell'Angelo sterminatore buñueliano, perché anche ciò che sta al di là è ben presente e la dimensione claustrofobica non interviene come dato oppressivo insostenibile, ma è una condizione che non prostra, piuttosto inquieta il passaggio attraverso riflessi, immagini virtuali, telecamere, vetri infrangibili... e in tutti e tre i casi i diaframmi trasparenti appaiono assumere valenze differenti.
Tre film diversissimi per autore, provenienza, destinazione d'uso, genere e successo ultimamente si mantengono sullo stesso crinale verso soluzioni irriconducibili tra loro, ma con lo stesso uso dello spazio ingombro di limiti trasparenti invalicabili e con la stessa pulsione a varcarne la soglia: in tutti e tre si supera la concezione dell'Angelo sterminatore buñueliano, perché anche ciò che sta al di là è ben presente e la dimensione claustrofobica non interviene come dato oppressivo insostenibile, ma è una condizione che non prostra, piuttosto inquieta il passaggio attraverso riflessi, immagini virtuali, telecamere, vetri infrangibili... e in tutti e tre i casi i diaframmi trasparenti appaiono assumere valenze differenti.

 Persino il mcguffin, il pretesto del film: la scatola di fotografie deve arrivare a comporre un universo che si era costituito altrove in un tempo diverso, e anche quello, come in uno specchio deformante, è frutto dello specchio musicale a cui si attribuisce un valore che nella realtà non si trova... ebbene anche quel contenitore di noccioline è una porta sul mondo vero che non si è aperta prima della morte del padre del protagonista, una sorta di bara per un sogno, un impegno totalizzante una vita. E così quell'espediente si ammanta di un'aura rituale di tristezza e di operazione di lutto, rimanendo racconto, storia da raccontare al di qua del coperchio, unica soglia apparentemente non trasparente, salvo poi trovare evidenze "trasparenti" nella fotografia di gruppo. "Sussiste oggi qualcosa del fascino incerto dei terreni incolti, delle sodaglie e degli scali, dei marciapiedi di stazione e delle sale d'attesa dove i passi si perdono, di tutti i luoghi dell'incontro fortuito dove si può provare fuggevolmente la possibilità dell'avventura [Zeta Jones], la sensazione che c'è solo da "veder cosa succede"?" (Augè, Non luoghi cit, p. 9)
Persino il mcguffin, il pretesto del film: la scatola di fotografie deve arrivare a comporre un universo che si era costituito altrove in un tempo diverso, e anche quello, come in uno specchio deformante, è frutto dello specchio musicale a cui si attribuisce un valore che nella realtà non si trova... ebbene anche quel contenitore di noccioline è una porta sul mondo vero che non si è aperta prima della morte del padre del protagonista, una sorta di bara per un sogno, un impegno totalizzante una vita. E così quell'espediente si ammanta di un'aura rituale di tristezza e di operazione di lutto, rimanendo racconto, storia da raccontare al di qua del coperchio, unica soglia apparentemente non trasparente, salvo poi trovare evidenze "trasparenti" nella fotografia di gruppo. "Sussiste oggi qualcosa del fascino incerto dei terreni incolti, delle sodaglie e degli scali, dei marciapiedi di stazione e delle sale d'attesa dove i passi si perdono, di tutti i luoghi dell'incontro fortuito dove si può provare fuggevolmente la possibilità dell'avventura [Zeta Jones], la sensazione che c'è solo da "veder cosa succede"?" (Augè, Non luoghi cit, p. 9)
 Già solo "vedere" rimanendo invisibili, cominciare a capire i meccanismi del gioco, significa comprendere dove sono i buchi nell'involucro trasparente; come fa l'inserviente indiano (che però così ritroverà la propria consapevolezza di migrante)... invece il protagonista procede nella sua lotta contro il potere ottuso e burocratico nel suo arroccamento antimigrazione in modo diverso: è sovraesposto in ogni telecamera, e questa è l'anomalia per il non luogo, disabituato all'invisibile, o meglio: suscettibile solo alle disparità, alle figure che nello specchio mantengono uno spessore non riconducibile a uno stereotipo rassicurante, perché conosciuto. Altra anomalia è che agisca fuori dalle regole e soprattutto insegni la dignità che esula sempre dalla burocrazia che la sottomette come suo primo obiettivo, quella dignità che emancipa dalle procedure, fredde insensibili e fondate sulla presunzione di autorità.
Già solo "vedere" rimanendo invisibili, cominciare a capire i meccanismi del gioco, significa comprendere dove sono i buchi nell'involucro trasparente; come fa l'inserviente indiano (che però così ritroverà la propria consapevolezza di migrante)... invece il protagonista procede nella sua lotta contro il potere ottuso e burocratico nel suo arroccamento antimigrazione in modo diverso: è sovraesposto in ogni telecamera, e questa è l'anomalia per il non luogo, disabituato all'invisibile, o meglio: suscettibile solo alle disparità, alle figure che nello specchio mantengono uno spessore non riconducibile a uno stereotipo rassicurante, perché conosciuto. Altra anomalia è che agisca fuori dalle regole e soprattutto insegni la dignità che esula sempre dalla burocrazia che la sottomette come suo primo obiettivo, quella dignità che emancipa dalle procedure, fredde insensibili e fondate sulla presunzione di autorità.  Quella autorità che preclude le frontiere, simboleggiate dalle opulente porte scorrevoli che lasciano vedere il mondo lì fuori, permettono di indovinare il modo in cui si potrebbe coronare il sogno del padre jazzofilo e il suo strano modo di ritessere la memoria, ricostruendo un'immagine, da cui scaturisce il romanzo... Addirittura dare una testa, un volto ai manichini nelle vetrine attraverso il riflesso: il massimo della provocazione: prendere possesso dei luoghi effimeri e per antonomasia impalpabili - quindi non espropriabili: vera spesa proletaria - e conferirgli il proprio gusto.
Quella autorità che preclude le frontiere, simboleggiate dalle opulente porte scorrevoli che lasciano vedere il mondo lì fuori, permettono di indovinare il modo in cui si potrebbe coronare il sogno del padre jazzofilo e il suo strano modo di ritessere la memoria, ricostruendo un'immagine, da cui scaturisce il romanzo... Addirittura dare una testa, un volto ai manichini nelle vetrine attraverso il riflesso: il massimo della provocazione: prendere possesso dei luoghi effimeri e per antonomasia impalpabili - quindi non espropriabili: vera spesa proletaria - e conferirgli il proprio gusto. che lo collocano per la nostra percezione di spettatori come in un acquario, al di là di tutte quelle superfici ingannevoli, che fanno apparire la società americana come appetibile, mentre invece può soltanto essere funzionale al compimento di un sogno lungo un giorno, in cui l'ultima firma giustapposta alla fotografia completerà quel mondo. Solo che noi, o meglio il nostro sguardo è collocato inconsapevolmente sull'altro lato della porta scorrevole.
che lo collocano per la nostra percezione di spettatori come in un acquario, al di là di tutte quelle superfici ingannevoli, che fanno apparire la società americana come appetibile, mentre invece può soltanto essere funzionale al compimento di un sogno lungo un giorno, in cui l'ultima firma giustapposta alla fotografia completerà quel mondo. Solo che noi, o meglio il nostro sguardo è collocato inconsapevolmente sull'altro lato della porta scorrevole.
 Tutto tende a diventare una tombale opacità come quella degli infiniti ascensori, avvolti da superfici che non riflettono più nulla, se non ombre opacizzate dai materiali, anche se sono metallici e quindi dovrebbero restituire una qualche immagine riflessa, ma - proprio perché lo sguardo all'esterno è vacuo e poco interessato - tutto viene catturato, assorbito, inglobato, escluso dall'"esterno", anche le ombre, anche i riflessi, tranne l'avvenente figura della ragazza, che gli specchi dietro al bancone del bar rimandano in frammenti e le vetrine ritagliano dalla strada: infatti lei diventa l'unica ancora per ritrovare il "fuori" dall'albergo ticinese. Il resto è ripreso come se nessun gioco di specchi potesse lasciar uscire l'immaginazione intrappolata nell'albergo... o nel pilastro di cemento, che sancisce l'impossibilità di varcare la soglia e dimostra il legame tra impossibilità di superare quella soglia, di liberarsi dei limiti - innanzitutto architettonici, e poi mentali - per superare l'inibizione derivante dal raccontare la morte, anticipata dallo stato di recluso e dall'invalicabilità delle superfici che allontanano il mondo sia quando, come in Sorrentino, fanno dell'opacità la distanza dall'esterno (l'altro lato del confine), sia quando come in Terminal quel limite si evidenzia nella più cristallina trasparenza, altrettanto insuperabile.
Tutto tende a diventare una tombale opacità come quella degli infiniti ascensori, avvolti da superfici che non riflettono più nulla, se non ombre opacizzate dai materiali, anche se sono metallici e quindi dovrebbero restituire una qualche immagine riflessa, ma - proprio perché lo sguardo all'esterno è vacuo e poco interessato - tutto viene catturato, assorbito, inglobato, escluso dall'"esterno", anche le ombre, anche i riflessi, tranne l'avvenente figura della ragazza, che gli specchi dietro al bancone del bar rimandano in frammenti e le vetrine ritagliano dalla strada: infatti lei diventa l'unica ancora per ritrovare il "fuori" dall'albergo ticinese. Il resto è ripreso come se nessun gioco di specchi potesse lasciar uscire l'immaginazione intrappolata nell'albergo... o nel pilastro di cemento, che sancisce l'impossibilità di varcare la soglia e dimostra il legame tra impossibilità di superare quella soglia, di liberarsi dei limiti - innanzitutto architettonici, e poi mentali - per superare l'inibizione derivante dal raccontare la morte, anticipata dallo stato di recluso e dall'invalicabilità delle superfici che allontanano il mondo sia quando, come in Sorrentino, fanno dell'opacità la distanza dall'esterno (l'altro lato del confine), sia quando come in Terminal quel limite si evidenzia nella più cristallina trasparenza, altrettanto insuperabile. Concludendo questa trilogia di vetri, si potrebbe dire che Ruiz offre un punto di vista che in parte spiega i due precedenti, accentuando il livello di indefinitezza legata a questi diaframmi diafani, mentre dall'altro li lega alla pulsione a porre al centro un personaggio che conosciamo anziano, percorre la memoria - per esaudire una nostra urgenza in questo senso - e muore, come avviene negli ultimi lavori di Tabucchi, Eco, Orengo... quasi che in punto di morte si riveda davvero la vita almeno a frammenti. Soltanto... in questo caso la sua morte è annunciata all'inizio e poi si insegue per tutto il film al di là dei tramezzi trasparenti.
Concludendo questa trilogia di vetri, si potrebbe dire che Ruiz offre un punto di vista che in parte spiega i due precedenti, accentuando il livello di indefinitezza legata a questi diaframmi diafani, mentre dall'altro li lega alla pulsione a porre al centro un personaggio che conosciamo anziano, percorre la memoria - per esaudire una nostra urgenza in questo senso - e muore, come avviene negli ultimi lavori di Tabucchi, Eco, Orengo... quasi che in punto di morte si riveda davvero la vita almeno a frammenti. Soltanto... in questo caso la sua morte è annunciata all'inizio e poi si insegue per tutto il film al di là dei tramezzi trasparenti. Colpisce a distanza di pochi giorni dall'agonia di Arafat vedere sullo schermo una situazione simile corredata dagli stessi travagli, ma soprattutto al nostro discorso interessa da un lato il fatto che il regista egiziano affronti il tema del momento della morte vissuto come occasione per fare un consuntivo utile come memoria, sollecitata da chi la raccoglie (quasi un "essere per la morte" heideggeriano, che ammanta di tragico il formalismo derridiano di Ruiz) e dall'altro sorprende per quella Porta (il titolo del film è La porta del sole): cioè l'ennesima soglia incantata che protegge gli incontri del fedayyn esiliato in Libano con la moglie rimasta nei Territori occupati.
Colpisce a distanza di pochi giorni dall'agonia di Arafat vedere sullo schermo una situazione simile corredata dagli stessi travagli, ma soprattutto al nostro discorso interessa da un lato il fatto che il regista egiziano affronti il tema del momento della morte vissuto come occasione per fare un consuntivo utile come memoria, sollecitata da chi la raccoglie (quasi un "essere per la morte" heideggeriano, che ammanta di tragico il formalismo derridiano di Ruiz) e dall'altro sorprende per quella Porta (il titolo del film è La porta del sole): cioè l'ennesima soglia incantata che protegge gli incontri del fedayyn esiliato in Libano con la moglie rimasta nei Territori occupati. 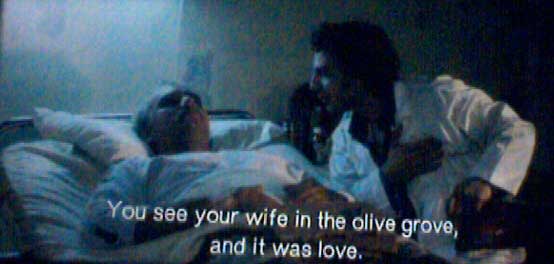

 Nahila, la sposa non ha bisogno di epici racconti in una cornice, lei è già la Palestina e lo è anche Shams, la ragazza di Khalil, uccisa per vendetta dopo che ha ammazzato un'amante che l'aveva ingannata, la cui storia evidenzia l'altro destino delle donne palestinesi: guerrigliera e, prima, moglie sottomessa a un bruto maschilista; ribelle e, poi, ancora vittima della struttura tribale, militante Olp solo dopo essersi emancipata come donna e, in quanto donna, ricacciata tra i reprobi.
Nahila, la sposa non ha bisogno di epici racconti in una cornice, lei è già la Palestina e lo è anche Shams, la ragazza di Khalil, uccisa per vendetta dopo che ha ammazzato un'amante che l'aveva ingannata, la cui storia evidenzia l'altro destino delle donne palestinesi: guerrigliera e, prima, moglie sottomessa a un bruto maschilista; ribelle e, poi, ancora vittima della struttura tribale, militante Olp solo dopo essersi emancipata come donna e, in quanto donna, ricacciata tra i reprobi.  I racconti dello "specchio" (trasformato in grotta incantata) si ritagliano una loro indipendenza dal contesto politico, che li rende possibili e che viene suggestivamente e passionalmente riproposto in un tripudio di bandiere e armi e volontà di rivolta e resistenza dal regista, il quale dimostra una capacità di giudizio assolutamente indipendente: non verrà distribuito in un Occidente impaurito dall'Altro e che ha abbracciato ciecamente la censura della storia dei crimini sionisti, non lo sarà sicuramente in Israele - uno stato razzista, integralista e terrorista - e nemmeno i fedifraghi arabi, che appoggiano la lotta palestinese senza amare i palestinesi, non lo accoglieranno nelle loro sale, eppure è un film lucidissimo sugli eventi susseguitisi dal 15 maggio 1948, forse perché fa uso di quell'infinità di soglie senza quasi mostrarle, solo alludendovi con quella luce solare di una grotta pronta a riaprirsi.
I racconti dello "specchio" (trasformato in grotta incantata) si ritagliano una loro indipendenza dal contesto politico, che li rende possibili e che viene suggestivamente e passionalmente riproposto in un tripudio di bandiere e armi e volontà di rivolta e resistenza dal regista, il quale dimostra una capacità di giudizio assolutamente indipendente: non verrà distribuito in un Occidente impaurito dall'Altro e che ha abbracciato ciecamente la censura della storia dei crimini sionisti, non lo sarà sicuramente in Israele - uno stato razzista, integralista e terrorista - e nemmeno i fedifraghi arabi, che appoggiano la lotta palestinese senza amare i palestinesi, non lo accoglieranno nelle loro sale, eppure è un film lucidissimo sugli eventi susseguitisi dal 15 maggio 1948, forse perché fa uso di quell'infinità di soglie senza quasi mostrarle, solo alludendovi con quella luce solare di una grotta pronta a riaprirsi.  Ma ora avvolta dalle tenebre per l'intervento di una figura femminile che sdoppia le fattezze di Shams, uccisa, con quelle di Nahila, scomparsa, facendo entrare in scena una fantomatica figura velata, che alle arance dell'inizio sostituisce un formaggio, talismano altrettanto utile per entrare in sintonia con la propria terra usurpata.
Ma ora avvolta dalle tenebre per l'intervento di una figura femminile che sdoppia le fattezze di Shams, uccisa, con quelle di Nahila, scomparsa, facendo entrare in scena una fantomatica figura velata, che alle arance dell'inizio sostituisce un formaggio, talismano altrettanto utile per entrare in sintonia con la propria terra usurpata.  Come sempre a tratti ironico e molto sottile, il regista cileno si diverte a contrappuntare il tema con dialoghi surreali che "giocano" con le situazioni di vita e morte, spesso semplicemente collocando in luoghi e tempi adiacenti nella diegesi situazioni distanti nel tempo (richiamate da splendidi montaggi, agganciati da parole riprese o da richiami formali, come gocce che travalicano frontiere narrative e temporali e continuano "infiltrazioni erranti") o - spesso - attraverso l'attività esplicitamente onirica, che destruttura il racconto mescolando piani temporali infiniti che vincono il momento di divisione tra vita e morte (la radio che ripete ossessiva: "lo scrittore è morto", che è sì il protagonista, ma anche l'autore stesso), tra esistenza e racconto.
Come sempre a tratti ironico e molto sottile, il regista cileno si diverte a contrappuntare il tema con dialoghi surreali che "giocano" con le situazioni di vita e morte, spesso semplicemente collocando in luoghi e tempi adiacenti nella diegesi situazioni distanti nel tempo (richiamate da splendidi montaggi, agganciati da parole riprese o da richiami formali, come gocce che travalicano frontiere narrative e temporali e continuano "infiltrazioni erranti") o - spesso - attraverso l'attività esplicitamente onirica, che destruttura il racconto mescolando piani temporali infiniti che vincono il momento di divisione tra vita e morte (la radio che ripete ossessiva: "lo scrittore è morto", che è sì il protagonista, ma anche l'autore stesso), tra esistenza e racconto.  Proprio le gocce sono utili a capire quanta parte abbia la fantasia in questo gioco di specchi surreali, che come tali fungono da passaggio tra l'aldiqua e l'aldilà: anche le gocce ne fanno parte in quanto "non arrivano da nessuna parte", cadono su una radio (forse quella dell'annuncio di morte: "I morti non sognano, questo vi dico. I defunti sognano soltanto nelle notti di pioggia. Per il resto sono sognati", dice Ermelindo Mucanga, un morto che sta Sotto l'albero del Frangipani di Mia Couto), riapparendo in un cortile di un altro tempo, ma rimanendo al centro della conversazione: sembra che continuino un discorso, ma in realtà fanno parte dell'alea che ammanta il romanzo che si va dipanando al di là dei vetri.
Proprio le gocce sono utili a capire quanta parte abbia la fantasia in questo gioco di specchi surreali, che come tali fungono da passaggio tra l'aldiqua e l'aldilà: anche le gocce ne fanno parte in quanto "non arrivano da nessuna parte", cadono su una radio (forse quella dell'annuncio di morte: "I morti non sognano, questo vi dico. I defunti sognano soltanto nelle notti di pioggia. Per il resto sono sognati", dice Ermelindo Mucanga, un morto che sta Sotto l'albero del Frangipani di Mia Couto), riapparendo in un cortile di un altro tempo, ma rimanendo al centro della conversazione: sembra che continuino un discorso, ma in realtà fanno parte dell'alea che ammanta il romanzo che si va dipanando al di là dei vetri. 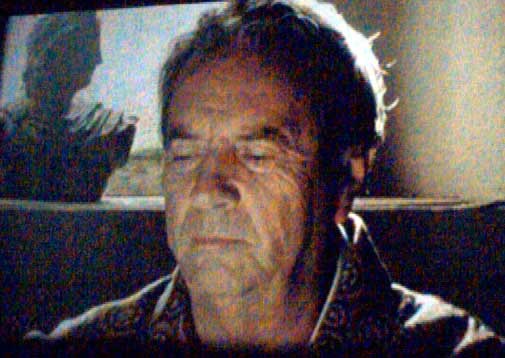 Laddove la scienza non può arrivare, subentra il romanzo, il palliativo del riflesso illuminante, il succedaneo del vetro che ci invita al di là... che però non riesce a formarsi, rimanendo evocato al di qua dei vetri, riflesso da specchi infiniti, mediato da superfici che si frappongono a dividere senza per questo essere diaframmi definitivi, come se la Recherche non possa mai concludersi, perché il romanzo può vedere dall'altra parte, può anche descrivere il mondo dall'altro lato dello specchio, ma non lo può abitare, ottenendo di poter solo far percepire la sensazione di quella soglia, senza mai nasconderla definitvamente o consentirne il disvelamento, appunto quel
Laddove la scienza non può arrivare, subentra il romanzo, il palliativo del riflesso illuminante, il succedaneo del vetro che ci invita al di là... che però non riesce a formarsi, rimanendo evocato al di qua dei vetri, riflesso da specchi infiniti, mediato da superfici che si frappongono a dividere senza per questo essere diaframmi definitivi, come se la Recherche non possa mai concludersi, perché il romanzo può vedere dall'altra parte, può anche descrivere il mondo dall'altro lato dello specchio, ma non lo può abitare, ottenendo di poter solo far percepire la sensazione di quella soglia, senza mai nasconderla definitvamente o consentirne il disvelamento, appunto quel 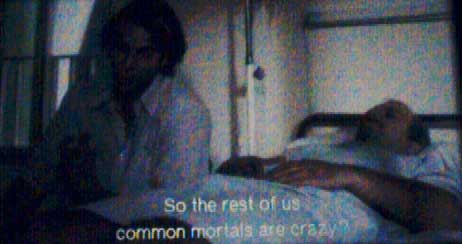 "Mi pare che ci sia ancora il moscone, lo faccia uscire, non voglio che mi si posi sulla bocca quando l'avrò chiusa. Quando scriverà questa storia, se ne farà un libro, sul libro ci metta il suo nome, il mio non ce lo voglio, non voglio esser quello che racconta, voglio essere raccontato... Lei una volta ha scritto che Tristano conobbe la paura e io l'ho confermato. Ma la vera paura è un'altra, quella era una paura da poco, perché aveva il privlegio dell'aleatorio, poteva andargli male, ma poteva anche cavarci le gambe... La vera paura è quando l'ora è fissata e sai che sarà inevitabile... è una strana paura, insolita, si prova una volta sola nella vita, e non si proverà mai più, è come una vertigine, come se si spalancasse una finestra sul niente, e lì il pensiero si annega davvero, come se si annientasse. È questa la vera paura... Fra poco, quando non sentirà più il mio respiro, spalanchi quella finestra, lasci entrare la luce e i rumori del mondo vivo, appartengono a lei, il silenzio è mio. E vada subito via,chiuda la porta e lasci qui il cadavere, quello non sono io, ho già dato disposizioni alla Frau per sbarazzarsene in fretta... C'è un amore religioso della morte che ha qualcosa di necrofilo, quasi che si amasse di più un cadavere di un vivo... Una bella morte... che sciocchezza, la morte non è mai bella, la morte è laida, sempre, è la negazione della vita... Dicono che la morte è un mistero, ma il fatto di essere esistito è un mistero maggiore, apparentemente è banale, e invece è così misterioso... Sa, per esempio il fatto che lei e io ci troviamo qui, nella stessa stanza, in questo preciso momento, è molto misterioso, o comunque abbastanza singolare, non le pare?... La ringrazio... "
"Mi pare che ci sia ancora il moscone, lo faccia uscire, non voglio che mi si posi sulla bocca quando l'avrò chiusa. Quando scriverà questa storia, se ne farà un libro, sul libro ci metta il suo nome, il mio non ce lo voglio, non voglio esser quello che racconta, voglio essere raccontato... Lei una volta ha scritto che Tristano conobbe la paura e io l'ho confermato. Ma la vera paura è un'altra, quella era una paura da poco, perché aveva il privlegio dell'aleatorio, poteva andargli male, ma poteva anche cavarci le gambe... La vera paura è quando l'ora è fissata e sai che sarà inevitabile... è una strana paura, insolita, si prova una volta sola nella vita, e non si proverà mai più, è come una vertigine, come se si spalancasse una finestra sul niente, e lì il pensiero si annega davvero, come se si annientasse. È questa la vera paura... Fra poco, quando non sentirà più il mio respiro, spalanchi quella finestra, lasci entrare la luce e i rumori del mondo vivo, appartengono a lei, il silenzio è mio. E vada subito via,chiuda la porta e lasci qui il cadavere, quello non sono io, ho già dato disposizioni alla Frau per sbarazzarsene in fretta... C'è un amore religioso della morte che ha qualcosa di necrofilo, quasi che si amasse di più un cadavere di un vivo... Una bella morte... che sciocchezza, la morte non è mai bella, la morte è laida, sempre, è la negazione della vita... Dicono che la morte è un mistero, ma il fatto di essere esistito è un mistero maggiore, apparentemente è banale, e invece è così misterioso... Sa, per esempio il fatto che lei e io ci troviamo qui, nella stessa stanza, in questo preciso momento, è molto misterioso, o comunque abbastanza singolare, non le pare?... La ringrazio... "