Straordinariamente poetico l’ultimo film del regista argentino
Alejandro Agresti, che si intitola Valentin, come il nome del suo piccolo
protagonista, ed è proprio il suo punto di vista a rendere lirico l’universo
ricreato: la voce fuori campo del bambino guida e conduce l’intera narrazione e va
oltre la durata del film. Inoltre la scelta di affidare a questo codice linguistico il
racconto e il commento delle immagini finisce con il filmare queste ultime attraverso il
medesimo punto d’osservazione, assolutamente e ingenuamente infantile. La bellezza
stilistica del film consiste allora nel fatto che l’adulto, spettatore, finisce per
aderire facilmente a questo processo di immedesimazione: egli pensa, guarda e ragiona, per
un’ora e venti, secondo il punto di vista del bambino. Nel mio caso, poi,
l’identificazione è ancora più naturale e immediata, visto che i riferimenti
epocali a cui fa allusione (gli anni sessanta) sono gli stessi della mia infanzia - anno
più, anno meno – e la comparsa di alcuni oggetti, come il magnetofono, le magliette
a righe, la tv in b/n con le valvole che saltano, la Seicento, sortisce lo stesso effetto
di una madeleine … Per non parlare dei giochini mostrati: fare la conta fino a mille,
prima che un evento desiderato possa verificarsi (ad esempio che il campanello suoni) e
poi proseguire il conteggio (o il countdown?), nel caso in cui non accada; le fantasie
spaziali di fronte alle prime immagini dello sbarco sulla Luna: una nottata del 1969
trascorsa incollata davanti alla TV, una delle poche alzata dopo Carosello, per incantarmi
a sognare, seguendo i passi impacciati di Armstrong, che sembrava un omino della Michelin
dentro a quella buffa tuta da astronauta [e non a caso è proprio lì, il 21 luglio del
1969, che termina il film, l’infanzia di Valentin e la sua adozione da parte della
coppia da lui appositamente creata].
Valentin è un bravo scrittore della vita: ne inventa gli intrecci, non solo falsificando
il contenuto dei temi scolastici (immaginando una famiglia che non ha), ma prefigurandoli
e in certi casi commentandoli in anticipo (il ricorso al medico per l’imminente
malattia della nonna), per spiegare che sono andati all’incirca come li aveva
pensati, a parte qualche lieve differenza o aggiustamento imprevisto. Valentin è
soprattutto l’alter ego del regista, nato proprio nel 1961, che gli affida la storia
della sua infanzia, pur riservando per sé, nella fiction, il ruolo recitato dal padre.
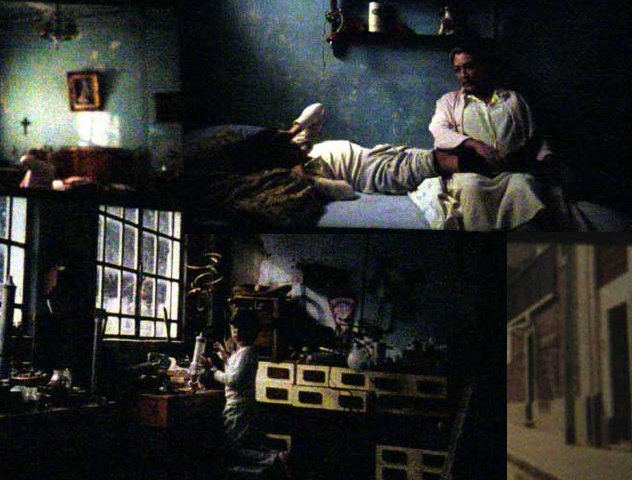
"Ciao, mi chiamo Valentin e ho otto anni. Costruisco cose da
astronauti, non ho soldi per andare nello spazio, ma mi esercito comunque per raggiungere
la Luna …": la sua vocetta squillante e vivace (sarebbe stato bello fruire il
film in originale, anche se per una volta il doppiaggio è fatto bene e il bambino che dà
voce italiana al protagonista sembra aderire, non solo verbalmente, ma anche
epidermicamente all’interpretazione di Roderigo Noya) dà il benvenuto allo
spettatore, lo fa entrare nella sua casa di Buenos Aires, lo accompagna in camera, gli fa
perlustrare ogni genere di cianfrusaglia raccolta in soffitta, lo costringe a restare per
trenta secondi in apnea dentro la vasca da bagno (bisogna infatti tenersi in allenamento
per poter andare nello spazio!), quindi lo prende per mano per portarlo a incontrare la
nonna, con cui abita, anch’essa abile nel raccontare le storie. Una nonna
magistralmente interpretata da Carmen Maura, invecchiata precocemente per ragioni di
copione, ma sempre immortalata come se si trovasse al "bordo di un attacco di
nervi" (fedele al ruolo che le aveva assegnato Almodovar), quando preconizza
un’umanità fatta di individui fuori di testa, malati psicologicamente, a differenza
dell’unica persona da lei amata, quel nonno, morto di diabete, splendido ballerino di
tango, i cui occhi verdi l’avevano incantata fin dalla prima volta che si erano
incontrati.
Valentin trascorre la sua infanzia a mugugnare e a sognare con la nonna; la mamma se ne è
andata improvvisamente e non ha più voluto rivederlo; il papà pensa solo al lavoro e
alle nuove fidanzate, molte delle quali, una volta conosciute, è meglio scordare per la
loro invadenza; uno zio arriva da Ushuaia con le voci della famiglia incise su un
magnetofono: sonorità irreali, quasi fantascientifiche, come quelle registrate per
tentare amicizie con gli alieni (al contrario di Happy together di Wong Kar Wai,
dove si effettuava il percorso a ritroso per liberarsi del pianto registrato).
Il bambino cerca consolazione nelle sue passeggiate spaziali fuori casa, calzando scarpe
che possano abituarlo all’idea della mancanza di gravità, che fanno incuriosire il
vicino, un certo Rufo, pianista da strapazzo, considerato "balordo e ubriacone"
dalla nonna. Tra i due scatta un’affinità elettiva, mediata non solo dal comune
sentire la musica abitare dentro e sgorgare fuori (compresa quella pop, che il padre
detesta, eppure il bambino ascolta, travestendosi da astronauta in una sequenza ritmata
alla stregua di un videoclip), ma dal porre interrogativi all’altro da sé, destinati
a restare in sospeso: "È una cosa buona essere ebrei?", "Ma perché gli
uomini sono più romantici delle donne?".
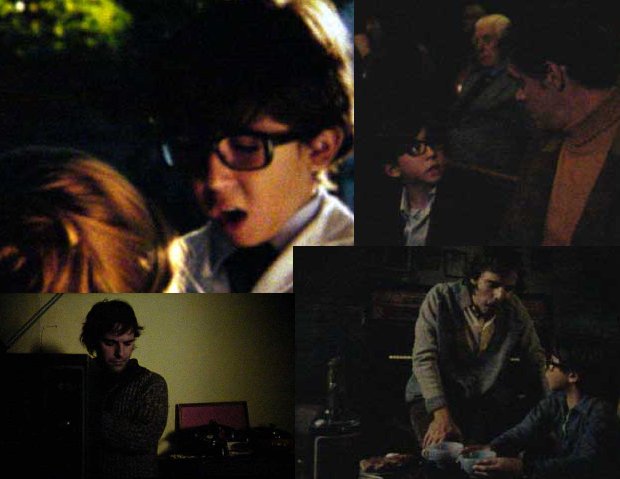
E allora tutto il film sembra confermare un grande assunto, che stava
anche al centro del Gianburrasca di Vamba, "Per i grandi è impossibile non
dire bugie!", mentre per i Valentin è naturale inseguire i propri istinti, dire le
cose pane al pane, non per condannare gli adulti alle loro ipocrisie, ma per morderne la
voglia di evasione in un immaginario, che risulta essere terreno adatto per essere
perlustrato soltanto da uno sguardo bambino, orfano e un po’ strabico, e forse per
questo legittimato a sondare una crosta, terrestre e lunare, dove la sincerità conduce
alle stesse mete dei grandi, ma seguendo orme diverse e dai percorsi originali.
"C’è gente che non sembra viva o che comunque non se ne fa niente della
vita", conclude amaramente il bambino, riferendo questa sua elucubrazione sia ai
compagni, che hanno la fortuna di avere delle madri che vanno a recuperarli
all’uscita di scuola, anche se non sanno poi conversare tra loro, sia agli adulti
persi nelle loro occupazioni quotidiane: leggono il giornale, bevono il caffè, ma per il
resto non sanno alzare la testa.
"Nel frattempo la mamma se n’è andata, forse anche lei fuori di testa, come
dice la nonna, il papà si è innamorato per l’ennesima volta di una certa Letizia,
che è la fine del mondo (la sua più bella fidanzata) e anche il Che ci ha abbandonati in
"un mondo dove tutto è, purtroppo, uguale a prima!". E poi se è vero che il
nonno sta bene dove è, in paradiso, perché non è morto prima?. Lo zio ha un bel dire
che si muore quando è ora e che chi si suicida, non va in paradiso…, ma io non ne
sono poi così convinto". Mi accorgo che l’effetto ipnotico della voce off del
bambino prosegue incredibilmente anche al termine del film e ha il sopravvento sui
tentativi di estraniarsi: si appropria della recensione e la contamina nel raccontarne gli
eventi.
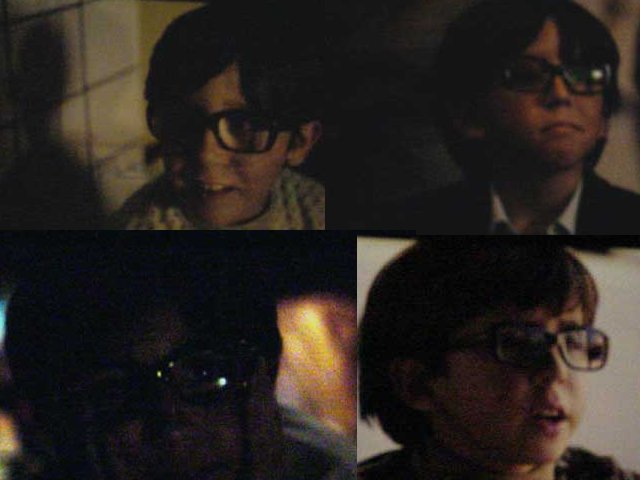
In balia del suo narrare, resta infine intrappolato lo sguardo di
Valentin, spesso inquadrato in grandangolo e in tralice rispetto agli occhiali che
indossa: enormi per un visino minuto, dalla montatura seriosa da adulto ("Ma si sa
che loro vogliono sentirsi dire cose da grandi, per questo invento allo zio la storia che
mi sono innamorato di una bambina della mia classe!"), attraverso i quali anche gli
oggetti esterni sembrano diventare enormi e smisurati come il suo immaginario, al punto
che, quando Rufo tenta di inforcarli, subito glieli restituisce, affermando che si tratta
di un’esperienza psichedelica. Solo poche volte Valentin viene inquadrato senza
occhiali, per sottolineare il suo strabismo sul mondo che lo circonda: una volta per
guardarsi allo specchio e poi conversare da grande con lo zio, un’altra per
consumare, a modo suo, il lutto per la morte della nonna, di cui ha percepito la
dipartita, fingendo di dormire. Un’altra volta ancora se li toglie, si stropiccia gli
occhi come per allontanare un fastidio, ma poi inaugura felicemente un’altra storia,
per inventarsi quella famiglia che non ha, a cui avrebbe diritto…
La storia dell’infanzia di Valentin e di Agresti si interrompe con un lieto fine
magicamente strabico rispetto alla realtà da venire, soprattutto in Argentina: gli anni
settanta, la dittatura, la desaparicion, i girotondi delle madri, stavolta davvero
protagoniste, in Plaza de Majo. Ma quel che successe dopo, il regista ce l’aveva già
raccontato, alla sua maniera, nei film precedenti, primo fra tutti Buenos Aires
viceversa, che ebbi il piacere di vedere, anni fa, proprio in una sala porteña. Lì
era un ragazzino a rubare una telecamera per filmare una realtà altrimenti destinata
all’oblio: in quel caso non c’era un lieto fine, il giovane soccombeva, ucciso
da una guardia giurata, dopo aver documentato ogni angolo più recondito di una Buenos
Aires successiva al "proceso militar". Purtroppo aveva già smarrito gli
occhiali e non c’era più un ottico speciale in grado di procurarglieli (come cantava
De André) e comunque l’effetto psichedelico sperimentato da Rufo, indossandoli, si
era esaurito!

