Torino Film Festival 2008
|
tre passi tra le guerre
3. Rata neće biti (non ci sarà la guerra)
elaborare il lutto di una nazione attraverso gli occhi dei testimoni irreconciliabili
|
|

"In quei luoghi, il tempo della guerra pesa ancora in modo determinante sul presente, sulla questione politica, sulle psicologie individuali e sulle relazioni umane. E' un passato tragico che incombe su un presente dove l'oggi non c'è ancora. La sensazione di attraversare un tempo sospeso mi ha guidato nel realizzare il documentario e in qualche modo ha dato forma alla sua struttura, alla sequenza dei capitoli in cui personaggi e racconto si prendono il proprio tempo, cercando forse di rompere quel limbo che li imprigiona"
(Daniele Gaglianone, Catalogo del 26° Torino Film Festival, pag. 149).
Davvero è un limbo caleidoscopico l'affresco che Daniele Gaglianone offre - in tre ore - allo spettatore: una serie di incontri e di viaggi in quella regione geografica che gli atlanti registravano come Jugoslavia, con dentro uno stato federale di nome Bosnia-Erzegovina - una federazione che è bastato poco perché sparisse e sembri ora che pochi abbiano ancora voglia di ricordare che ci credevano: quei pochi proprio a Sarajevo, città simbolo della tolleranza multietnica e convivenza religiosa. Un film dove nessuno è escluso, perché lo shock della guerra non si può dimenticare, o obliare a ogni buon conto! C'è chi sta dalla parte serba, chi difende l'identità slava, chi recita la parte del croato reazionario, chi invece è partigiano di quella che fu l'Armija bosniaca, chi racconta i lasciti dei soldati Onu, anche graffitati a memoria dei posteri sulle pareti di un edificio, chi cerca di mettere insieme i resti di cadaveri scovati in fosse comuni (come quella storica di Katyn filmata da Wayda), intanto a Srebrenica si provano le danze per uno spettacolo, dove la guerra sembra essere davvero lontana o da scordare soltanto durante un ballo...

"La guerra è un problema che abbiamo tutti dentro di noi", dice Zoran e sembra di tornare ai fumetti che spediva via rete il suo omonimo da una Belgrado bombardata, eppure il fluire tranquillo del film non ricostruisce eventi, ma ragioni e patimenti di singole persone che parlano davanti a una telecamera che a lungo andare, vista l'assenza di interventi e la scelta di lasciare anche i commenti - altrove si direbbero fuoricampo - e non solo le dichiarazioni pregnanti, i racconti atroci, quella telecamera diventa parte del flusso, inavvertita anche quando il particolare degli occhi diventa figura a tuttotondo, quando ormai il personaggio intervistato è diventato persona, spesso dolente, sempre rammemorante. E quello che si delinea sullo schermo non sono immagini o sonori di repertorio, ma dolenza per gli strascichi lasciati dalla guerra, mai - in nessuno dei casi - positivi rispetto al prima (e per tutti lo scorrere del tempo si conteggia attraverso il parametro tra prima e dopo la guerra).
L'uso dell'inquadratura che incalza il narrante per tutto il tempo in un quasi piano sequenza (dove non si tagliano riferimenti all'esterno dell'inquadratura) rischierebbe la retorica che per esempio caratterizza i lavori di Daniele Segre; invece le variazioni di taglio, l'importanza dei dettagli (che si cerca di mantenere nella struttura delle singole "interviste") per introdurre il personaggio, allargando poi a tutto il volto e al suo mondo, diventano narrazione da cui si trae non solo la Storia, per cui diventa fondamentale il suo apporto, ma soprattutto quello che ha provato e prova lui - e quelli che lui rappresenta hanno provato allo stesso modo - emerge dal suo sguardo, dalle sue pause, dai suoi sgomenti e amarezze.

I racconti di Rata neće biti (non ci sarà la guerra) si fanno dal "basso", con testimoni in carne e ossa, scelti per rappresentare le diverse anime di questa nazione unica (vissuta da croati, sloveni e secessionisti vari come "Prigione dei popoli"), segmentata vieppiù in tante etnie, differenti a loro volta "prigioni dei popoli" e delle nazionalità, che non possono comunicare tra loro, non per colpa di muri appositamente costruiti per dividere (si veda al proposito il muro che è costante in Lemon Tree e che qui sembra presente nelle menti), ma a causa di incomprensioni coriacee, rese ancora più tenaci da quel fervore belligerante. Forse per combattere questo Gaglianone mette in scena in quasi ogni singolo episodio umano almeno un mezzo di trasporto che consente di mettere in comunicazione e superare i muri della distanza: i tram dietro all'infermiere sconvolto da quello che ha visto; la barca solitaria (uno stato molto simbolico) in mezzo al lago quando si pronunciano frasi terribili di chi non potrà perdonare l'ex amico diventato attivo nel perseguitare la sua etnia musulmana; l'autobus che trasporta nel finale la ragazza che vive in un'enclave estranea e accoglie amiche che scoprono che l'Altro non è un mostro. Ecco, quest'ultimo episodio di speranza, per la sua collocazione nel dipanarsi del film - e per il fatto che non a caso offre lo spunto per il titolo del film - è significativo, quanto il fatto che Zoran, il primo intervistato spigliato, si dichiara "apolide".
Inoltre questi mezzi di comunicazione sono sempre in movimento e questo in omaggio a una situazione fluida, mai definitiva... non si tratta solo del road movie (che attraverso la voce off radiofonica irradia nel veicolo in movimento le voci che arringavano, o esclamavano, o inneggiavano... all'apocalisse) di Daniele alla ricerca di testimonianze significative che ricostruiscano i massacri, ma anche alla ricerca di tracce della storia transitata da quelle parti.
La guerra sembra apparentemente conclusa, ma cova ancora sotto la neve, la si respira nel vento gelido dell'inverno, regna sovrana anche durante la traiettoria di uno slittino di un bambino di Sarajevo che finirà di qui o di là in quella fiumana di federazioni?
Nessuno ci voleva credere a quella guerra e poi... dopo il suo accadere, tutti si trovano a farci i conti o a contare i defunti registrati casa per casa.

E' l'inverno del 2007, in prossimità del Capodanno, quando il regista si reca sui luoghi delle riprese alla ricerca di testimoni eccellenti: c'è Zoran, pittore e disegnatore vissuto a Milano e poi ritornato a Sarajevo, che racconta la sua infanzia. La macchina da presa lo segue di spalle, mentre entra nella taverna e gli avventori si stupiscono che sia l'attore principale di un film che finirà per coinvolgere anche loro. Tra un boccale di birra e l'altro, Zoran ha il tempo di illustrare in che cosa consista la nostalgia per l'epoca capeggiata da Tito, diventato ormai l'effigie dei calendari venduti sul corso principale della città: "Allora c'era dignità nei confronti dell'essere umano, pur con i limiti propri di qualsiasi dittatura. Adesso viviamo in una prigione dei popoli!". Ogni etnia divisa a metà, tra il prima e dopo l'accadere dell'evento bellico, che ha catapultato ognuno in una sorta di dimensione parallela. Zoran mantiene l'ironia del suo esistere in maniera naif, si è abituato a convivere con la morte e le occasioni mancate (soprattutto per gli amici desiderosi di farsi baciare dalle ragazzine poi destinate a morti assurde per granate gettate sul mercato, lo stesso in cui avrebbero dovuto esserci anche loro sopravissuti per caso), gli anni della guerra hanno finito per migliorarlo, abituandolo a vivere "a bruciapelo", indifferente al contesto che però brucia ancora sotto la cenere. Vorrebbe abitare un'identità collettiva, ma si è ormai rassegnato a convivere con questa babele nazionalista, che non concede sospensioni alla memoria di come si viveva meglio prima di tracciare linee di demarcazione.
Ma in particolare il film riesce a far capire precisamente come sia possibile che il vicino (come in un vecchio film di Norman McLaren) si trasformi in persecutore - e non si possa riprendere una buona amicizia; oppure il fratello si sia trovato casualmente intrappolato qualche chilometro fuori Sarajevo e quindi abbia sparato sul fratello, rimasto da quest'altra parte - e, a "guerra conclusa" (qualora una guerra si possa decretare ccome terminata in tempi brevi), abbiano potuto riprendere a vivere in concordia. Nulla cancellava l'amicizia dei fratelli, se non il destino; lo stesso destino che invece impone a due persone divise dall'appartenenza etnica differente a non poter essere amici fraterni come prima.

Voci off affidate a trasmissioni radiofoniche del 1989, quando al microfono si avvicendavano discorsi inneggianti alla supremazia del partito comunista serbo, seguite da ovazioni della folla, introducono il secondo testimone: Sasa, 28 anni, ex professore di storia e di latino, ora impiegato presso la reception di un hotel cittadino, nato a Sarajevo e rimasto a viverci con la nonna e la madre, gli altri familiari transfughi nella parte serba, la SRPSKA. Egli vive di là, ma si sente discriminato e preferisce non avere contatti con il resto della popolazione bosniaca. La mdp si sofferma a registrare soltanto il movimento dei suoi occhi, non potendo registrare i suoi parchi spostamenti nella città: gli occhi nervosi sembrano inseguire soltanto un nazionalismo disperatamente difeso, tranne scivolare sulla sua bocca quando gli capita di rimproverare la madre di far rumore, proprio mentre lo stanno riprendendo: "Così facciamo brutta figura!". Ma qual è la figura che esce da Srebrenica e dalla strage ivi consumata? La Federazione Croata-Musulmana non può far altro che legittimare l'accaduto: "Così è stato".
Quelle voci off del passato si mescolano nel film con il futuro, perché è sospeso un presente impossibile, così segmentato, carico di rancore... e anche perché presso alcuni (in particolare di etnia serba) comincia a serpeggiare la nostalgia del periodo prebellico.
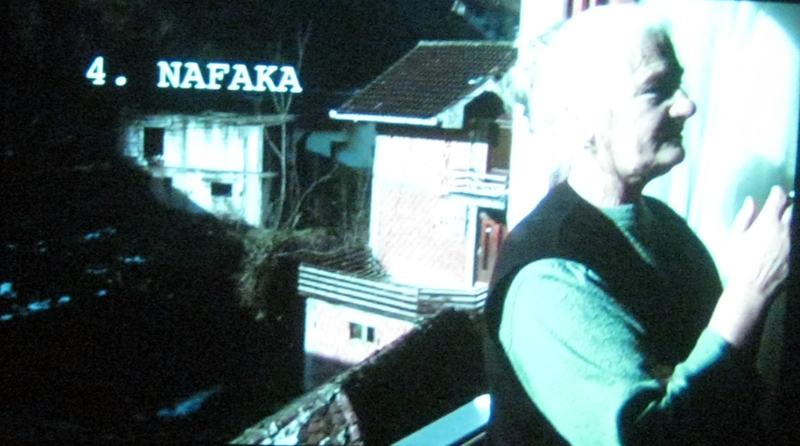
Altri testimoni si avvicendano, ripresi per strada, in mezzo al traffico della città, spesso di spalle, per seguirli dapprima da dietro e poi avvicinarsi man mano al vero sentire delle loro storie. Chi abitava nei pressi, poi si è trovato senza casa e senza lavoro, finito per caso nel cuore di un evento, senza immaginarne la potenza e la forza destabilizzante. Persone invecchiate in una sola notte, perché costrette a vivere troppo in fretta quello che altri sperimentano nel corso di un'intera esistenza! E le ferite fanno ancora male e faticano a rimarginarsi.
E' vero che stando qui sperimenti anche quello che vuol dire nafaka: povero, non sai come sbarcare il lunario, ma da qualche parte ti arriva qualcosa. A noi è arrivato almeno Gaglianone a fare nafaka, regalandoci il regalo di una spiegazione per un insensato massacro fratricida, e gliene siamo grati, ma lì come si fa?
La vecchia che continua ad abitare a Srebrenica, dopo aver visto i suoi cari assurdamente morire e le case sbriciolarsi, fuma arditamente una sigaretta dopo l'altra, dopo aver inalato anche quelle realizzate con le foglie di noci. "La politica ha fatto litigare il popolo", commenta amaramente; lei è musulmana e prima riusciva a convivere con gli altri abitanti del borgo, adesso non si fida più di nessuno. Ci tiene a rimarcare il suo non essere nazionalista, a dispetto del livore che cova nei confronti dei vicini di casa.
Apre lo scrigno delle fotografie e si perde dietro al ricordo di altri tempi, mentre immagini di repertorio, tratte dagli archivi istituzionali, repertoriano esuli, migranti, donne in marcia con pochi bagagli appresso.
Già perché le case degli esuli e degli sfollati, sono state demolite e poi ricostruite.
Un'altra donna fa da Virgilio della situazione: inquadrata sempre di spalle, elenca casa per casa il numero e l'identità di chi manca: "Qui c'è solo la madre senza figli! Qui è rimasto solo il figlio di mio fratello! Qui c'è solo il marito! Ogni casa ha avuto i suoi morti". Anche nella sua manca infatti Nino, il figlio radiomatore, di cui non ha avuto più notizie dopo il 1997.

Invece nel sesto capitolo del documentario, intitolato non a caso Sex bar, troviamo i graffiti che i soldati occupanti hanno tracciato sui muri delle casematte che li ospitavano: una serie di epiteti offensivi non solo visivamente, ma verbalmente ("Le ragazze bosniache profumano come il mio buco del culo: odore di merda!", alternato a disegni di tette, bocche con i baffi e altri idioti fumetti, degni di menti malate).
Durante le riprese, c'è anche il tempo per sostare con il guardiaparchi Aziz sulla Drina, l'acqua madre, il lago che dà anima a tutta quella zona geografica un tempo chiamata Bosnia-Erzegovina: le persone morte in quella guerra che - non doveva accadere e che sembra non sia mai accaduta per le acque di quel lago - non ci sono più, ma la vita va avanti, i vincitori non si sono visti, ma dei vinti resta sempre vivo il ricordo, anche quando risulta difficile ricomporne le membra

L'ultima parte del documentario si sofferma infatti a illustrare l'egregia impresa compiuta dal centro internazionale che si occupa delle persone scomparse, Into The Shelter: mucchi di ossa, relitti umani siglati e repertoriati per essere a loro volta identificabili dai sopravvissuti alla strage di Srebrenica, analisi del dna, vestiti e altri oggetti analizzati dai familiari: un cronicario vivente, una costante diagnosi dell'orrore avvenuto...
Le ultime immagini dei 170' minuti del tour de force in quella ex Jugoslavia lasciano per fortuna spazio ai piedi: in movimento, in danza, sarabanda, fuga dalle prigioni; piedi dinamici che ballano sperando di evadere da quei resti che ancora desiderano di essere ricomposti, riconosciuti, rimessi all'interno di uno scheletro, un'ossatura, molto fragile e ancora troppo frantumata al suo interno.
Lo stile di Daniele Gaglianone, coerente con le sue produzioni precedenti, diventa ancora più rigoroso e matura quella sua maniera di restare fedele al suo stile, lasciando respiro ai suoi personaggi: diventa esaustivo il suo lavoro sul conflitto bosniaco proprio perché non prevarica i suoi personaggi, ma lascia che ognuno dica le sue ragioni e ciascuno, non pressato o talgiato in montaggio, lo fa... forse questo è stato apprezzato dalla giuria che lo ha premiato.
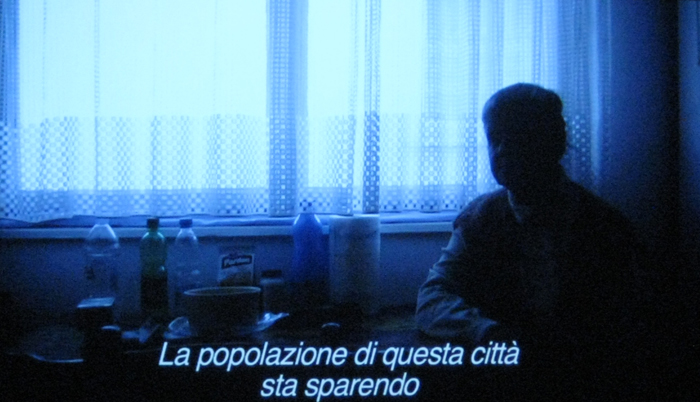
continua...
a cura di
paola tarino
adriano boano
|

